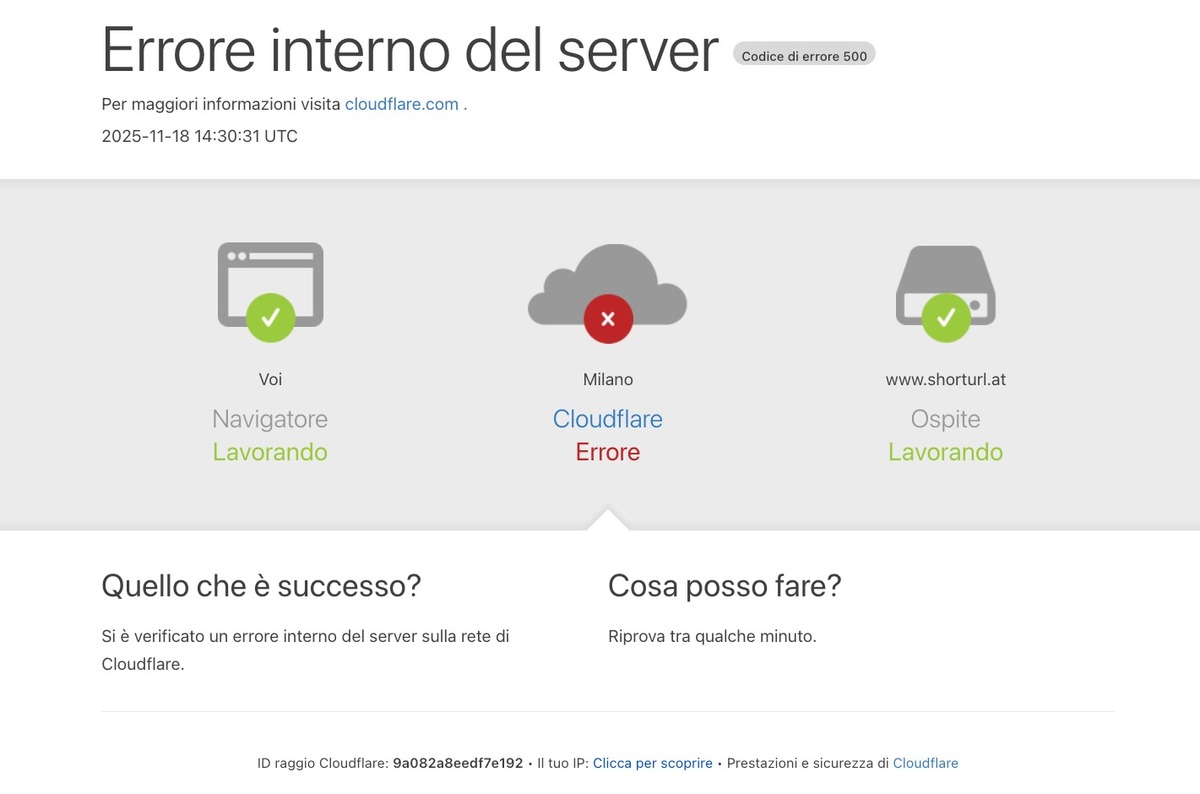Non sono io a essere vintage, è il capitalismo che ha lo schermo troppo grande


Conosco un intellettuale che ha un Nokia di quelli di quando eravamo giovani. È un segnale importante, di grande distacco rispetto alle cose del mondo: noi qui che ci disperiamo se cambiamo telefono dopo esserci persi un backup – mezza giornata di messaggi sparita, santo cielo, come faranno i filologi senza l’archiviazione di ogni nostro sospiro – e lui che ha quei telefoni che una volta ci sembravano normali, quelli in cui ci stavano dieci sms e per riceverne di nuovi dovevi cancellare i vecchi.
Ne ho comprato uno simile tre o quattr’anni fa. Mi avevano rubato il BlackBerry, non sapevo che l’avessero ritrovato perché la polizia mi chiamava al numero che non avevo, non avendo un telefono; il BlackBerry non lo producevano già più e Google, alla ricerca “telefono con tastiera”, mi diede un Nokia somigliantissimo a quelli delle nostre giovinezze.
Con in più il wifi, quindi con WhatsApp, ma con un altro dei limiti che allora ci sembravano normali e ora insopportabili: la tastiera era sì fisica ma non estesa. Per digitare la A dovevi premere il tasto una volta, poi fare una pausa delle giuste frazioni di secondo che permettessero al telefono di capire che non stavi continuando a premere per cambiare lettera, ma che ora stavi per dargli la seconda lettera, e a quel punto digitando tre volte lo stesso tasto ottenevi una C. Probabilmente in qualche settimana la mia muscolatura si sarebbe riabituata ai tempi di vent’anni prima, avrei saputo esattamente con che ritmo premere i tasti, ma in quei due giorni mi risultava sfinente: sembrava di guardare un concorrente stolido alla “Ruota della fortuna”.
Nei due giorni in cui ho usato quell’attrezzo, ho mandato solo vocali. Quando l’anno scorso un intervistatore mi ha fatto dire che odiavo i messaggi vocali, mi è sembrato di rinnegare la mia natura più profonda. Per fortuna le interviste non le legge nessuno, e quelli che le leggono spero non pensino che gli intervistati han detto davvero le robe riportate.
«La rivista per consumatori Which dice che è dal 2022 che non recensisce un telefono con uno schermo più piccolo di quindici centimetri. Un suo sondaggio su un campione di mille lettori suggerisce che la mia frustrazione faccia sì di me una minoranza, ma non insignificante: il 33 per cento che si lamenta che in generale gli smartphone siano troppo grandi, mentre il 19 trova troppo grande il proprio telefono». Sarah O’Connor scrive sul Financial Times che vorrebbe un telefono più piccolo, che stesse comodo in una mano o nella tasca d’un paio di jeans da femmina, ma i telefoni piccoli non esistono più (tranne quelli dell’intellettuale e mio, mio per due giorni quattr’anni fa ma ancora me li ricordo).
Persino i BlackBerry, di cui ho la casa piena perché metti che me lo rubino di nuovo ho razziato tutti quelli che trovavo nei negozi dell’usato, persino loro prima di morire si erano ingranditi, e gli ultimi modelli prodotti che stanno nei cassetti di casa mia non somigliano a quello che uso: se domani il mio si rompe, mi tocca usarne uno grande il doppio. «Perché il capitalismo non ci dà ciò che vogliamo?», si domanda O’Connor a nome della nicchia di consumatori che vorrebbero telefoni piccoli e che il mercato non soddisfa.
È una domanda che mi faccio continuamente, quella sul capitalismo che non asseconda noialtri consumisti. Scrivo quest’articolo da un albergo che, rispetto a quando ci venivo trent’anni fa, ha fatto molte ristrutturazioni ben sapendo che nessuno più vuol stare senz’aria condizionata, ma non ha pensato che di fianco al letto ci volessero due prese: per mettere in carica il telefono ho dovuto staccare la spina dell’abat-jour. La frequenza con cui accade, negli alberghi, è disperante. Com’è possibile che il capitalismo non sappia rispondere a un bisogno così ovvio?
Quello di telefoni piccini è meno ovvio, meno evidente, ed è colpa vostra, dice Sarah. Di quelli di cui scrivevo (questo lo aggiungo io) un paio di settimane fa: quelli che vogliono i letti coi sensori elettronici e Alexa che gli metta la musica. «I telefoni sono diventati le cartine stradali delle persone, e i loro computer, le loro macchine fotografiche, i loro televisori. Molte di queste attività sono meglio su uno schermo più grande».
Conosco un’altra tizia con un Nokia: ha sempre dietro anche un iPad, col quale fa tutto quel che i telefoni anni Novanta non consentono ed evita di sentirsi, come l’intellettuale, speciale perché non le puoi mandare un link; glielo mandi, e lei lo apre dall’iPad, che si porta sempre dietro tanto è femmina e ha sempre una borsa.
Immagino che anche a lei, come a me, la gente chieda «ma hai un iPad, come fanno a comunicare lui e il telefono?». Lui, perché ormai hanno tutti diritto a essere umanizzati. La settimana scorsa Janice Turner ha scritto sul Times che al parco un tizio le ha fatto un cazziatone perché gli aveva detto di mettere il guinzaglio al cane, ma l’aveva fatto usando per il cane «it», il pronome che si usa per gli animali e le cose, e non quello per le persone.
Se non si può osare pensare che un cane sia «esso» figuriamoci se ci si può azzardare a non umanizzare il telefono. È quindi giusto e sensato che l’umanità fessa, cioè voi tutti, dopo aver deciso di trattare i bambini come adulti e i cani come bambini, ora si preoccupi anche che gli strumenti elettronici socializzino tra loro, come bambini e adulti e cani.
L’umanità fessa, cioè voi tutti, oltre a volere un’intelligenza artificiale che le dica come vestirsi e come arredare casa e come scrivere un biglietto di condoglianze, vuole anche che tutta l’elettronica si parli, si scambi informazioni, comunichi. Chissà come farò, se la rubrica del telefono non si sincronizza con quella del computer. Morirò di fame e di sete, probabilmente.
L’altro giorno un tassista romano s’è innervosito perché, mentre metteva Via della Penna nel navigatore, gli ho detto che era a piazza del Popolo, al che lui si è messo a inserire piazza del Popolo nel navigatore, e io ho trasecolato, com’era possibile non ci sapesse arrivare: anche se sei romano, ed è impossibile che tu non sappia come andare a piazza del Popolo, ormai i tassisti senza navigatore si sentono smarriti come duenni senza la mamma.
Ogni tanto sento gente anche intelligente, anche semicolta, che si bea di risparmiare moltissimo tempo da quando si fa scrivere le mail dall’intelligenza artificiale: ma quanto ci metti a scrivere una mail? Com’è possibile che tu ci metta meno a spiegare all’ia che mail devi scrivere, che a farlo da solo? Non ho mai letto la fantascienza, e ora mi sembra una lacuna gigantesca: avevano previsto che gli umani non vedessero l’ora di farsi gestire dai robot, che volessero abbandonare ogni autonomia nelle loro piccole vite?
La povera Sarah lo sa, che ormai dipendiamo dalle macchine: nel suo pezzo c’è uno che, senza che lei lo spernacchi, le dice che è condannata a non liberarsi mai dell’iPhone, visto che ha un Apple Watch. Mi sembra la punizione minima, per una che ha comprato quella mostruosità di orologio che ti dica che frequenza cardiaca hai (ennesima illusione che morirai in forma, come i letti che non si reclinano senza il server di Amazon: la tecnologia è ormai la versione industriale di quella battuta di Jannacci, «una vita da malati per morire sani»). Dice Sarah che c’è un concorso di colpa: neanche lei si sta comportando come una brava cliente del libero mercato, e invece di guardarsi intorno resta in una relazione monogama con la Apple.
Io inizio a vedere il BlackBerry che perde colpi, ma l’iPhone non mi avrà. Mai un telefono senza tastiera, è il mio unico principio etico e senza di esso mi sentirei nuda. Mi sembra inaccettabile che tutto torni, che il vintage domini qualunque mercato dei consumi, epperò nessuno voglia rilanciare il BlackBerry. Ho trovato un articolo di quasi vent’anni fa in cui parlavo del nuovo giocattolo che volevano tutte le attrici: cos’è cambiato, cos’è andato storto?
Solo perché in vent’anni è sparito il cinema e sono spariti i dischi e sono spariti i tacchi a cono e sono sparite le tute di ciniglia e sono sparite le sopracciglia sottili, non vuol dire che debba sparire per sempre anche il BlackBerry, io sento che siamo pronte per un ripescaggio, per una di quelle belle commedie romantiche in cui lei scopre in menopausa che quello dei trent’anni era proprio il grande amore. Il grande amore non può non avere la tastiera.
Anche perché l’alternativa è che io alla prima necessità di sostituzione torni al telefono anni Novanta e ci metta dieci minuti a comporre un rigo di messaggio, una lentezza di quelle che caratterizzano voialtri che prendete a ditate il vetro dell’iPhone. È la lentezza che mi uccide, mica il resto: tutte le altre funzioni d’un qualunque telefono moderno, dalle fotografie in giù, mica le uso. È la lentezza.
E, più della lentezza, temo il danno reputazionale. Temo di fare la fine di quell’intellettuale che, alle cene, tira fuori il Nokia per declamare il messaggio che gli ha mandato la rockstar di cui è amico. Temo di finire anziana mitomane che, pur di non cancellare i messaggi della gente famosa, tiene la memoria piena, e non le si può mai dire niente perché non può liberare per le comunicazioni importanti nessuna delle dieci caselle possibili, tutte e dieci occupate da altrettanti sms di Burt Reynolds che le vomita sul tappeto.
L'articolo Non sono io a essere vintage, è il capitalismo che ha lo schermo troppo grande proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































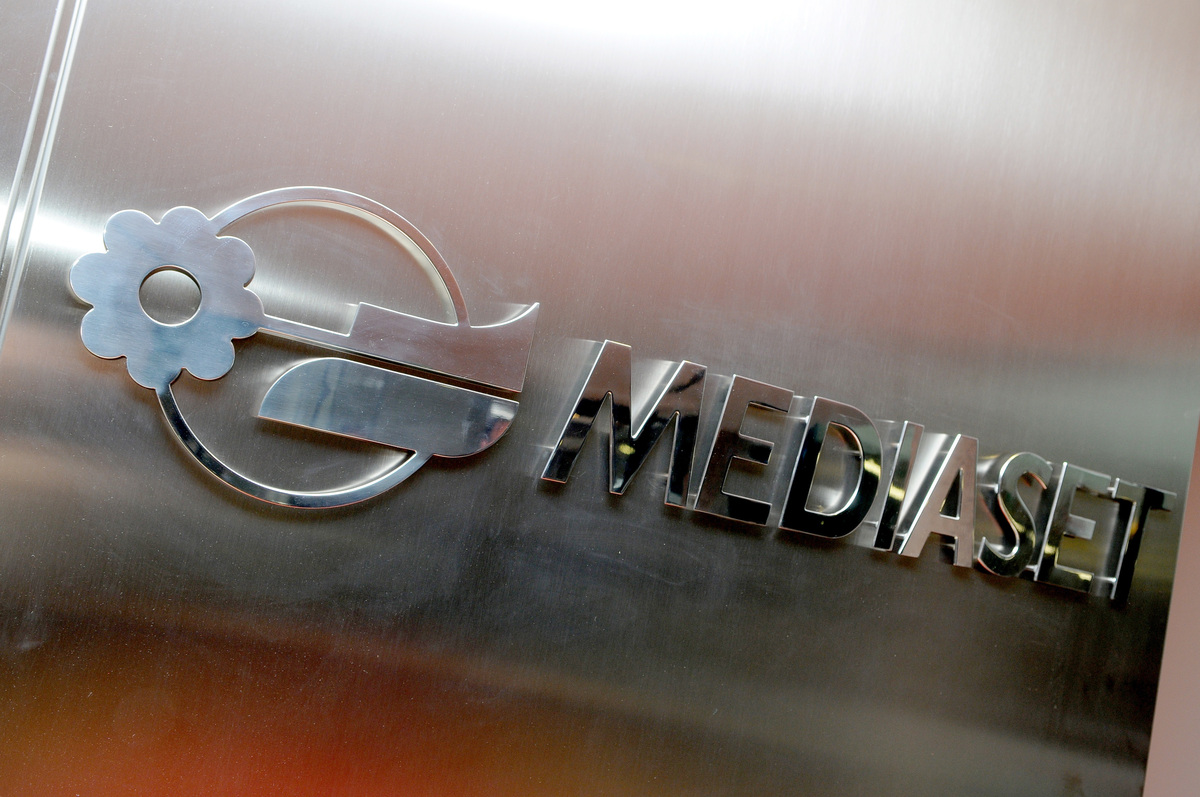


















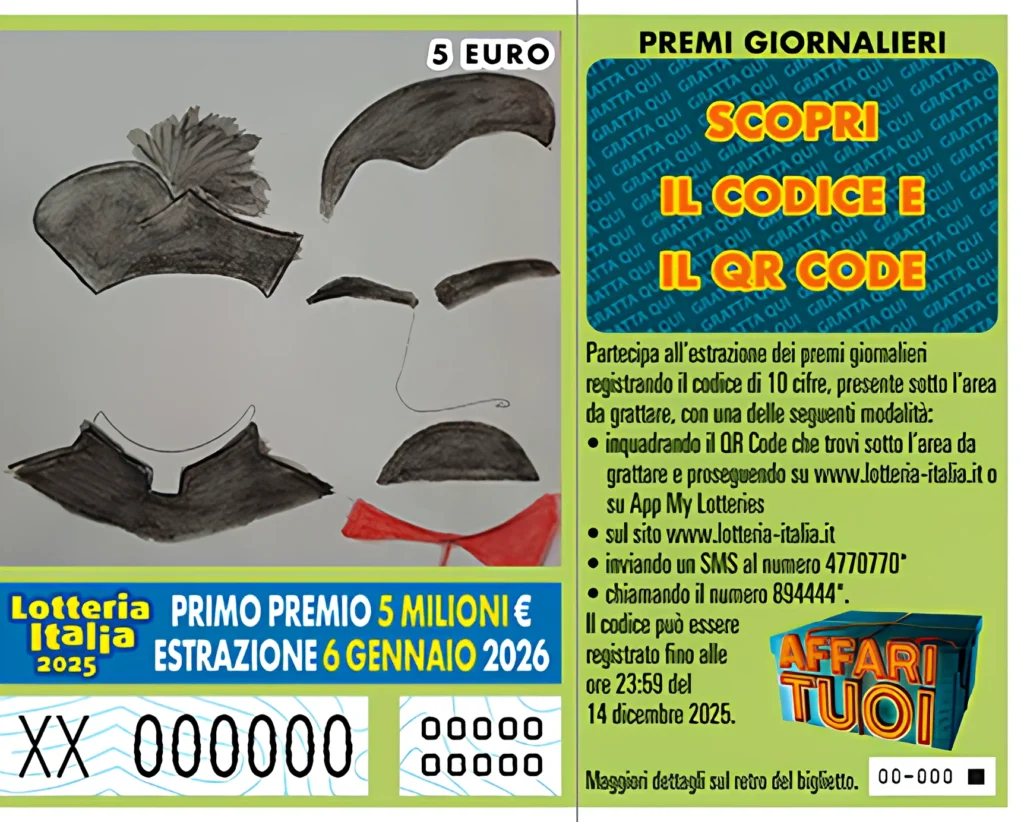









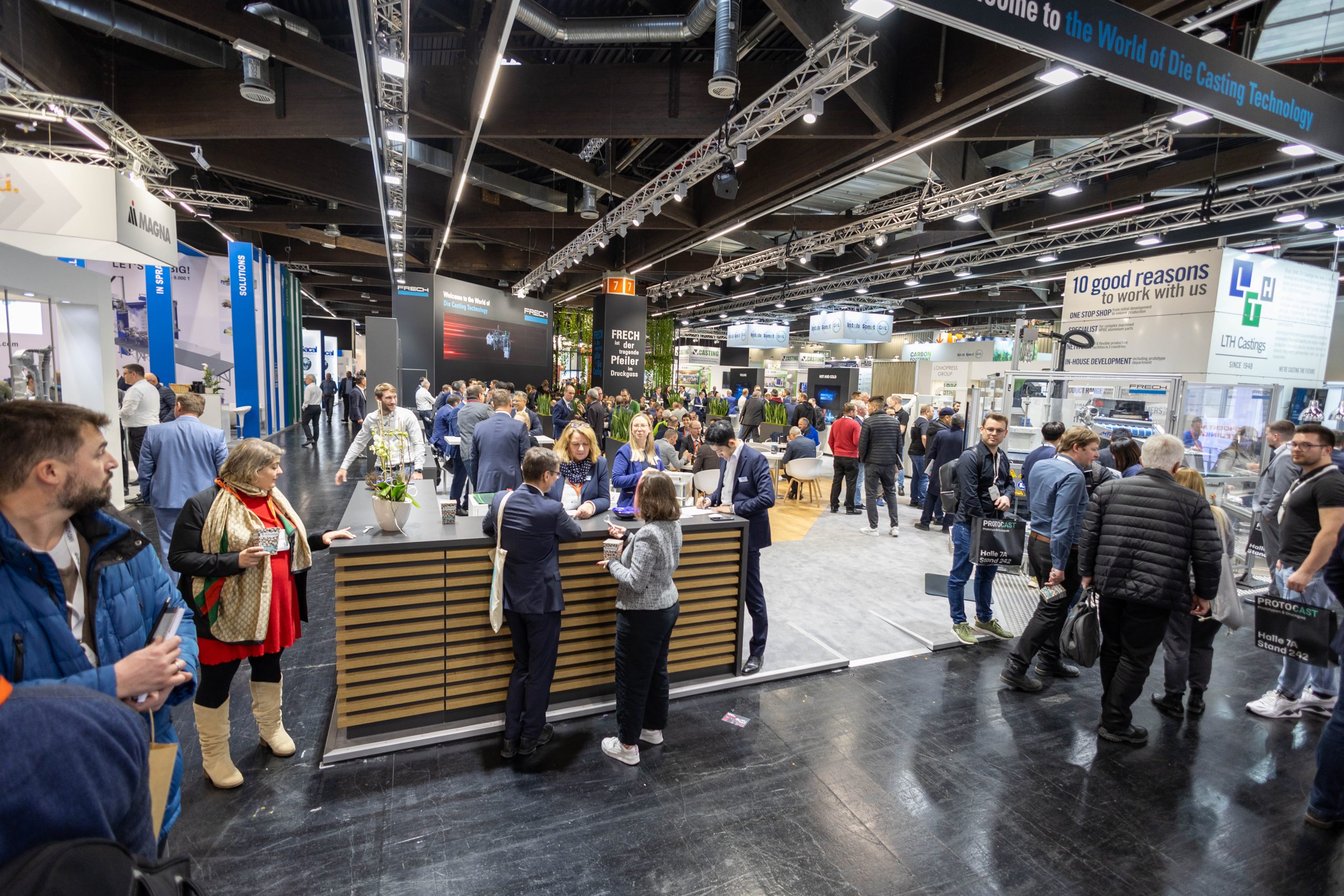





















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)






















































































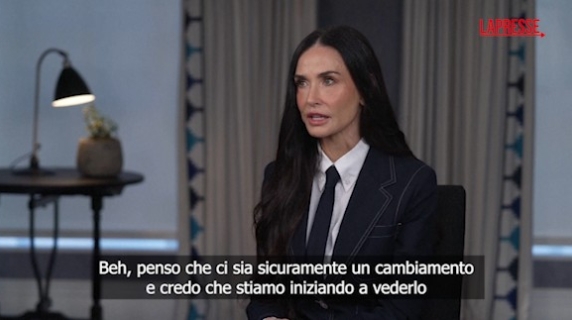
























-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)