Per ridurre il “carbonio nascosto” dei nostri edifici dobbiamo intervenire sui materiali da costruzione


Se davvero vogliamo realizzare una transizione ecologica credibile, dobbiamo agire anche – e soprattutto – sugli edifici. In Europa, il settore delle costruzioni e del patrimonio edilizio esistente è responsabile di circa il 36% delle emissioni di gas serra e di oltre il 40% del consumo energetico totale. È quindi impossibile parlare di neutralità climatica senza intervenire in modo deciso su come progettiamo, costruiamo e utilizziamo gli spazi in cui viviamo e lavoriamo.
Non si tratta soltanto dell’energia impiegata per riscaldare o raffrescare gli ambienti: il problema è molto più profondo e riguarda ciò che potremmo definire il “carbonio nascosto” dei nostri edifici, ovvero le emissioni incorporate (embodied carbon) generate nella produzione dei materiali, nella costruzione e nel ciclo di vita stesso degli immobili.
Secondo il Global Status Report for Building and Construction 2024-2025 del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), il 2023 ha segnato un primo, piccolo segnale positivo: le emissioni globali del comparto edilizio hanno registrato un lieve calo, nonostante un aumento del 5% della superficie edificata. Ma la strada è ancora lunga. Le emissioni operative – quelle legate all’uso quotidiano di energia negli edifici – restano stabili a livelli record, mentre le emissioni incorporate ammontano ancora a 2,9 gigatonnellate di CO₂, con una riduzione del 2,5% rispetto all’anno precedente.
Numeri che mostrano un settore in movimento, ma ancora lontano dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. A rendere il quadro ancora più complesso, entrerà presto in vigore il nuovo Sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS 2 (Emission Trading System 2), che estenderà il prezzo della CO₂ anche ai settori dell’edilizia e dei trasporti. Ciò significa che il costo delle emissioni legate al consumo di gas e carburanti verrà progressivamente trasferito su famiglie e imprese, incidendo direttamente sulle bollette energetiche.
Secondo il report 2025 di Legambiente e Kyoto Club, pubblicato nell’ambito del progetto “Per un salto di classe”, ogni famiglia italiana potrebbe pagare tra 115 e 196 euro in più all’anno, a seconda del prezzo della CO₂ sull’ETS2 e della Regione di residenza. La forbice è legata anche alla composizione del mix energetico locale: dove le fonti rinnovabili hanno maggiore incidenza, gli aumenti saranno più contenuti; nelle aree dove prevale ancora il gas, l’impatto sarà più pesante.
Questo nuovo scenario economico rende ancora più urgente ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e intervenire sui materiali e sui processi costruttivi. A differenza delle emissioni operative — che possono essere ridotte con interventi di efficienza energetica, isolamento e uso di fonti rinnovabili — le emissioni incorporate sono più difficili da abbattere perché si generano prima ancora che un edificio venga abitato. L’unico modo per ridurlo è ripensare l’intero ciclo di vita del costruito, dall’estrazione delle materie prime fino al fine vita dell’edificio, passando per la progettazione, la manutenzione e il riuso dei materiali.
Ed è proprio in questa direzione che si muove la nuova Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD), nota come “Case Green”, approvata nel 2024. Oltre a fissare obiettivi stringenti di efficienza energetica, la direttiva introduce — per la prima volta — l’obbligo di considerare l’intero ciclo di vita emissivo degli edifici, integrando due strumenti chiave:
- la Life Cycle Assessment (LCA), che valuta tutti gli impatti ambientali di un edificio lungo le varie fasi di vita;
- il Whole Life Carbon (WLC), che misura in modo specifico le emissioni totali di CO₂ equivalente, sia operative che incorporate.
Questo approccio segna un passaggio culturale decisivo: non basterà più costruire edifici efficienti, ma sarà necessario costruirli con materiali e processi a basso impatto climatico, valutando la loro impronta carbonica totale. La direttiva prevede che gli Stati membri – Italia compresa – definiscano entro il 2027 metodi comuni di calcolo e limiti nazionali di emissioni WLC per i nuovi edifici pubblici e privati.
L’approccio “whole life” è già realtà in diversi Paesi europei. La Francia, con la RE2020, impone limiti massimi di CO₂ per metro quadrato costruito, basandosi su un database nazionale dei materiali (INIES). La Danimarca applica un tetto di 12 kg di CO₂ equivalente per m² all’anno ai nuovi edifici sopra i 1.000 m². Nei Paesi Bassi, il metodo MPG (Milieuprestatie Gebouwen) obbliga a calcolare la prestazione ambientale di ogni edificio e a rispettare soglie di impatto.
In Italia, il Green Building Council Italia ha pubblicato nel 2024 il documento “Strumenti per la decarbonizzazione: valutazione della Whole Life Carbon e della Circular Economy”, che fornisce una metodologia nazionale per LCA e WLC.
Un esempio emblematico arriva da EDERA, hub milanese per l’innovazione edilizia che promuove il modello europeo Energiesprong (“salto energetico”). Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Housing Sociale e dal Politecnico di Milano, applica un metodo di riqualificazione profonda e standardizzata degli edifici, con componenti prefabbricate e materiali a basso impatto. Ogni intervento include una misurazione LCA e l’adozione di componenti riutilizzabili, riducendo al minimo il carbonio incorporato. I primi progetti pilota in Lombardia e Piemonte, dedicati all’edilizia residenziale pubblica, dimostrano come l’innovazione industriale possa accelerare la decarbonizzazione del costruito senza sacrificare qualità e comfort abitativo.
Una parte sempre più importante della transizione edilizia passa anche attraverso la bioedilizia e l’uso di materiali naturali e rinnovabili. In Italia, realtà come Ricehouse, Federcanapa e Diasen stanno dimostrando come sia possibile costruire e riqualificare riducendo drasticamente il carbonio incorporato.
Ricehouse, nata in Piemonte, utilizza scarti della lavorazione del riso – come la lolla e la paglia – per realizzare intonaci, pannelli e isolanti naturali. Questi materiali, oltre a essere riciclati e riciclabili, immagazzinano CO₂ durante la loro vita utile, trasformando l’edificio in un “pozzo di carbonio”. Federcanapa promuove la filiera nazionale della canapa industriale, un materiale che cresce rapidamente e sequestra grandi quantità di anidride carbonica, impiegato per blocchi e intonaci con alte prestazioni termiche e acustiche. Diasen, azienda marchigiana, sviluppa eco-resine e rivestimenti a base di sughero e calce naturale, combinando isolamento, traspirabilità e ridotto impatto ambientale.
Questi esempi mostrano che la decarbonizzazione edilizia non è solo questione di tecnologia, ma anche di filiera e di materia, valorizzando risorse locali e processi produttivi circolari. La sfida della transizione energetica non si gioca solo nei piani industriali o nelle centrali elettriche, ma nelle case, nelle scuole e negli uffici in cui viviamo ogni giorno. Servono norme chiare, incentivi stabili e una nuova cultura del progetto capace di guardare al ciclo di vita dell’edificio come a un’unica catena di responsabilità ambientale. Perché la vera neutralità climatica non nasce dal nuovo, ma dal modo in cui scegliamo di costruire – o di non costruire affatto.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































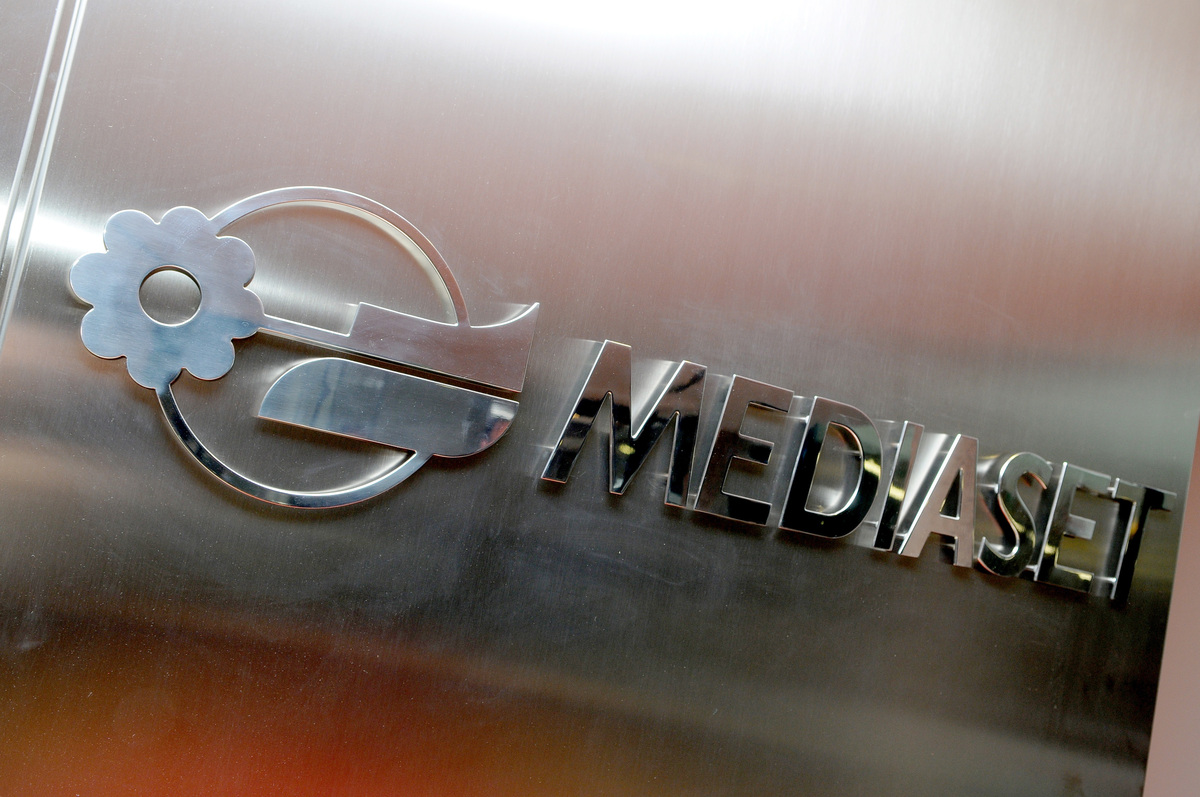


















































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)
























































































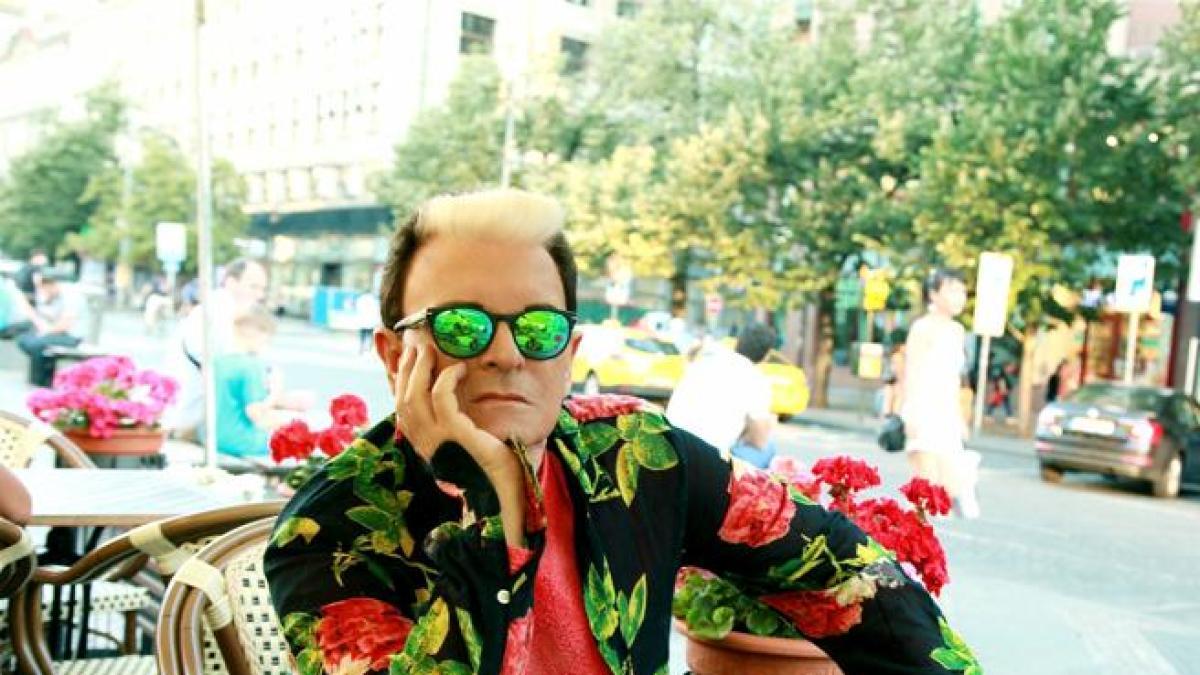

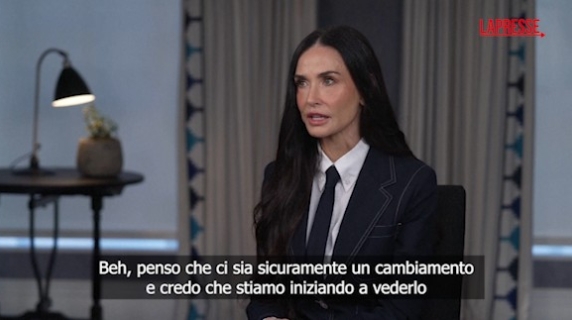




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































