A nessuno è mai bastato semplicemente “partecipare”


Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.
A dispetto delle dichiarazioni sullo spirito sportivo, i Giochi Olimpici e Paralimpici, la cui edizione invernale si sta per celebrare in Italia, sono molto di più che una competizione tra atleti. In particolare, negli ultimi cento anni, scrive l’economista Andrea Goldstein in Quando l’importante è vincere. Politica ed economia delle Olimpiadi (Il Mulino, 2024), dietro la retorica della fatica e dell’agonismo si sono intrecciate ambizioni nazionali, rivalità politiche e interessi economici. D’altra parte, neppure per gli antichi greci le Olimpiadi furono quella “palestra” di virtù sportiva che immaginiamo. Come hanno raccontato Eva Cantarella, nota grecista, ed Ettore Miraglia nel saggio edito da Feltrinelli L’importante è vincere, per gli ellenici la vittoria era un valore primario; la sconfitta una prova d’inadeguatezza, per evitare la quale anche un certo grado di scorrettezza era “ammesso”. Prova ne è che nei ginnasi ateniesi si praticava un doppio culto: quello di Eracle, simbolo di forza atletica, e quello di Ermes, divinità dall’intelligenza astuta.
D’altronde, la stessa fondazione delle Olimpiadi, nel 776 a.C., è associata a un inganno. Secondo il poeta Pindaro, Pelope, figlio del re di Lidia, giunto nella regione che da lui avrebbe preso il nome di Peloponneso, partecipò alla gara di carri indetta da Enomao, re di Pisa, città non lontana da Olimpia. Premio: le nozze con la principessa Ippodamia, figlia di Enomao. Questi era certo di vincere, potendo contare su una quadriga donatagli da Fetonte, il figlio di Apollo, che aveva guidato il carro del Sole. Vinse invece Pelope, il quale, dopo un lungo matrimonio con Ippodamia, fu sepolto presso il sacro recinto di Olimpia. In suo onore furono celebrati i giochi funebri, all’origine proprio delle Olimpiadi. In altre versioni della storia, però, si narra che la gara fu vinta dall’eroe corrompendo Mirtilo, l’auriga di Enomao, che su suggerimento di Pelope sostituì con della cera i chiodi dei mozzi del carro del re, provocando il distacco delle ruote.
Dopo quella prima gara truccata, le scorrettezze peraltro non si fermarono. Secondo Plutarco, per esempio, nel 388 a.C. Eupolo di Tessaglia vinse il primo premio nel pugilato. Come? Comprando ben tre avversari… Mentre alcuni decenni più tardi, un ateniese vinse il pentathlon ricorrendo allo stesso metodo. E, squalificato, suscitò l’indignazione nei suoi concittadini più per essersi fatto scoprire che per la scorrettezza. Un falso storico, poi, è anche l’idea che i greci gareggiassero soltanto per la gloria. Sin dall’inizio esistevano gli agones thematikoi, con premi consistenti in oggetti di valore o in denaro. Si deve dunque unicamente all’aristocratico francese Pierre de Coubertin, con la sua visione moralista dello sport come educazione dei giovani, l’idea vulgata che le Olimpiadi siano un’arena di fair play lontana da logiche di profitto e di potere. Per gli atleti di un tempo, non meno che per gli atleti odierni, i Giochi significano migliaia di ore ad allenarsi per prevalere; per le città che le ospitano, spendere somme colossali per svettare; per le imprese, investire cifre esorbitanti per sponsorizzare le gare; per i Paesi, farsi un’immagine prospera ed efficiente o anche rifarsi una reputazione sulla scena internazionale. La realtà: celata oltre la retorica.

Iniziamo dalla professionalizzazione degli atleti: se a Jim Thorpe, uno dei più versatili dello sport moderno, stella del football americano, del baseball e campione olimpico nel pentathlon e nel decathlon, furono ritirati i titoli conquistati a Stoccolma nel 1912, a causa di una breve precedente esperienza semiprofessionistica, con l’avvento degli sponsor tecnici, l’esposizione mediatica e l’esplosione dei costi organizzativi, il dilettantismo non è più possibile. Ecco perché, nel 1974, la Rule 26 del Comitato Internazionale Olimpico è stata emendata per consentire a ogni federazione di fissare i criteri di eligibilità per il proprio sport e nel 1975 il termine “dilettante” è stato cancellato dalla Carta, così da consentire agli atleti di essere pagati per il tempo dedicato all’allenamento e di indossare materiale pubblicitario (sebbene non durante i Giochi), pur devolvendone parte alla loro federazione.
Il professionismo ha addirittura trasformato l’identità stessa degli atleti, rendendo la bandiera che rappresentano una questione negoziabile. Sempre più spesso, infatti, i campioni cambiano nazionalità in cerca di migliori condizioni o visibilità, fatto salvo l’obbligo di attendere due anni prima di rappresentare una nazione diversa da quella d’origine. Oggi negli 11 team principali del mondo, gli olimpionici nati all’estero sono cresciuti dal 6% del 1948 al 9% del 2012, a dimostrazione che le vittorie delle superstar valgono per gli Stati più dei confini geografici, politici, culturali. Anche in epoca classica, d’altronde, la “nazionalità” era un concetto poroso: Sotades era un mezzofondista cretese che Efeso pagò per difendere i suoi colori – e che a Creta non poté fare ritorno; mentre il velocista crotonese Astilo fu perfino disconosciuto dai parenti quando si aggiudicò una medaglia per conto di Siracusa. I trucchetti nella competizione non riguardano soltanto la nazionalità degli atleti: agli scandali per abusi e doping, si aggiungono i giudici di alcune discipline che favoriscono i connazionali. Da manuale il caso della pattinatrice artistica Adelina Sotnikova che a Sochi ottenne il punteggio massimo dal marito della presidente della Federazione russa di pattinaggio. Infiniti sono poi gli scandali legati all’opacità del Comitato olimpico internazionale (Cio), la più grande organizzazione non-governativa al mondo, guidata da un centinaio di persone cooptate secondo criteri pressoché ignoti che decidono in modo non di rado imperscrutabile quale città appoggiare per i Giochi futuri e i cui presidenti sono spesso molto discussi.
Un caso per tutti: Antonio Samaranch, Presidente del Cio dal 1980 al 2001, la cui avidità è riassunta in una frase dello scrittore francese Maurice Droun: “Se il cuore di de Coubertin riposa a Olimpia, il suo andrebbe deposto a Wall Street”. Quanto agli investimenti delle città per ospitare i Giochi, il bilancio non è affatto scontato sia positivo. Lo sforamento medio del budget tra il 1964 e il 2018 è stato del 172% rispetto alla previsioni. Un aumento incontrollato dovuto in parte a un “ottimismo eccessivo”, autentico e simulato; in parte a un altro inganno, ovverosia alla manipolazione deliberata dei numeri per ottenere l’assegnazione, per non parlare dei ritardi e della mancanza di trasparente concorrenza nei processi di gara. Le infrastrutture, infine, spesso sovradimensionate, gravano sui costi. Si torna così alla domanda fondamentale: i Giochi convengono? Forse. Premesso che è difficile definire le variabili da considerare (come valutare l’impatto dell’immagine del Paese ospitante all’estero?) alcuni studi indicano effetti positivi su turismo ed esportazioni; altri ne sottolineano la sovrastima e la breve durata. Le due sole edizioni in attivo d’altronde sono state Barcellona (1992) e Los Angeles (1984), mentre Montreal (1976) si è indebitata a tal punto che ha impiegato 50 anni a ripianare il debito, segnando la successiva sconfitta del sindaco, l’unica però registrata per un primo cittadino responsabile delle Olimpiadi. Eppure, un po’ per il prestigio un po’ perché sperano nell’effetto traino, spesso le città candidate sono disposte a tutto, come documentano gli scandali di Salt Lake City 2002 (che pagò borse di studio e spese mediche per le famiglie dei membri del Comitato Olimpico Internazionale) e di Tokyo 2020 (con pagamenti a una società di Singapore per aggiudicarsi i voti dei delegati africani).

Non tutti comunque puntano ai Giochi per gli stessi motivi. I regimi più liberali esaltano se stessi come mete turistiche, enfatizzando la propria immagine di società aperte e tolleranti: i Giochi di Parigi 2024 furono chiusi da un baccanale politicamente corretto celebrato sulle acque della Senna. I governi più autoritari mirano più che altro a celebrare, legittimandolo, il loro potere. È il cosiddetto sportswashing. «I Giochi sono diventati un giochino molto costoso in cui, distratti dall’illusione di parlare di performance e di pace, si fanno gli interessi di sponsor, dittatori e atleti dopati», riassume Goldstein. A farvi ricorso, in tempi recenti, sono state la Russia (2014) e la Cina (2022), quest’ultima favorita da un vicepresidente cinese del Cio che chiuse un occhio sugli alti indici d’inquinamento e le scarse infrastrutture di Pechino. Ma anche qui niente di nuovo. Antesignani dello sportwashing moderno sono stati i Giochi Olimpici del 1938 a Berlino, secondo lo storico Paul Christensen, professore di Storia greca antica al Dartmouth College (Usa). Ma potremmo far risalire la pratica, ancora una volta, ai Greci. Mentre nel 416 a.C. Alcibiade spese ingenti somme per competere nelle gare di carri, schierando ben 7 quadrighe diverse e ottenendo un primo, un secondo e un quarto posto, in una fase in cui Atene stava perdendo la guerra del Peloponneso contro Sparta e i suoi alleati: il ricco e ambizioso Alcibiade voleva far passare l’idea di un’Atene ancora potente: “una manovra geopolitica a tutti gli effetti”, secondo Christensen.
Infine, anche la discriminazione tra i sessi, in Grecia sistematica, ha avuto un’eccezione sportiva. Presso il santuario dedicato ad Artemide Brauronia, protettrice delle donne gravide, si svolgeva una gara dove le giovani parthenoi, poco più che bambine, dovevano correre attorno all’altare di Artemide imitando i gesti dell’orsa, simbolo di forza e coraggio. La gara non poteva essere perduta, per esempio non portandola a termine, pena l’esclusione dalla vita adulta e dalla relativa funzione riproduttiva. Segno che il compito primo delle donne era essere ricettacolo del seme maschile. Ma anche che allo scopo bisognava dimostrare il proprio valore “sportivo”. D’altronde, nella guerriera e ben poco femminista Sparta, le donne morte di parto erano seppellite con nome e cognome, privilegio accordato soltanto agli eroi morti in guerra. E gli atleti sono gli eroi quando la guerra tace.
L'articolo A nessuno è mai bastato semplicemente “partecipare” proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























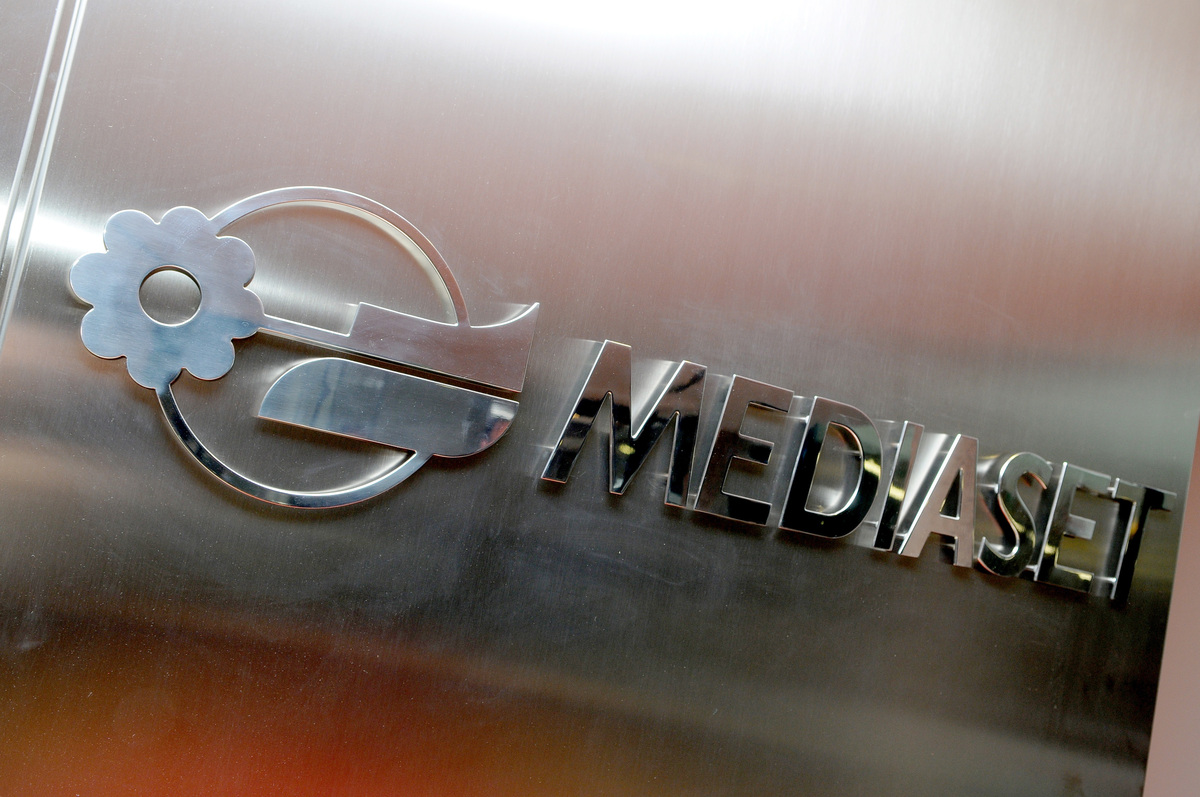



























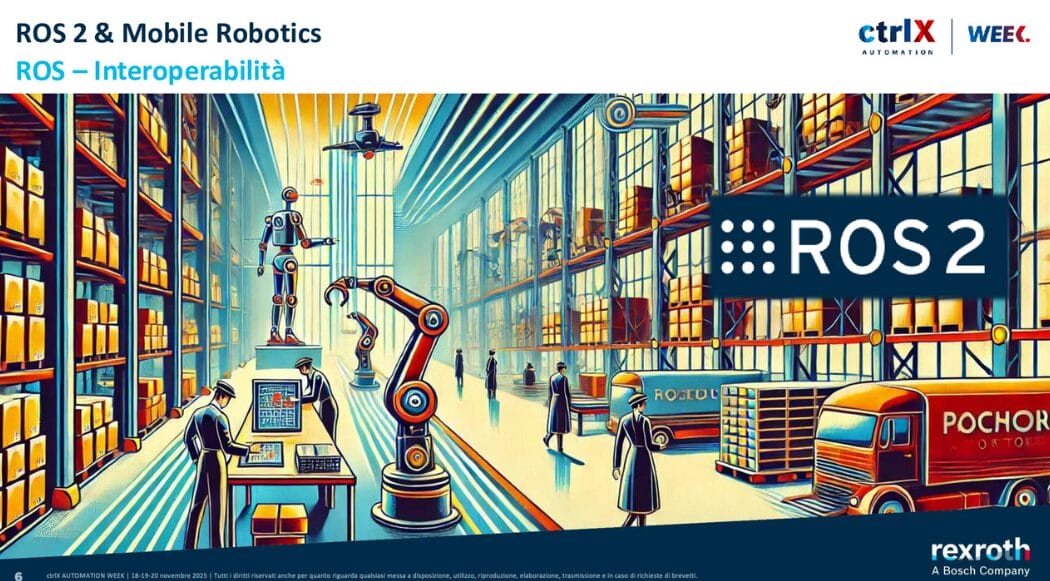











































































































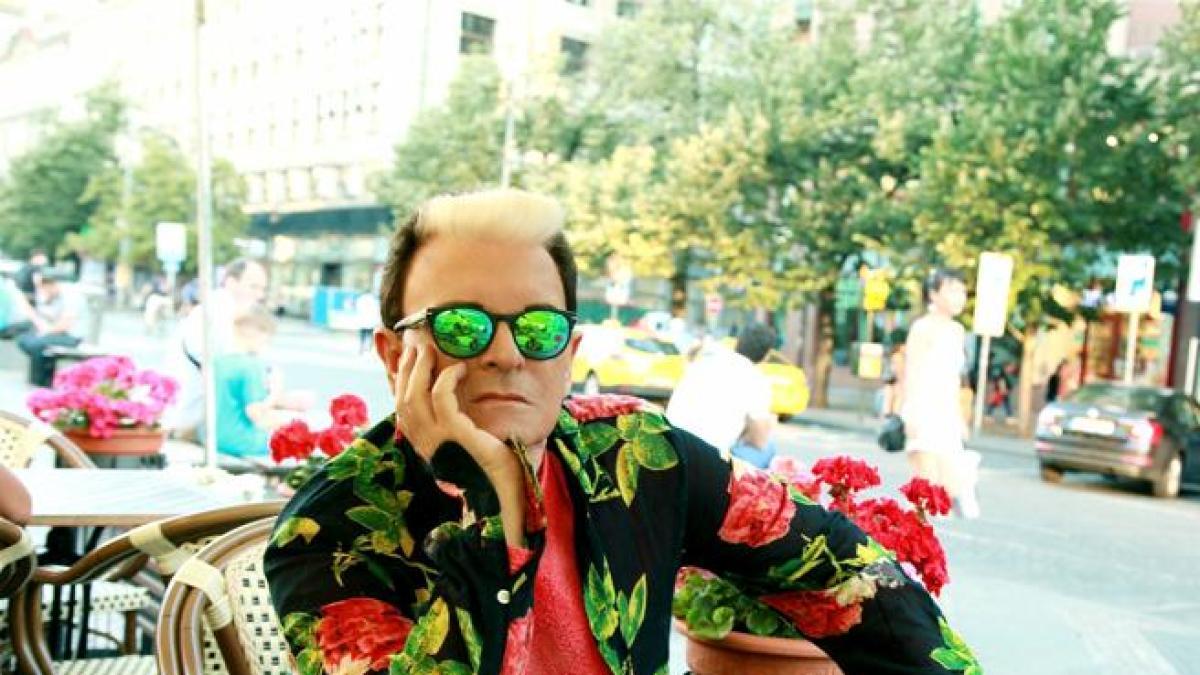

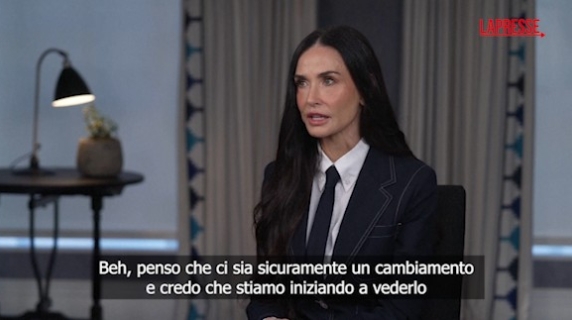




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































