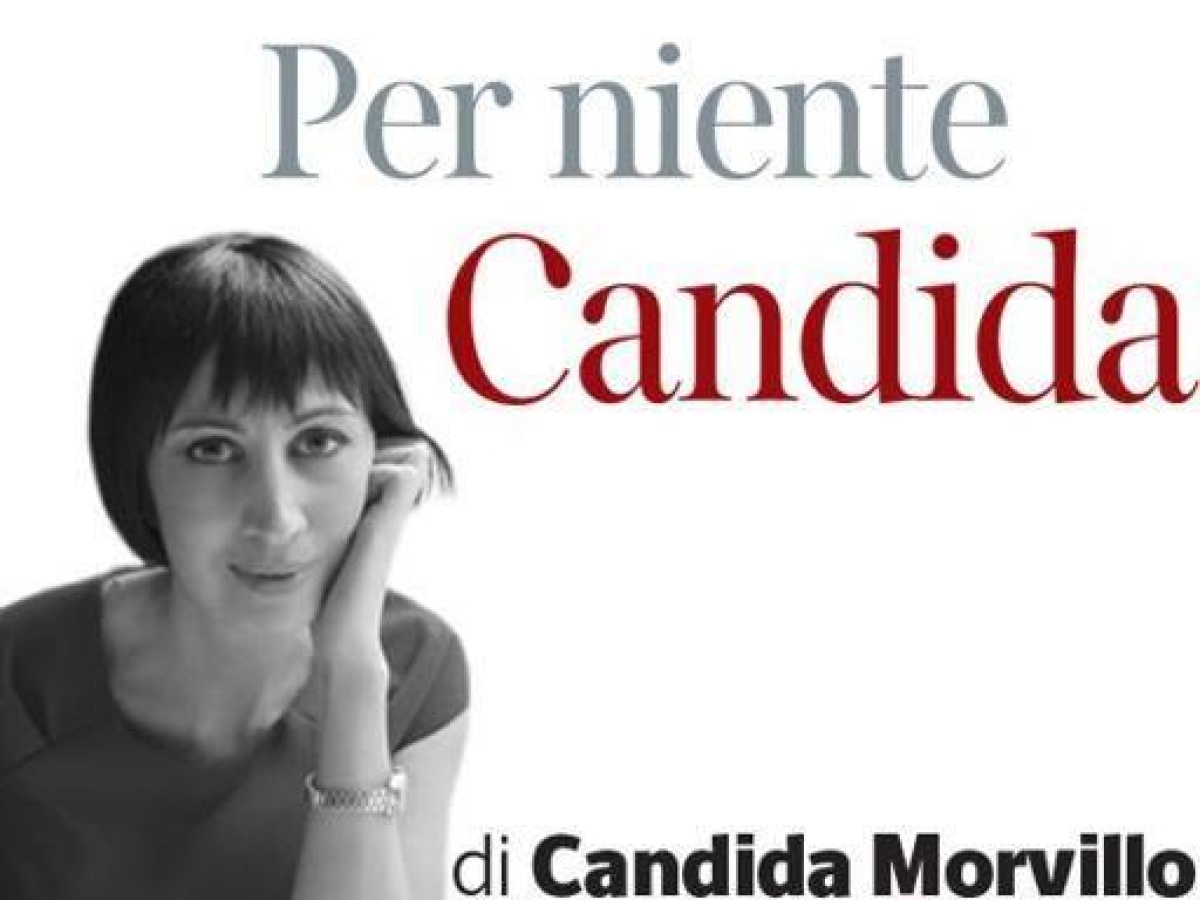Al Teatro Menotti di Milano va in scena il Teatro Disarmato

Con Teatro Disarmato la nuova stagione del Teatro Menotti si fa atto civile e artistico. Un progetto necessario, nato in un tempo segnato da nuovi conflitti e da una crescente disumanità. Non una semplice rassegna, ma una presa di posizione. Il teatro, spazio fragile e potente, sceglie di essere voce disarmata contro ogni guerra. La rassegna attraversa epoche, linguaggi, memorie. Da Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, feroce affresco antimilitarista, a L’è el dì di mort, alegher, che raccoglie le voci dei disertori della Grande Guerra; dalle Olimpiadi del 1936, dove sport e ideologia si scontrano, a Causa di beatificazione, potente affresco femminile di violenza e redenzione. Al cuore del progetto, il Trittico della guerra diretto da Gabriele Vacis, che indaga la radice mitica del conflitto attraverso tre tragedie classiche: in Prometeo si accende il fuoco della ribellione individuale contro il potere assoluto; Sette a Tebe mette in scena la rovina della guerra fratricida; Antigone dà voce alla resistenza etica, al diritto di dire no. Tre gesti, tre dolori, tre sfide al potere che, secoli dopo, continuano a interrogarci. E poi gli incontri con quegli autori che sono testimoni contemporanei del dolore, della perdita e della lotta per la dignità umana, tra questi l’incontro La pace è il contrario della guerra? con Fernando Gentilini, Franco Pagetti, Emilio Russo e Gabriele Vacis. Modera Elisabetta Burba (Krisis.info). Il Teatro disarmato non è una rassegna, ma una scelta. Contro l’assuefazione all’orrore, contro l’indifferenza. Perché il teatro, quando è vero, non consola, risveglia. E sceglie da che parte stare.
14 | 19 ottobre
TRITTICO DELLA GUERRA
PRIMA MILANESE
PROMETEO
SETTE A TEBE
ANTIGONE
Con le attrici e gli attori di PoEM Impresa Sociale
Regia GABRIELE VACIS
Scenofonia e allestimenti Roberto Tarasco
Con Il Trittico della guerra diretto da Gabriele Vacis si apre Teatro Disarmato, il primo atto della nuova stagione del Teatro Menotti: un atto civile e artistico. Un progetto necessario, nato in un tempo segnato da nuovi conflitti e da una crescente disumanità. Non una semplice rassegna, ma una presa di posizione. Il teatro, spazio fragile e potente, sceglie di essere voce disarmata contro ogni guerra. Teatro Disarmato non è una rassegna, ma una scelta. Contro l’assuefazione all’orrore, contro l’indifferenza. Perché il teatro, quando è vero, non consola: risveglia. E sceglie da che parte stare.
Il Trittico della guerra è una trilogia composta dalle tragedie Prometeo, Sette a Tebe e Antigone, firmato da Gabriele Vacis, regista e drammaturgo tra i più apprezzati della scena contemporanea, con gli attori della compagnia PoEM (Potenziali Evocati Multimediali), gli allestimenti e la scenofonia di Roberto Tarasco, i cori a cura di Enrica Rebaudo.
Un viaggio attraverso il mito, riletto e adattato con la lente del tempo presente, per riflettere sui ruoli, le pulsioni e le difficoltà che le giovani generazioni devono affrontare per trovare una collocazione all’interno di un mondo iperconnesso, ma ancora segnato da feroci conflitti politici e sociali.
14 e 15 ottobre
PROMETEO
Dal Prometeo incatenato di Eschilo
Prometeo racconta di un tempo che viene prima del tempo, di uno spazio che non è uno spazio. Il titano ha rubato il fuoco agli dèi per donarlo agli umani, per questo Zeus lo punisce inchiodandolo ad una rupe ai confini del mondo, in Scizia. Lì, sofferente ma non del tutto vinto, riceve alcune visite: le oceanine e il loro padre, Oceano, e poi la vergine Io, per ultimo Hermes, il galoppino di Zeus. C’è chi lo raggiunge per scelta e chi ci capita, ma in entrambi i casi questi incontri sembrano essere più delle visioni che veri e propri dialoghi. Prometeo racconta ciò che è successo, tesse le fila di un racconto lontano, rivendica il suo diritto alla libertà e la giustezza della sua ribellione.
Gabriele Vacis, in scena, introduce alcuni passaggi, ne sottolinea degli altri: guida gli spettatori alla visione, riportando continuamente il tempo del mito alla contemporaneità attraverso le parole di altri autori, come Luigi Meneghello o William Golding. È proprio dentro un’opera di quest’ultimo che il nostro Prometeo trova le sue più profonde ragioni, il suo nucleo pesante. La scena è vuota, si riempie soltanto dei corpi e delle voci degli interpreti. La danza e il canto sono essenziali, costruiscono e costituiscono la struttura del coro. Sono numerose le lingue: dall’albanese all’armeno, suoni di spazi che sono indecifrabili ma che rimandano al mistero di un mondo antico e perduto.
Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza nel settembre del 2022
Produzione PoEM impresa sociale, Artisti Associati centro di produzione Gorizia
in collaborazione con UTIM
16 e 17 ottobre
SETTE A TEBE
QUESTO TERRIBILE AMORE PER LA GUERRA
Da I sette contro Tebe di Eschilo, traduzione di Monica Centanni
Al centro della scena il vissuto corale dei cittadini di Tebe fa da cassa di risonanza a quanto accade al di là dalle mura della città e fa accadere in scena i rumori dell’assedio, i colori e le immagini terrificanti del nemico, dell’estraneo, dell’altro che da fuori spinge, e minaccia l’ordine della città dalle sette porte. Ma l’“altro” – come ci rivela l’inaspettato scontro alla porta settima tra i fratelli nemici Eteocle e Polinice – ha sempre le sembianze del fratello: la guerra è, sempre, guerra civile. Il copione è costruito incastonando nel testo di Eschilo brani di voci attuali, che portano sulla scena dati tecnici sulle armi in uso nel nostro tempo, ma anche considerazioni storico-culturali sull’immanenza della guerra a ogni latitudine, geografica e cronologica, della nostra civiltà.
Sulla trama di un testo così costruito, i giovani attori/autori di PoEM si prendono la responsabilità di rappresentare, di far accedere alla realtà aumentata del teatro, i desideri, i punti di forza e di debolezza della generazione dei ventenni: in scena riflettono l’esperienza della guerra nei pensieri, nei gesti, sui corpi dei giovani loro coetanei. In questo la tragedia di Eschilo si dichiara come “necessaria”, la matrice giusta che genera una presentazione adeguatamente complessa del nostro tempo. In un’altalena che oscilla tra le parole di Eschilo e le domande del presente su cosa sia, allora come oggi, la guerra, si attiva un cortocircuito energetico tra antico e contemporaneo, complici molti autori, di epoca e cultura diversa, chiamati in causa: Henri Laborit, Sun Tzu, Franklin J. Schaffner, Bertolt Brecht e, soprattutto, James Hillman che orienta la prospettiva mai retoricamente buonista sul tremendo impasto di amore e di ferocia che ha il nome divino di Ares, e innesca la concentrazione di uno sguardo e la direzione di un pensiero mai scontato sulla terribile vitalità di ogni guerra.
Lo spettacolo ha aperto il 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza
Produzione PoEM impresa sociale, Artisti Associati centro di produzione Gorizia
in collaborazione con UTIM
18 e 19 ottobre
ANTIGONE
Da Fenicie di Euripide e Antigone di Sofocle
Antigone mette in scena uno dei personaggi femminili più importanti della storia del teatro attraverso due tragedie: Fenicie di Euripide e Antigone di Sofocle, perché conoscendo gli antefatti è possibile comprendere meglio le scelte di Antigone. Poi ci sono le risposte degli attori ad alcune domande che il testo ci ha posto: avete qualcosa per cui vale la pena vivere? Avete qualcosa per cui vale la pena morire? Quando avete compiuto azioni eccessive? Quando avete avuto paura per qualcuno? Quando è stato troppo tardi? Antigone nel corso dei secoli, dei millenni, è stata il simbolo della rivoluzione ma anche della conservazione più oscurantista.
Negli ultimi anni, per esempio, era di moda prendere le parti di Creonte: Antigone potrebbe essere la sorella di un capomafia che pretende funerali con fuochi d’artificio per il fratello assassinato e Creonte il giudice che nega l’autorizzazione. All’epoca dei tragici, nel quinto secolo avanti Cristo, in Grecia, stavano inventando la democrazia. E Antigone potrebbe essere l’erede di un’aristocrazia che difende antichi privilegi di fronte al nuovo che avanza. È comprensibile che gli anni appena passati chiedessero legalità dopo decenni di leggi “ad personam”, che facessero il tifo per la ragion di Stato, che è Creonte. Per contro, quando io avevo l’età dei ragazzi che sono in scena nello spettacolo, ribellarsi era giusto! Com’era giusto per i genitori della mia generazione, che andavano in montagna a fare i partigiani quand’erano ancora adolescenti. Sono questo i classici, comprendono la cosa e il suo contrario, contengono i paradossi, sono specchi che riflettono gli sguardi di un’epoca.
Produzione Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale, PoEM impresa sociale, Artisti Associati centro di produzione Gorizia in collaborazione con UTIM
19 ottobre ore 18:30
INCONTRO
LA PACE È IL CONTRARIO DELLA GUERRA?
Con Ferdinando Gentilini Diplomatico e Autore, Franco Pagetti Fotografo di guerra, Emilio Russo Direttore Artistico del Teatro Menotti e Gabriele Vacis Regista.
Modera Elisabetta Burba, Direttrice della rivista Krisis.info.
Nel tempo delle guerre permanenti, che cosa resta della parola pace? Un incontro al Teatro Menotti, all’interno della rassegna Teatro disarmato, per interrogarsi sul fragile confine tra tregua e riconciliazione. Ne discuteranno il diplomatico Fernando Gentilini, il fotografo di guerra Franco Pagetti, il direttore artistico del Teatro Menotti Emilio Russo e il regista Gabriele Vacis. Modera Elisabetta Burba, direttrice della rivista Krisis.info.
ELISABETTA BURBA | Giornalista
Fondatrice e direttrice responsabile di Krisis, è una giornalista d’inchiesta e docente a contratto all’Università Statale di Milano. È stata capo della sezione Esteri di Panorama, ha collaborato con media internazionali, partecipato a missioni di osservazione elettorale per l’OSCE, scritto libri e insegnato all’Università dell’Insubria e alla Summer School del Marlborough College (UK). Dopo la laurea in Lettere alla Statale di Milano, ha fatto un Master al Politecnico e seguito corsi all’Università del Wisconsin, alla Scuola Sant’Anna di Pisa e alla London School of Economics. Vincitrice del premio Saint-Vincent.
FRANCO PAGETTI | Fotogiornalista
Nato a Varese nel 1950, dopo gli studi in Chimica all’Università di Milano abbandona le molecole per la fotografia. Ex membro di VII Photo Agency, oggi parte della VII Foundation, ha raccontato i principali conflitti internazionali. Inviato per TIME in Iraq dal 2003 al 2008, ha documentato sei anni di guerra, per poi seguire l’Afghanistan tra il 1998 e il 2010.
Collabora con testate come TIME Magazine, New York Times, The New Yorker, Stern, Vogue America, Le Figaro Magazine, Paris Match, Le Monde. Definito dal New York Times “uno dei fotografi di guerra più esperti e rispettati della sua generazione”, ha lavorato dall’inferno iracheno al gelo delle Svalbard, sempre con un unico obiettivo: raccontare l’essenza dell’umano.
FERNANDO GENTILINI | Diplomatico e Autore
Diplomatico di professione, con oltre trent’anni di esperienza europea e internazionale, ha operato in Africa, Balcani, Medio Oriente e Afghanistan, rappresentando Ministero degli Esteri, Unione europea e NATO. Ha ricoperto ruoli di vertice a Bruxelles, tra cui Direttore generale per Nord Africa e Medio Oriente e Rappresentante speciale UE a Gerusalemme e in Kosovo.
Oggi vive tra Roma e Bruxelles, dove collabora con istituti, università e testate giornalistiche. Autore di numerosi libri, tra cui Atlante delle città eterne (2025), I demoni (2023) e Tre volte a Gerusalemme (2020, Premio Gambrinus)
21 |23 ottobre
MATTATOIO N.5
KURT VONNEGUT
Tratto dal libro di Kurt Vonnegut
Con Con Nicolas Errico, Maria Vittoria Scarlattei, Jacopo Sorbini, Chiara Tomei
Costumi Pamela Aicardi
Produzione Tieffe Teatro
Un viaggio surreale tra tempo, memoria e guerra. Mattatoio n. 5, capolavoro di Kurt Vonnegut e manifesto pacifista, racconta la storia di Billy Pilgrim, soldato americano e viaggiatore nel tempo, testimone del bombardamento di Dresda e protagonista di una narrazione frammentata e visionaria. Billy scivola tra passato, presente e futuro, senza ordine né controllo, mentre attorno a lui realtà e fantasia si fondono. La scena è affidata a quattro personaggi minori, la moglie Valencia, il soldato Roland, la pornodiva Montana e lo scrittore Trout che, tra sogno e realtà, ricompongono i frammenti della vita di Billy, pellegrino disarmato nella follia della guerra. Lo spettacolo restituisce l’ironia feroce e la dolente umanità del romanzo, giocando con i linguaggi della fantascienza, della tragedia e della comicità. Perché, come dice Billy, di fronte all’assurdo e all’orrore, l’unica risposta possibile è: “Così va la vita.”
24 e 25 ottobre
LE OLIMPIADI DEL ‘36
FEDERICO BUFFA
Di Federico Buffa, Emilio Russo, Paolo Frusca, Jvan Sica
Con Federico Buffa
Pianoforte Alessandro Nidi
Fisarmonica Nadio Marenco
Voce Cecilia Gragnani
Costumi Pamela Aicardi
Produzione Tieffe Teatro
Il 24 e 25 ottobre al Teatro Menotti va in scena Federico Buffa con Le Olimpiadi del ’36, uno spettacolo che intreccia sport, storia e memoria collettiva: attraverso il suo inconfondibile stile narrativo, Buffa trasforma i Giochi di Berlino 1936 in un affresco teatrale che parla di uguaglianza, resistenza e dignità umana.
Lo spettacolo, partendo dalla narrazione di una delle edizioni più controverse dei Giochi Olimpici, quella del 1936, racconta una storia di sport e di guerra. Le storie dello sport sono storie di uomini. Sono storie che scorrono assieme al tempo dell’umanità, seguono i cambiamenti e i passaggi delle epoche, a volte li superano.
È capitato a Berlino nel ‘36 quando Hitler e Goebbels volevano trasformare le loro Olimpiadi, o quello che credevano che fossero le “loro” Olimpiadi, nell’apoteosi della razza ariana e del “nuovo corso”. E invece quelle Olimpiadi costruirono i simboli più luminosi dell’uguaglianza: il primo giorno di gara sul podio del salto in alto salirono due atleti neri, l’ebrea Helene Mayer vinse l’oro nella scherma e Jesse Owens di medaglie ne vinse addirittura quattro.
E poi, mentre in quella calda estate del ’36 il mondo assisteva in colpevole silenzio alla tragedia della guerra civile spagnola e la pace scricchiolava sull’asse Roma Berlino Tokyo, il coreano Sohn Ki-Chung vinceva la maratona di Berlino, ma aveva un peso sul cuore e sul podio non alzò mai lo sguardo. Sohn era costretto a competere non per la Corea ma come maratoneta per il Giappone, che aveva colonizzato il suo paese nel 1910. Per la sua vittoria fu innalzata non la bandiera coreana, ma quella giapponese e fu l’inno giapponese a essere cantato nello stadio.
Lo spettacolo racconta le storie all’interno di un luogo senza tempo, un luogo dimenticato, sospeso tra il sogno e la realtà. Le racconta con le parole di chi c’era in quei giorni esaltanti e tremendi, le racconta con lo stile narrativo incalzante di Federico Buffa, le racconta con la musica e le canzoni evocative di un’epoca in bilico tra il sogno e la tragedia, le racconta con le immagini “rivoluzionarie” di Leni Riefensthal, “la regista che filmò il nazismo”.
27 | 30 ottobre ore 21
L’È EL DÌ DI MORT, ALEGHER
NAVIGLI E TRINCEE
STORIE E CANZONI DELLA GRANDE GUERRA
Da Delio Tessa, Carlo Salsa, Emilio Lussu, Enzo Jannacci, Boris Vian, Corrado Alvaro
Con Marco Balbi e Paolo Bessegato
Alla fisarmonica Riccardo Dell’Orfano
Musiche arrangiate e dirette da Alessandro Nidi
Costumi Pamela Aicardi
Produzione Tieffe Teatro
Uno spettacolo di narrazione, musica e memoria
Due attori, un tavolo condiviso con il pubblico, le voci dissidenti di poeti e soldati, la musica che attraversa il dolore con ironia e resistenza. L’è el dì di mort, alegher è un viaggio intimo e collettivo nella memoria della Grande Guerra, dove le parole e le note diventano strumenti per raccontare l’assurdità della tragedia e la fragile umanità di chi l’ha vissuta.
Delio Tessa guida questo percorso con il suo poema Caporetto 1917, un affresco lirico e surreale di una Milano scossa dagli echi del fronte, in cui il tragico e il comico si mescolano in un canto di resistenza poetica. Accanto a lui, le voci di Emilio Lussu, Carlo Salsa, Corrado Alvaro, Enzo Jannacci, Boris Vian e altri testimoni di un’epoca che continua a parlarci.
Tra lettere, canti popolari, versi dissacranti e immagini d’archivio, lo spettacolo – interpretato da Marco Balbi ed Enrico Ballardini – costruisce una drammaturgia corale che chiama in causa lo spettatore, invitato a partecipare non solo emotivamente ma fisicamente, seduto accanto agli attori, per un’esperienza teatrale che unisce il rito, il ricordo e la convivialità.
Un minestrone caldo, un bicchiere di vino, e il desiderio di restare umani anche nella disfatta: L’è el dì di mort, alegher! è un brindisi malinconico alla memoria, un gesto di resistenza poetica contro ogni guerra.
27 | 30 ottobre ore 19.30
CAUSA DI BEATIFICAZIONE
TRE CANTI PER VOCE E TEMPESTA
MASSIMO SGORBANI
Drammaturgia Massimo Sgorbani
Regia, video, luci e musiche Rajeev Badhan
Con Elena Strada, Sofija Zobina e in video Isabella Nefar
Produzione SlowMachine con il sostegno di MIBACT e Regione del Veneto
A dieci anni dalla creazione del “Primo Canto”, debutta in forma compiuta CAUSA DI BEATIFICAZIONE – Tre canti per voce e tempesta, nuova produzione firmata da Rajeev Badhan, su testo di Massimo Sgorbani. Un’opera che non si limita a raccontare, ma trasfigura la narrazione in un’esperienza immersiva e multimediale, fondendo teatro, cinema e performance live in una potente partitura scenica.
“Ho voluto costruire un cast che rispecchiasse un approccio multidisciplinare alla recitazione e che rispecchiasse un mondo multiculturale come quello in cui viviamo e che il teatro italiano fatica ad accettare.” – Rajeev Badhan
Video in tempo reale, immagini cinematografiche, suono spazializzato, corpi in scena e drammaturgia visiva si intrecciano per dare voce a tre destini femminili attraversati da martirio, fede e guerra. Il palcoscenico diventa un dispositivo sensoriale dove la tecnologia non accompagna, ma dialoga, contrasta e si fonde con la materia viva del teatro. Un linguaggio ibrido, sospeso tra sacro e profano, visione e realtà.
Tre canti. Tre donne. Una sola tempesta.
Primo Canto – Una donna ispirata alle mistiche Angela da Foligno e Veronica Giuliani canta l’estasi della fede e il tormento del corpo. Le immagini si fanno carne, la voce si trasfigura in luce e suono.
Secondo Canto – Una donna kosovara attende, sopravvive, si offre. La guerra è lontana; eppure, dentro: il video moltiplica lo sguardo, frammenta il presente, costruisce una geografia dell’assenza.
Terzo Canto – Una donna palestinese, sterile, diventa santa attraverso il sacrificio. Il suo gesto esplode nella materia video che la eleva, la dissolve, la condanna e la beatifica.
Un’opera lirica e performativa, che riflette su santità, violenza e identità femminile in un mondo che divora e trasfigura.
credit foto Roberto De Biasio
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0










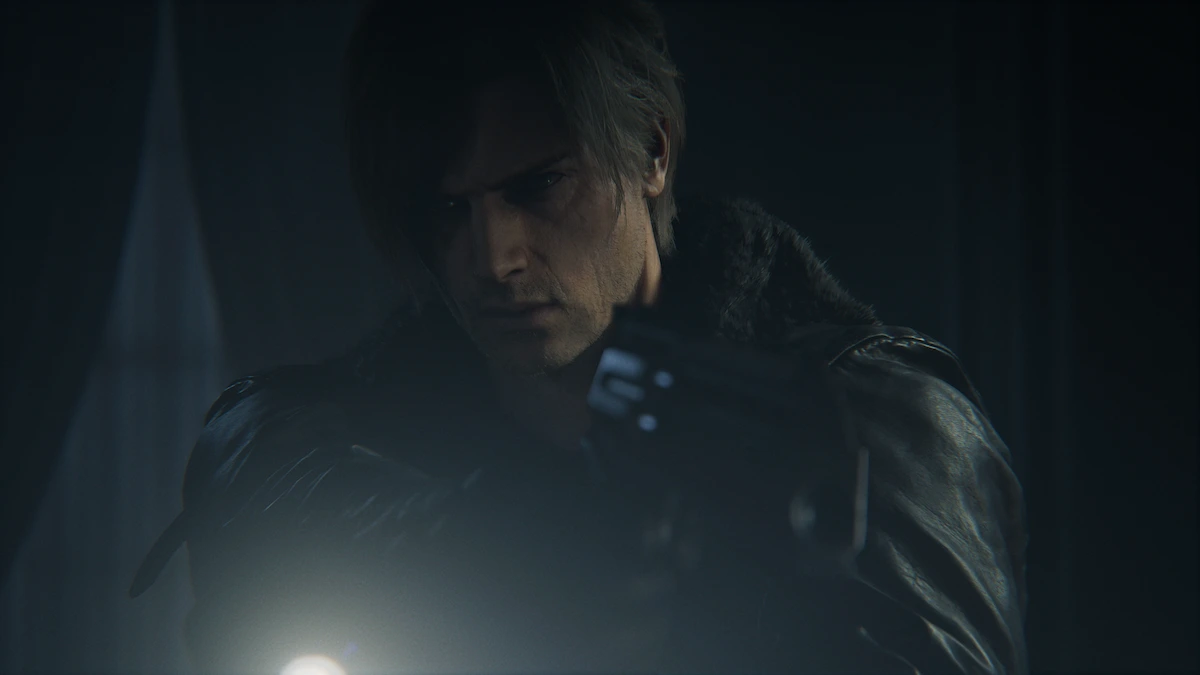
























![Mondiale WRC 2026. Nel bene e nel male sarà stagione cruciale. Allora, vogliamo essere seri? [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48295138/1200x/si202510171702.jpg)



























 Fonderie Ariotti S.p.a.-U88165282343aAr-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)



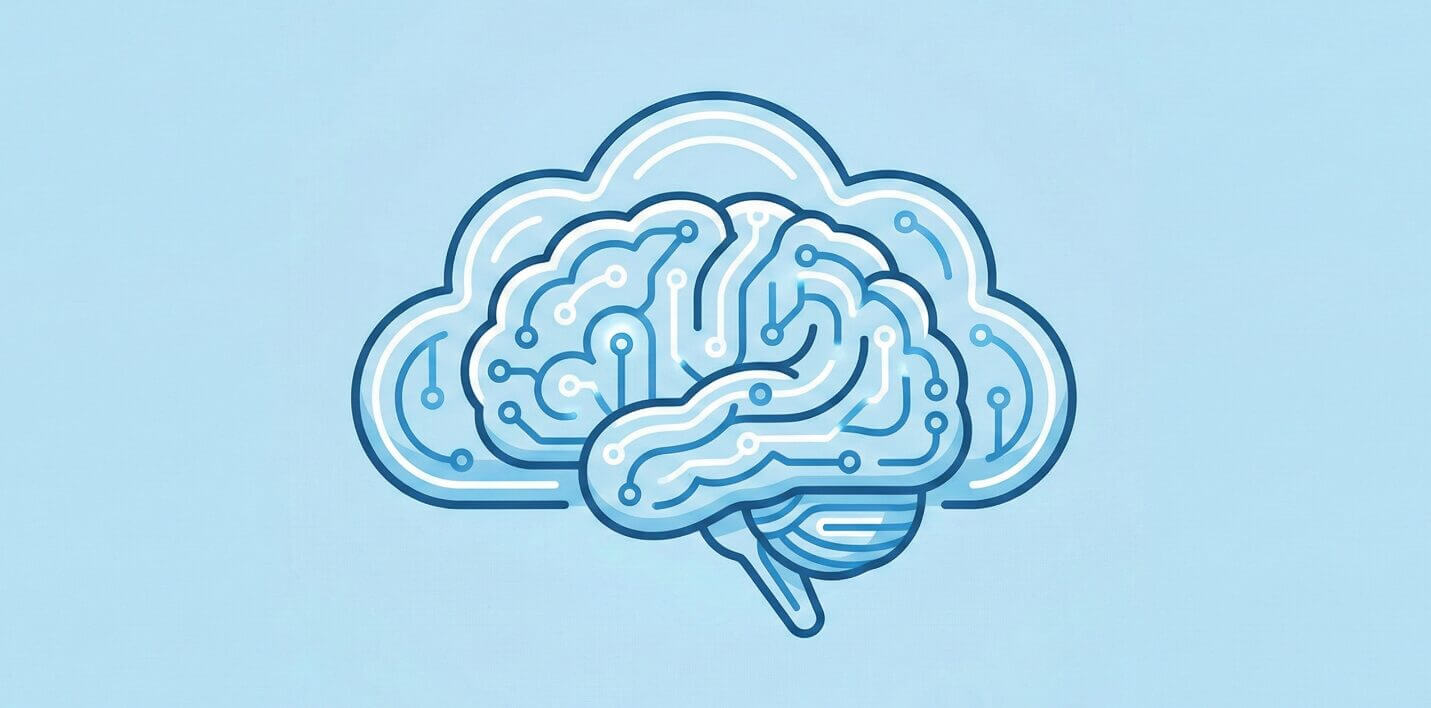











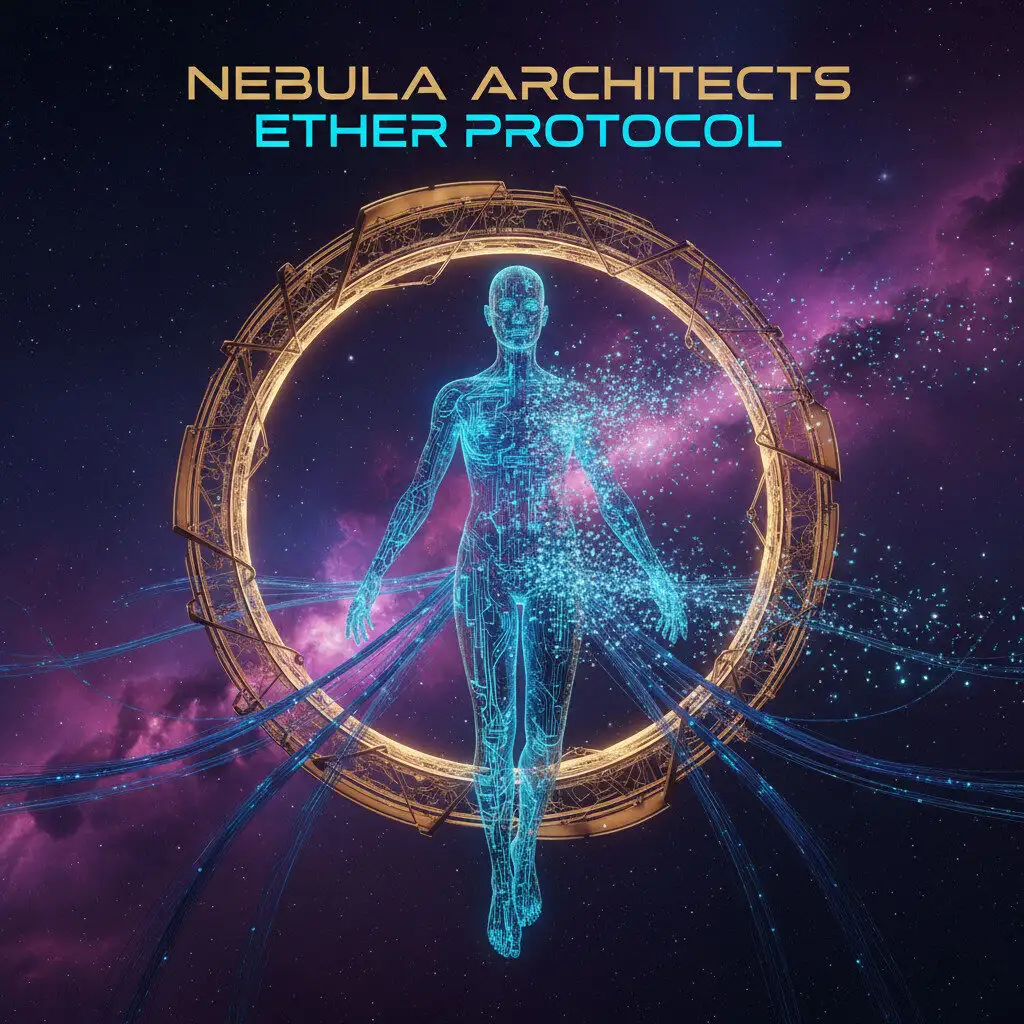



/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/offerte-attuale-coinbase-incredibile-approfittane-subito.jpg)























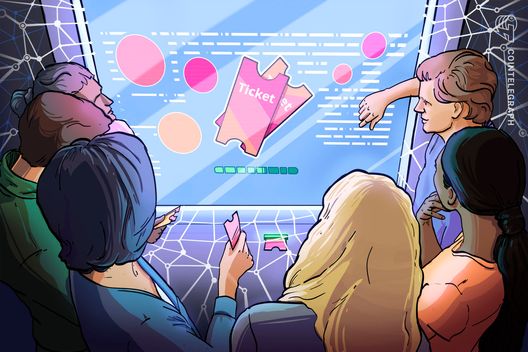






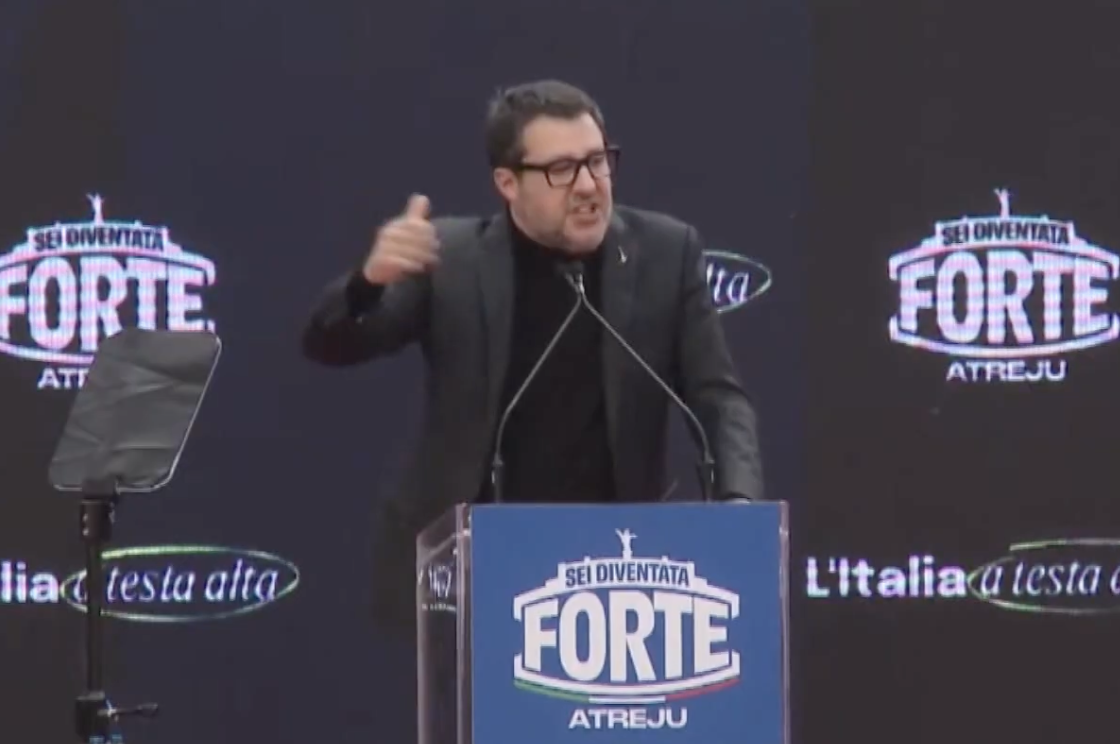












































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)