Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali: il parere del TAR

lentepubblica.it
Una recente pronuncia giuridica, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, evidenzia la piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali.
La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens [1].
Il principio del tempus regit actum
È noto che il principio tempus regit actum postula che la legittimità di un provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, a nulla rilevando che la pregressa disciplina fosse differente, stante l’esigenza di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo ius superveniens [2].
Il precipitato porta a ritenere che la corretta applicazione del principio generale tempus regit actum impone che gli atti ed i provvedimenti della PA, essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico [3].
In termini diversi, nella decisione le norme applicabili sono quelle vigenti al momento della conclusione del procedimento e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.
Il succitato principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l’Amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa [4].
Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio.
Tali conclusioni restano ferme anche laddove l’Amministrazione non rispetti il termine finale di conclusione del procedimento, poiché essa conserva comunque il potere di provvedere anche dopo lo spirare di tale termine, sicché le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento finale debbono essere osservate, proprio in adesione al principio del tempus regit actum [5].
Le norme regolamentari
Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi [6].
Fatto
Nella sua essenzialità un operatore economico impugna, chiedendone l’annullamento, la deliberazione di Consiglio comunale con la quale viene adottato un regolamento e disciplinare tecnico sul ripristino del suolo comunale in seguito a manomissioni da parte di soggetti terzi, nonché la comunicazione di archiviazione qualora l’interessato non provvedeva a integrare l’istanza (già) presentata (e autorizzata) da apposita cauzione (a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, importo calcolato in base ai mq. interessati allo scavo e al suo completo ripristino “a regola d’arte”) prevista a seguito dell’entrata in vigore del cit. regolamento.
Merito
Il ricorso viene ritenuto infondato, aderendo all’orientamento giurisprudenziale [7], riferito alla potestà regolamentare degli Enti locali in materia di occupazione del suolo pubblico ed autorizzazioni per manomissioni stradali, disciplina degli scavi e ripristino del suolo da parte di concessionari di servizi pubblici, secondo il quale:
- l’adozione di normativa regolamentare comunale successiva alla stipula di convenzioni di concessione non configura violazione del principio di irretroattività né illegittima modificazione unilaterale del rapporto concessorio, trovando applicazione il principio tempus regit actum;
- le concessioni costituiscono rapporti di durata soggette alla disciplina di volta in volta introdotta dall’Ente concedente nell’esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite e il Comune, ai sensi dell’art. 117, sesto comma della Costituzione e del comma 1, dell’art. 13, Funzioni, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’assetto ed utilizzazione del territorio;
- la norma regolamentare successiva prevale su quella pattizia precedente sia per il criterio cronologico sia in ossequio al principio di gerarchia delle fonti del diritto;
- la potestà regolamentare esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del primo comma dell’art. 13, Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione, della legge 241/1990, ove non viene prevista una sorta di “eccezione della eccezione” per taluni soggetti che svolgono pubblici servizi [8];
Sulla base di quanto affermato:
- trova applicazione ordinaria il principio tempus regit actum, dal momento che la nuova normativa comunale non agisce retroattivamente su situazioni giuridiche già compiutamente definite ed acquisite ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori secondo lo ius superveniens;
- i depositi cauzionali, previsti dal regolamento comunale, non violano il principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. («nessuna prestazione patrimoniale o personale può̀ essere imposta se non in base alla legge») in quanto il comma 9, dell’art. 27, Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) prevede espressamente tale possibilità per l’Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori («L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale») [9], e, quindi, l’Ente locale non ha istituito alcun tipo di entrata a proprio favore, essendo prevista espressamente in via legislativa [10];
- la fonte regolamentare non viola il principio di proporzionalità, risultando adeguatamente motivate dall’esigenza di garantire sicurezza della circolazione stradale e incolumità pubblica, non configurandosi manifesta irragionevolezza o palese sproporzionalità delle misure adottate nell’esercizio della discrezionalità tecnico – amministrativa;
- le sanzioni previste dal regolamento in caso di violazione rispettano pienamente il principio di legalità, essendo già previste dalla normativa vigente – senza introdurre fattispecie sanzionatorie autonome – anche ai sensi dell’art. 21, Opere, depositi e cantieri stradali, del Codice della Strada («Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma»), osservando che ai fini dell’applicabilità della disciplina non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del Codice della strada [11].
Canone concessorio e deposito cauzionale
Neppure si può affermare che siamo in presenza di una doppia imposizione tributaria vista la coesistenza tra canone di occupazione di suolo pubblico e deposito cauzionale, trattandosi di istituti ontologicamente diversi:
- il primo costituisce corrispettivo sinallagmatico correlato al sacrificio imposto alla collettività per la privazione del bene pubblico [12], costituisce per l’ente pubblico proprietario del terreno una entrata patrimoniale (e non tributaria) che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio, concesso contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi [13];
- il secondo è strumentale a garantire l’escussione di penalità contrattuali correlate a danni eventualmente causati da non corretta esecuzione delle prestazioni, con una evidente funzione di liquidare in via preventiva e anticipata il danno da inadempimento contrattuale (pregiudizio che potrebbe scaturire da cattiva esecuzione dei lavori, oppure da eventuali danni materiali arrecati alle strutture ed ai beni della collettività).
Sintesi
Le situazioni giuridiche durevoli nel tempo restano soggette, per il periodo successivo alla formazione dell’atto amministrativo da cui esse scaturiscono, allo ius superveniens, trovando dunque applicazione la normativa generale vigente ratione temporis, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo, in quanto la disciplina regolamentare sopravvenuta incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel tratto che si svolge successivamente all’adozione dell’atto amministrativo che ne legittima l’esistenza, sulla base di una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica stessa.
Il deposito cauzionale risulta legittimo anche se definito con norma regolamentare successiva all’autorizzazione; deposito che trova titolo giuridico direttamente nella fonte primaria.
Osservazioni
Invero, senza volere entrare oltre, risulta pienamente legittima la richiesta di un deposito cauzionale prima di eseguire i lavori di scavo, sia solo per tutelare il demanio pubblico da danneggiamenti causati da “rattoppi” approssimativi (causa erosiva e proiezione di buche, insidie e trabocchetti) che concorrono ad aumentare i costi delle manutenzioni delle strade comunali, a spese dei cittadini e non degli esecutori di servizi pubblici, non potendo invocare esoneri in presenza di particolari scavi, assicurati da discipline di favor per le telecomunicazioni.
In effetti, l’Amministrazione agirebbe non con i poteri pubblicistici ma quale soggetto proprietario del bene, a cui spetta una garanzia dal rimanere indenne a fronte di prestazione di terzi sul proprio patrimonio, in presenza di un obbligo (onere) di passaggio, aspetto affrontato dal comma 6, dall’art. 54, Divieto di imporre altri oneri, del Codice delle comunicazioni elettroniche («Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale»).
Tuttavia, sul punto, il comma 3, dell’art. 12, Disposizioni di coordinamento, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha fornito una lettura alquanto precisa: «l’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
Alla luce del quadro interpretativo e normativo, supporre che alcuni operatori godano di diritti di supremazia rispetto ad altri operatori di servizi pubblici violerebbero i principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione, ma soprattutto esporrebbe l’Ente locale ad evidenti costi aggiuntivi a carico dei propri bilanci per lavori non eseguiti correttamente, imponendo l’attivazione di rimedi giudiziari per recuperare il pregiudizio (ristoro dei danni), evitabile con un deposito cauzionale: un rischio, secondo le sequenze statistiche, altamente probabile [14].
Chiosa (chi osa), a fronte di tali circostanze, l’uomo qualunque (cultura di genere) penserebbe: «è meglio godere della ricchezza dei sentimenti che del lusso dei vestiti» [15].
Note
[1] La legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269; sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900). Il principio del tempus regit actum, attinente alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848), con conseguente: irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi; non rilevando invece l’eventuale diversa situazione fattuale e giuridica dell’epoca della presentazione dell’istanza, e ciò anche laddove la PA si sia pronunciata tardivamente, rispetto al termine ordinamentale fissato per la conclusione del procedimento, LUCCA, Il principio tempus regit actum, gruppodelfino.it, 24 marzo 2025.
[2] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2022, n. 4223; sez. II, 8 marzo 2021, n. 1908; sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768; sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5154; sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 741; sez. V, 16 aprile 2019, n. 2498.
[3] TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 marzo 2025, n. 501.
[4] Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7550.
[5] Cons. Stato, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422.
[6] Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7797 e 2 novembre 2017, n. 5071.
[7] Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627, si chiarisce che le concessioni costituiscono rapporti di durata e, come tali, sono sottoposte alla disciplina di volta in volta introdotta. Infatti, una volta costituito il rapporto concessorio quest’ultimo resta comunque assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del sevizio da svolgere in concessione, non potendo richiamarsi al principio dell’art. 11 preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’Amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, bensì detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.
[8] La circostanza che taluni individui si trovino in posizione particolare, come i gestori dei servizi pubblici, non è idonea a trasformare la posizione di detti individui in quella di diretti destinatari della norma regolamentare, in quanto la loro posizione soggettiva rimane quella propria dei destinatari di un atto amministrativo generale e come tali non legittimati a pretendere di essere destinatari di una comunicazione di avvio del procedimento, Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2024, n. 2854. le disposizioni dettate dal legislatore in materia di partecipazione al procedimento non possono trovare applicazione in caso di atti amministrativi generali, TAR Molise, Campobasso, sez. I, 17 aprile 2023, n. 121.
[9] TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 giugno 2013, n. 1541, si tratta di norma di carattere generale, riferibile a ogni ipotesi di lavoro interessante strade, autostrade e relative pertinenze, ambito rispetto al quale, dunque, in radice non si pone il problema della violazione dell’art. 23 Cost.; inoltre, non sembra essere una prestazione “imposta”, costituendo essa l’oggetto non di un obbligo – posizione giuridica appunto ricollegabile, sul piano passivo, a una imposizione- ma, piuttosto, di un onere, al cui adempimento la parte in tanto si determina in quanto, e solo in quanto, abbia interesse a conseguire un certo vantaggio.
[10] Vedi, TAR Campania, Napoli, sez. III, 1° settembre 2025, 6035, è stato ritenuto che l’Ente locale non ha il potere di imporre attraverso una fonte normativa secondaria il pagamento di una somma di denaro ex ante imposta quale condizione al rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo comunale da parte del concessionario (c.d. diritto di scavo); una siffatta richiesta sarebbe legittima esclusivamente nel caso in cui operasse ex post, all’esito dei lavori e, correttamente quantificata caso per caso, quale corrispettivo a danni o disagi connessi alla manomissione stessa.
[11] Cass. civ., sez. II, ordinanza, 5 giugno 2018, n. 14367.
[12] Il pagamento del canone è un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell’ente pubblico per scopi commerciali con fini di lucro, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1655; 25 novembre 2022, n. 10382. Tali sentenze richiamano a loro volta, sul punto: Corte. cost., sentenza 14 marzo 2008, n. 64: un corrispettivo sinallagmatico alla misura dell’area concessa rapportato, tra l’altro, al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata dal godimento del bene.
[13] Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2023, n. 9450.
[14] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2025, 2034, secondo il quale l’art. 54 del d.gs. n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, e il successivo (Decreto Fibra), non precludono agli Enti locali la facoltà di richiedere agli operatori di telecomunicazioni la prestazione di fideiussioni o garanzie per assicurare la corretta esecuzione dei lavori di ripristino di suolo pubblico coinvolto da interventi di installazione e manutenzione, essendo tale richiesta una misura necessaria e proporzionata a tutela del patrimonio pubblico. Vi è doverosamente un obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi e di ripristinare tali aree a regola d’arte, non limitandosi alla sola posa degli impianti ma considerando anche le future possibilità d’intervento dell’Ente proprietario o gestore sul bene interessato, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2024, n. 10126.
[15] BALZAC, Il colonello Chabert, 1832.
The post Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali: il parere del TAR appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































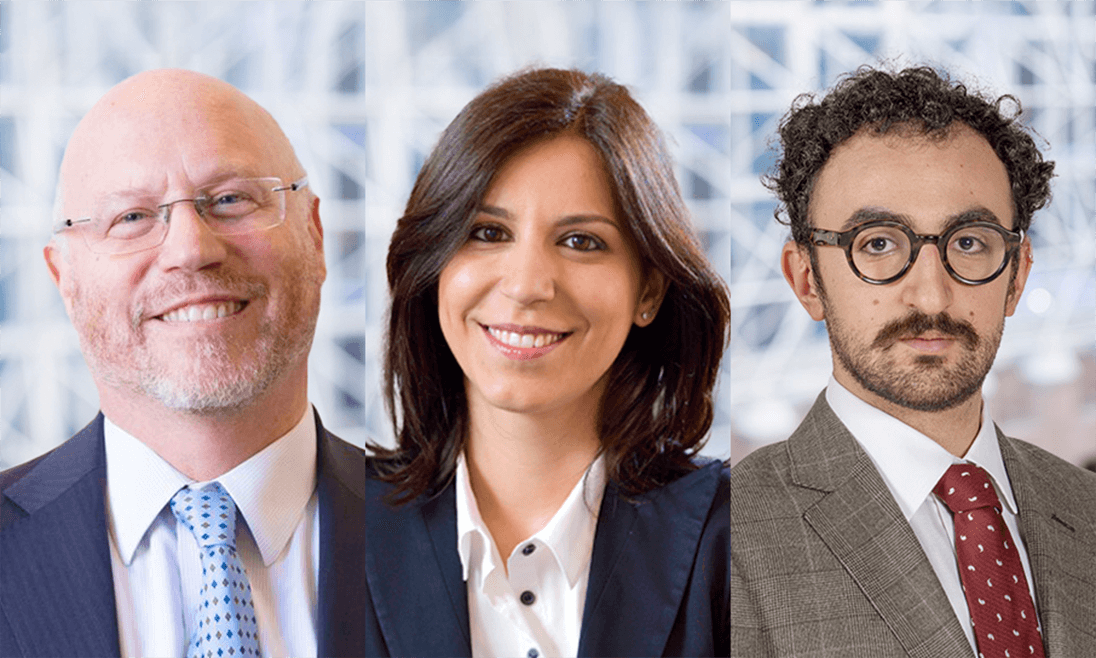


















































































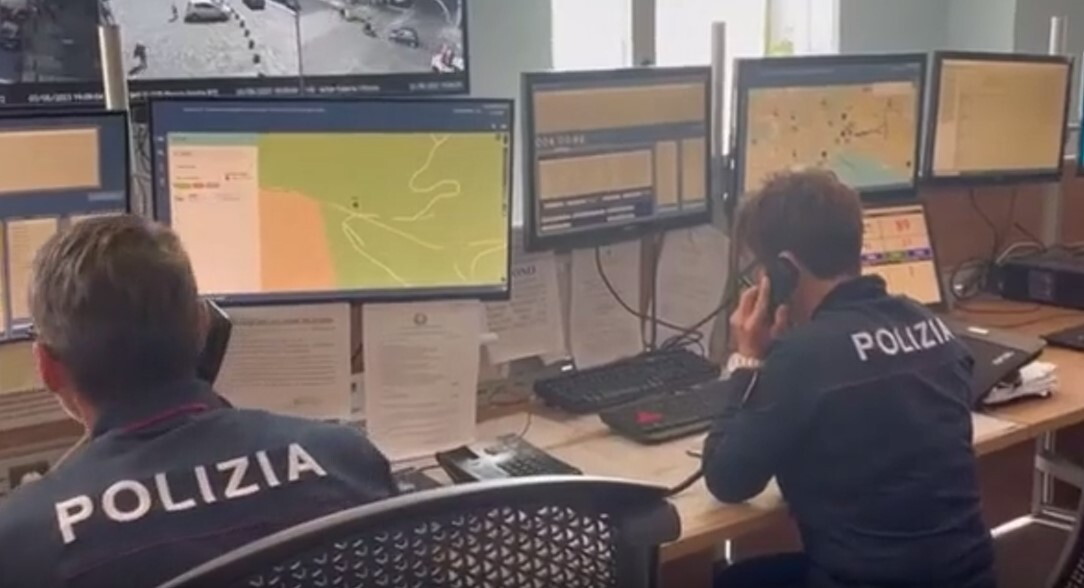
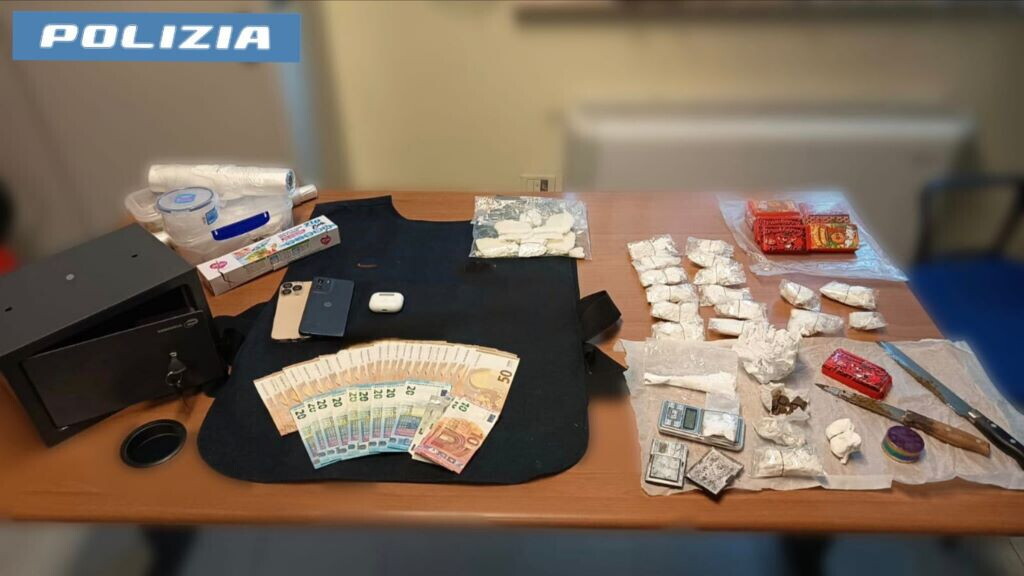
































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































