Clima, Paesi Ue trovano accordo sul target 2040 dopo un negoziato lungo un giorno e una notte

Bruxelles – Un giorno e una notte. Tanto è durata la trattativa tra i ministri competenti dei Ventisette Paesi dell’Unione europea per raggiungere un accordo sulla modifica della legge europea sul clima, introducendo un obiettivo climatico intermedio vincolante per il 2040 di riduzione del 90 per cento delle emissioni nette di gas serra (Ghg) rispetto ai livelli del 1990. Un passo “fondamentale” per Bruxelles per confermare e consolidare il cammino dell’Unione verso la neutralità climatica a metà secolo.
Per trovare la quadra, però, il testo inizialmente proposto dalla Commissione europea a luglio ha subìto non pochi interventi, così da accogliere quanto più possibile le diverse sensibilità delle capitali e incassare almeno il via libera della maggioranza qualificata necessaria dei Paesi, ovvero 15 Stati (il 55 per cento sui Ventisette) rappresentanti il 65 per cento della popolazione Ue. Alla fine, il testo è stato appoggiato da 21 Paesi. Contrari sono stati Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca (in pratica il ritorno del Gruppo di Visegrad, dopo un lungo tempo di sfilacciamento). Astenuti – posizione che equivale a voto contrario – Belgio e Bulgaria. Soddisfatta l’Italia, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che in un punto stampa definisce “buono” l’accordo raggiunto e parla di istanze italiane raccolte. “Abbiamo approvato sia la legge clima che l’Ndc (il contributo determinato a livello nazionale) per la Cop30. Devo dire che è stata una trattativa intensa e la Commissione ha riconosciuto che le distanze che portavamo avanti come Italia – e come gruppo di Paesi uniti all’Italia – erano rilevanti ed erano importanti, equilibrate”, sottolinea. Tra queste, lo slittamento di un anno dell’Ets2, il riferimento ai biocarburanti, l’innalzamento dal 3 per cento al 5 per cento dei crediti internazionali di carbonio, l’apertura, nella fase di revisione da parte della Commissione, all’uso di un’ulteriore quota di crediti internazionali, fino al 5 per cento del contributo nazionale. “Pertanto si è trovato un buon accordo” ed “è un compromesso buono”, incalza.
Il lavoro, però, non si conclude qui: per arrivare a una versione definitiva della legislazione, il Consiglio e il Parlamento dovranno negoziare, nel cosiddetto trilogo, partendo dai rispettivi testi concordati internamenti. Con il documento avallato oggi dai Paesi, la presidenza danese del Consiglio dell’Ue è pronta ad iniziare le trattative. E a breve lo sarà anche il Parlamento che voterà la sua posizione prima in commissione Ambiente lunedì prossimo 10 novembre e, poi, avrà il passaggio in aula plenaria o nella mini sessione del 13 novembre a Bruxelles o nella sessione a Strasburgo tra il 24 e il 27 novembre.
Il Consiglio ha mantenuto l’obiettivo vincolante di riduzione del 90 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 proposto dalla Commissione. Tuttavia, ha apportato alcune modifiche per riflettere le preoccupazioni sulla competitività dell’Ue, la necessità di una transizione giusta e socialmente equilibrata, l’incertezza legata agli assorbimenti naturali e le diverse circostanze nazionali degli Stati membri. Tutti cambiamenti che sono stati guidati dagli orientamenti strategici forniti dai leader dell’Ue nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 23 ottobre 2025 a cui proprio i ministri dell’Ambiente avevano spedito le questioni spinose della materia. Di fatto, il Consiglio ha ampliato le flessibilità che la Commissione tratteggiava nella sua proposta iniziale. In particolare, sulle quote dei crediti internazionali, sulla loro data di avvio, sul posticipo dell’Ets2, sulla revisione della Commissione europea, sulla possibilità di utilizzo di un uso aggiuntivo di crediti intenazionali pari al 5 per cento dello sforzo nazionale, sugli assorbimenti naturali di carbonio, sui biocarburanti.
Ad esempio sulla raccolta in Paesi extra Ue di una parte della riduzione delle emissioni, con i crediti internazionali di carbonio di alta qualità, per fornire un “contributo adeguato” al raggiungimento dell’obiettivo del 2040. Qui, i Paesi innalzano la percentuale al 5 per cento delle emissioni nette dell’Ue del 1990 – invece del 3 per cento proposto dalla Commissione. Questo meccanismo scatterà a partire dal 2036, come delineato dall’esecutivo Ue, ma viene incluso dal Consiglio un periodo pilota per il periodo 2031-2035. Su come funzioneranno tecnicamente questi crediti internazionali la Commissione europea presenterà una proposta che dovrà fare luce sui diversi aspetti, in particolare quello del finanziamento di tali crediti. Inoltre, per raggiungere l’obiettivo del 2040, si dovrà tenere conto del ruolo dei carburanti a zero, basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compreso il trasporto su strada oltre il 2030, e di misure concrete per aiutare i produttori di veicoli pesanti a raggiungere i loro obiettivi, tenendo conto dei contenuti europei.
Viene riconosciuto “il contributo realistico degli assorbimenti di carbonio allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze degli assorbimenti naturali”, cioè quelli di foreste e uso del suolo, “e garantendo che eventuali carenze non vadano a scapito di altri settori economici, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di utilizzare gli assorbimenti naturali in eccesso per compensare le proprie emissioni in altri settori”. In questo contesto, viene inserito un freno d’emergenza, perché la Commissione valuterà come modificare la pertinente legislazione dell’Unione per raggiungere l’obiettivo climatico del 2040, “tenendo conto anche della diminuzione della capacità di assorbimento naturale”. Perciò tale considerazione potrà anche far rivedere il target.
L’accordo del Consiglio prevede, poi, che la Commissione valuti e riferisca ogni due anni “in merito all’attuazione degli obiettivi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici e dell’evoluzione delle sfide e delle opportunità per la competitività globale dell’Ue”. Tale valutazione potrà essere corredata, se del caso, da proposte legislative. Inoltre, i Paesi chiedono che la Commissione faccia, ogni 5 anni, una revisione – elemento già previsto dalla legge sul clima – in cui tenga conto “delle sfide e delle opportunità in continua evoluzione per la competitività globale delle industrie europee negli Stati membri, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle piccole e medie imprese”. In questo contesto, la Commissione potrà rivedere anche l’obiettivo intermedio per il 2040 e inserire misure aggiuntive per rafforzare le iniziative relative al quadro di sostegno, anche alla luce dello stato degli assorbimenti netti a livello Ue in relazione a quanto sarebbe necessario per l’obiettivo del 2040 e tenendo conto anche dell’evoluzione dei prezzi dell’energia e del loro impatto su industrie e famiglie. Nel contesto della revisione, viene anche inclusa la clausola richiesta dall’Italia di poter usufruire di una flessibilità aggiuntiva, che prevede che i Paesi possano utilizzare crediti internazionali di alta qualità per realizzare fino al 5 per cento dei propri obiettivi e sforzi post-2030. Si tratta, dunque, di un quantitativo nazionale, non europeo, e volontario. Infine, tra gli altri elementi di novità, c’è il posticipo di un anno, dal 2027 al 2028, l’entrata in vigore del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue per edifici e trasporti su strada, l’Ets2.
Infine, i Paesi hanno aggiornato il contributo determinato a livello nazionale (Ndc) dell’Ue, in base all’Accordo di Parigi, da presentare alla Cop30 in partenza a Belém, in Brasile: hanno confermato la forbice già esplicitata a settembre di taglio delle emissioni compreso tra il 66,25 per cento e il 72,5 per cento per il 2035. “Con l’adozione dell’Ndc dell’Ue, inviamo un forte segnale in vista della Cop30: rimaniamo pienamente impegnati a mantenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Questo ci consente di promuovere una maggiore azione globale per il clima, quando incontreremo il resto del mondo alla Cop30”, ha commentato Lars Aagaard, ministro per il Clima, l’Energia e i Servizi pubblici della Danimarca, Paese che ricopre il semestre di presidenza del Consiglio dell’Ue.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























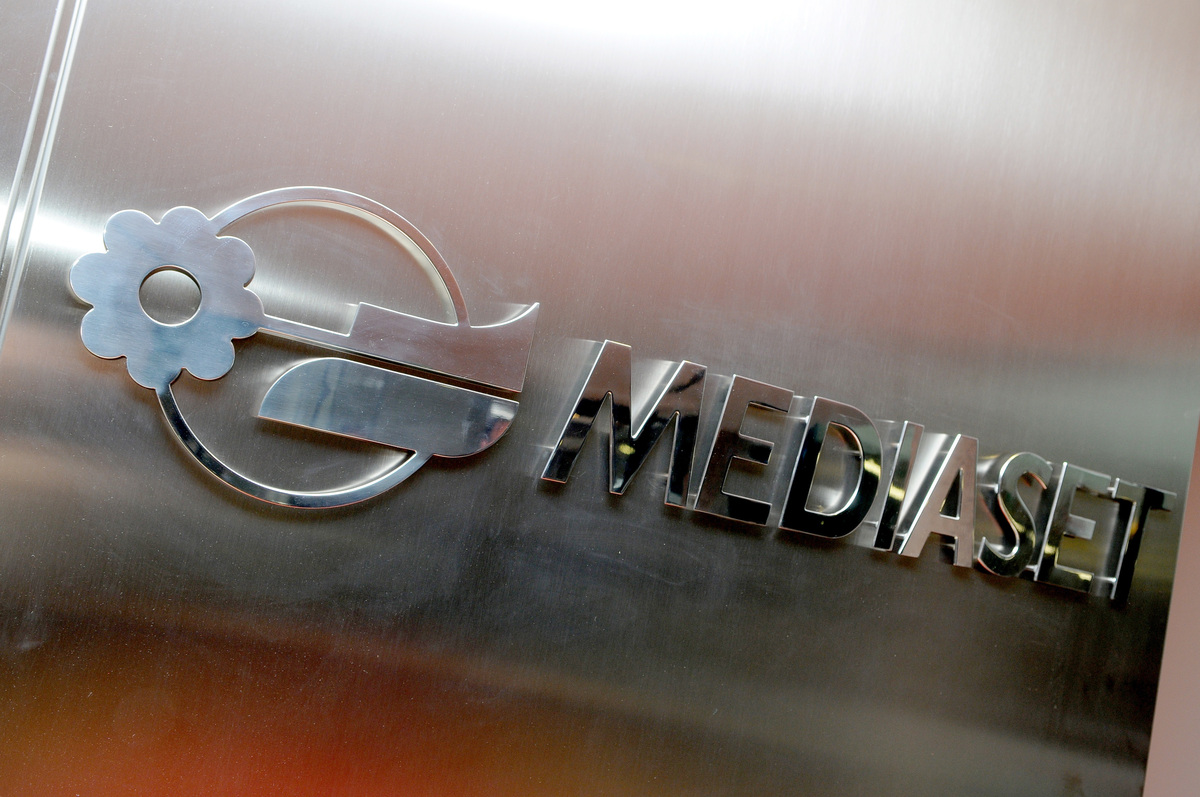



























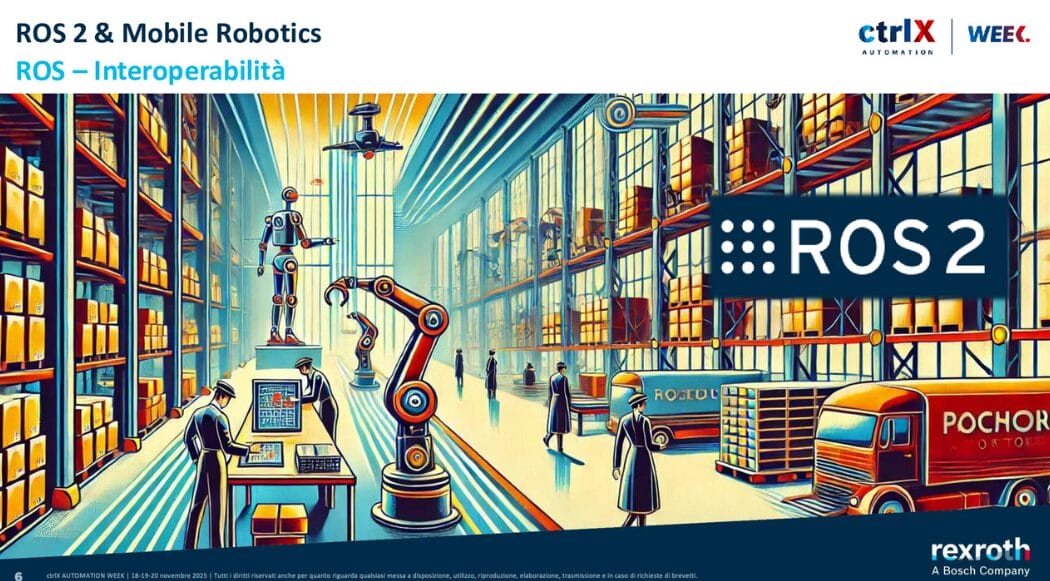











































































































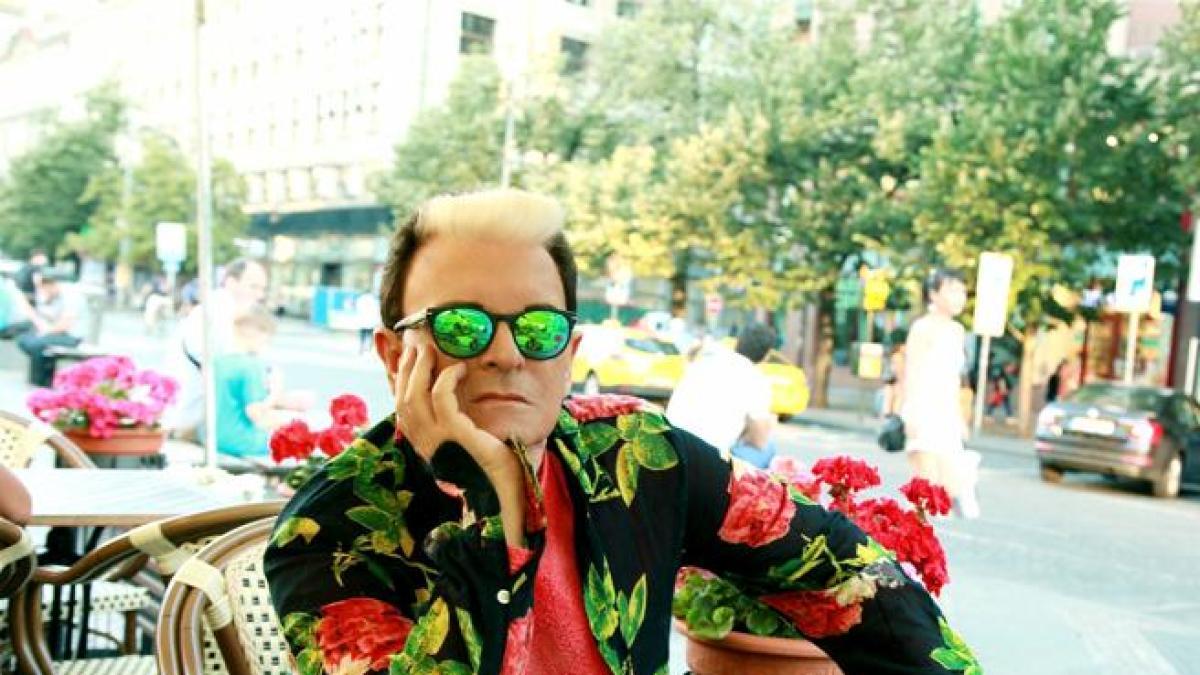

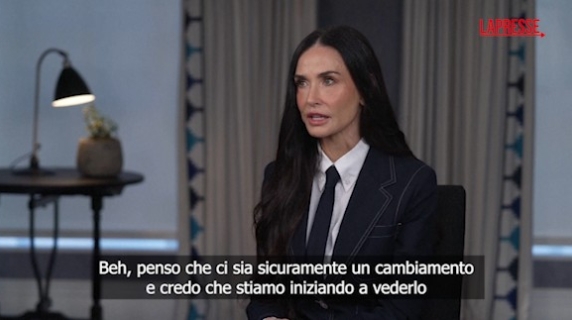




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































