Dying Light The Beast Recensione


 A dieci anni dall’uscita del primo Dying Light, Techland prova a rimettere ordine nella sua creatura con Dying Light The Beast. Un titolo che, già dalla sua genesi, racconta molto del suo DNA: nato come espansione, cresciuto come esperimento e infine promosso a capitolo principale.
Non è un dettaglio da poco, perché spiega bene il tipo di avventura che ci troviamo davanti: meno dispersiva rispetto a Dying Light 2, più compatta, più “carnale” nel suo essere action survival, e con un volto che i fan storici non dimenticheranno mai. Quello di Kyle Crane.
Ed è proprio qui che Techland fa la sua mossa più nostalgica, con Dying Light The Beast: riportare in scena l’eroe originale, sfigurato e corrotto da tredici anni di esperimenti in mano al Barone, ma ancora capace di correre, saltare e massacrare orde di non morti.
L’idea di un Crane trasformato in bestia, costretto a convivere con una rabbia che diventa gameplay, è la novità più significativa di un gioco che per il resto riprende con convinzione i canoni della serie: parkour, notti interminabili, combattimenti brutali e smembramenti a pioggia.
A dieci anni dall’uscita del primo Dying Light, Techland prova a rimettere ordine nella sua creatura con Dying Light The Beast. Un titolo che, già dalla sua genesi, racconta molto del suo DNA: nato come espansione, cresciuto come esperimento e infine promosso a capitolo principale.
Non è un dettaglio da poco, perché spiega bene il tipo di avventura che ci troviamo davanti: meno dispersiva rispetto a Dying Light 2, più compatta, più “carnale” nel suo essere action survival, e con un volto che i fan storici non dimenticheranno mai. Quello di Kyle Crane.
Ed è proprio qui che Techland fa la sua mossa più nostalgica, con Dying Light The Beast: riportare in scena l’eroe originale, sfigurato e corrotto da tredici anni di esperimenti in mano al Barone, ma ancora capace di correre, saltare e massacrare orde di non morti.
L’idea di un Crane trasformato in bestia, costretto a convivere con una rabbia che diventa gameplay, è la novità più significativa di un gioco che per il resto riprende con convinzione i canoni della serie: parkour, notti interminabili, combattimenti brutali e smembramenti a pioggia.
 La mappa, questa volta, abbandona l’urbanistica estesa di Villedor per portarci dentro Castor Woods, una riserva naturale che mescola boschi, montagne e un centro urbano più raccolto. Qui si consuma la vendetta di Crane, una storia che non sorprende per complessità o colpi di scena, ma che funziona come cornice per un’esperienza tutta sangue e sopravvivenza.
Se la narrativa principale pecca di banalità, le missioni secondarie e i piccoli enigmi ambientali aggiungono respiro, confermando la vocazione esplorativa della saga.
Dying Light The Beast è quindi un titolo che vive di contrasti: lineare ma stratificato, familiare ma con innesti inediti, spettacolare negli smembramenti quanto imperfetto nel sistema di combattimento. Eppure, al netto delle sue scivolosità, segna un ritorno alle origini che molti fan stavano aspettando.
La mappa, questa volta, abbandona l’urbanistica estesa di Villedor per portarci dentro Castor Woods, una riserva naturale che mescola boschi, montagne e un centro urbano più raccolto. Qui si consuma la vendetta di Crane, una storia che non sorprende per complessità o colpi di scena, ma che funziona come cornice per un’esperienza tutta sangue e sopravvivenza.
Se la narrativa principale pecca di banalità, le missioni secondarie e i piccoli enigmi ambientali aggiungono respiro, confermando la vocazione esplorativa della saga.
Dying Light The Beast è quindi un titolo che vive di contrasti: lineare ma stratificato, familiare ma con innesti inediti, spettacolare negli smembramenti quanto imperfetto nel sistema di combattimento. Eppure, al netto delle sue scivolosità, segna un ritorno alle origini che molti fan stavano aspettando.
Dying Light The Beast Recensione | Un ritorno alle origini
Il cuore pulsante di The Beast è Kyle Crane, o meglio ciò che resta di lui. Il protagonista del primo Dying Light, eroe spezzato da tredici anni di prigionia, diventa la perfetta incarnazione del tema del gioco: la perdita dell’umanità. Gli esperimenti del Barone lo hanno corrotto, costringendolo a convivere con poteri che lo rendono a metà uomo e a metà mostro. Questa trasformazione di Dying Light The Beast non è solo narrativa. È ludica, tangibile. La “modalità bestia” è il fulcro della nuova esperienza: una barra che, una volta caricata, consente di scatenare per pochi secondi una furia in grado di dilaniare zombie e nemici umani con una violenza quasi disturbante. Arti che volano, teste mozzate, corpi sbriciolati. È una delle novità più significative del gioco, anche se non esente da difetti: i movimenti risultano scivolosi, le hitbox a volte imprecise, e alcune animazioni sembrano più abbozzate che rifinite. Se la “bestia” è la novità, il parkour resta l’identità. Correre sui tetti, arrampicarsi sulle torri, saltare tra i rami di Castor Woods non ha perso un grammo di fascino. Anzi, rispetto a Stay Human, qui tutto sembra più rifinito: i comandi rispondono meglio, i movimenti sono più fluidi e il level design sfrutta a dovere dislivelli naturali e architetture urbane ridotte. In Dying Light The Beast, Castor Woods è una mappa meno vasta ma più densa. Ci sono villaggi da esplorare, grotte piene di segreti, zone contaminate da creature mutanti che alzano l’asticella della sfida. I rifugi sicuri da riattivare e i classici enigmi ambientali – leve da trovare, generatori da accendere, passaggi segreti da individuare – danno ritmo all’esplorazione, evitando la noia da “checklist” tipica di tanti open world.
Il sistema di progressione, poi, incentiva a spingersi sempre oltre. L’albero delle abilità si divide in quattro rami principali: mobilità, sopravvivenza, crafting e potere bestiale. Questo permette di modellare Crane secondo il proprio stile di gioco, rendendo ogni run leggermente diversa.
È inutile girarci intorno: Dying Light The Beast non inventa nulla nella struttura open world. Troviamo i soliti rifugi, le zone con difficoltà crescente, le torri da scalare. Però, diversamente da Dying Light 2, qui l’impianto risulta più coeso.
La campagna principale si completa in circa venti ore, ma il minutaggio può raddoppiare facilmente dedicandosi alle missioni secondarie. E sono proprio queste a sorprendere: piccole storie che, pur senza rivoluzionare la narrativa generale, aggiungono sfumature interessanti al mondo di gioco. A volte sono incontri con superstiti che raccontano la loro tragedia, altre volte sono indizi che portano a scoprire nuove chimere, gli esperimenti falliti del Barone.
In Dying Light The Beast, Castor Woods è una mappa meno vasta ma più densa. Ci sono villaggi da esplorare, grotte piene di segreti, zone contaminate da creature mutanti che alzano l’asticella della sfida. I rifugi sicuri da riattivare e i classici enigmi ambientali – leve da trovare, generatori da accendere, passaggi segreti da individuare – danno ritmo all’esplorazione, evitando la noia da “checklist” tipica di tanti open world.
Il sistema di progressione, poi, incentiva a spingersi sempre oltre. L’albero delle abilità si divide in quattro rami principali: mobilità, sopravvivenza, crafting e potere bestiale. Questo permette di modellare Crane secondo il proprio stile di gioco, rendendo ogni run leggermente diversa.
È inutile girarci intorno: Dying Light The Beast non inventa nulla nella struttura open world. Troviamo i soliti rifugi, le zone con difficoltà crescente, le torri da scalare. Però, diversamente da Dying Light 2, qui l’impianto risulta più coeso.
La campagna principale si completa in circa venti ore, ma il minutaggio può raddoppiare facilmente dedicandosi alle missioni secondarie. E sono proprio queste a sorprendere: piccole storie che, pur senza rivoluzionare la narrativa generale, aggiungono sfumature interessanti al mondo di gioco. A volte sono incontri con superstiti che raccontano la loro tragedia, altre volte sono indizi che portano a scoprire nuove chimere, gli esperimenti falliti del Barone.
 In cooperativa fino a quattro giocatori, poi, il titolo mostra il suo lato migliore. Coordinarsi per affrontare orde notturne o missioni più difficili trasforma l’esperienza in qualcosa di esaltante, capace di restituire quella sensazione di sopravvivenza condivisa che era stata un po’ persa nel secondo capitolo.
Il combattimento di Dying Light The Beast resta volutamente sporco e fisico. Le armi da mischia – mazze, machete, coltelli improvvisati – hanno un feedback soddisfacente, ma la vera differenza la fa la trasformazione in bestia. Le nuove abilità sbloccabili, come cariche devastanti o salti bestiali, arricchiscono il repertorio di Crane e introducono varianti utili nelle situazioni più caotiche.
In cooperativa fino a quattro giocatori, poi, il titolo mostra il suo lato migliore. Coordinarsi per affrontare orde notturne o missioni più difficili trasforma l’esperienza in qualcosa di esaltante, capace di restituire quella sensazione di sopravvivenza condivisa che era stata un po’ persa nel secondo capitolo.
Il combattimento di Dying Light The Beast resta volutamente sporco e fisico. Le armi da mischia – mazze, machete, coltelli improvvisati – hanno un feedback soddisfacente, ma la vera differenza la fa la trasformazione in bestia. Le nuove abilità sbloccabili, come cariche devastanti o salti bestiali, arricchiscono il repertorio di Crane e introducono varianti utili nelle situazioni più caotiche.
 La gestione della notte è sempre cruciale. Con il calare del sole emergono creature più aggressive, rapide e quasi inarrestabili. È qui che il titolo torna a essere davvero survival: ogni passo va pesato, ogni rifugio diventa un obiettivo vitale, ogni rumore può significare morte. Nonostante gli anni, quella sensazione di urgenza resta ancora oggi uno degli elementi più riusciti del franchise.
Non tutto però funziona: la modalità bestia, per quanto spettacolare, risulta a tratti imprecisa. Gli scontri possono diventare caotici al punto da perdere leggibilità, e il sistema di combattimento – volutamente rognoso – rischia a volte di frustrar più che coinvolgere.
Sul piano tecnico, il C-Engine di Dying Light The Beast dimostra ancora di avere qualcosa da dire. L’illuminazione globale dona profondità a scenari naturali e urbani, mentre i modelli dei personaggi sorprendono per dettagli e animazioni convincenti.
Ma è negli smembramenti che Dying Light The Beast dà il meglio con braccia, gambe e teste che saltano via con un realismo disturbante, trasformando ogni scontro in uno spettacolo splatter quasi compiaciuto.
Non mancano difetti: qualche glitch grafico, cali di frame sporadici e riflessi sull’acqua che cambiano in modo innaturale muovendo la telecamera. Niente che comprometta l’esperienza, ma abbastanza da ricordare che il titolo ha ancora bisogno di patch.
La colonna sonora pesca dalle atmosfere horror anni ’80, con temi cupi che si fondono perfettamente ai momenti di tensione. Il doppiaggio in inglese è solido, mentre pesa l’assenza del doppiaggio in italiano, che poteva rendere la narrazione più accessibile a un pubblico più ampio.
La gestione della notte è sempre cruciale. Con il calare del sole emergono creature più aggressive, rapide e quasi inarrestabili. È qui che il titolo torna a essere davvero survival: ogni passo va pesato, ogni rifugio diventa un obiettivo vitale, ogni rumore può significare morte. Nonostante gli anni, quella sensazione di urgenza resta ancora oggi uno degli elementi più riusciti del franchise.
Non tutto però funziona: la modalità bestia, per quanto spettacolare, risulta a tratti imprecisa. Gli scontri possono diventare caotici al punto da perdere leggibilità, e il sistema di combattimento – volutamente rognoso – rischia a volte di frustrar più che coinvolgere.
Sul piano tecnico, il C-Engine di Dying Light The Beast dimostra ancora di avere qualcosa da dire. L’illuminazione globale dona profondità a scenari naturali e urbani, mentre i modelli dei personaggi sorprendono per dettagli e animazioni convincenti.
Ma è negli smembramenti che Dying Light The Beast dà il meglio con braccia, gambe e teste che saltano via con un realismo disturbante, trasformando ogni scontro in uno spettacolo splatter quasi compiaciuto.
Non mancano difetti: qualche glitch grafico, cali di frame sporadici e riflessi sull’acqua che cambiano in modo innaturale muovendo la telecamera. Niente che comprometta l’esperienza, ma abbastanza da ricordare che il titolo ha ancora bisogno di patch.
La colonna sonora pesca dalle atmosfere horror anni ’80, con temi cupi che si fondono perfettamente ai momenti di tensione. Il doppiaggio in inglese è solido, mentre pesa l’assenza del doppiaggio in italiano, che poteva rendere la narrazione più accessibile a un pubblico più ampio.
 Dying Light: The Beast non reinventa la ruota, ma la fa girare più liscia. È un capitolo che guarda indietro con convinzione, riportando in scena Kyle Crane e un gameplay che mescola vecchie certezze e nuove contaminazioni. La modalità bestia non è perfetta, la trama è banale, ma la solidità dell’open world, il parkour rifinito e un comparto tecnico spettacolare ne fanno un titolo che merita attenzione.
Per i fan del primo Dying Light è un ritorno a casa. Per chi cerca un survival più diretto e meno dispersivo, è la conferma che a volte guardare indietro è l’unico modo per andare avanti.
Dying Light: The Beast non reinventa la ruota, ma la fa girare più liscia. È un capitolo che guarda indietro con convinzione, riportando in scena Kyle Crane e un gameplay che mescola vecchie certezze e nuove contaminazioni. La modalità bestia non è perfetta, la trama è banale, ma la solidità dell’open world, il parkour rifinito e un comparto tecnico spettacolare ne fanno un titolo che merita attenzione.
Per i fan del primo Dying Light è un ritorno a casa. Per chi cerca un survival più diretto e meno dispersivo, è la conferma che a volte guardare indietro è l’unico modo per andare avanti.L'articolo Dying Light The Beast Recensione proviene da GameSource.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)






























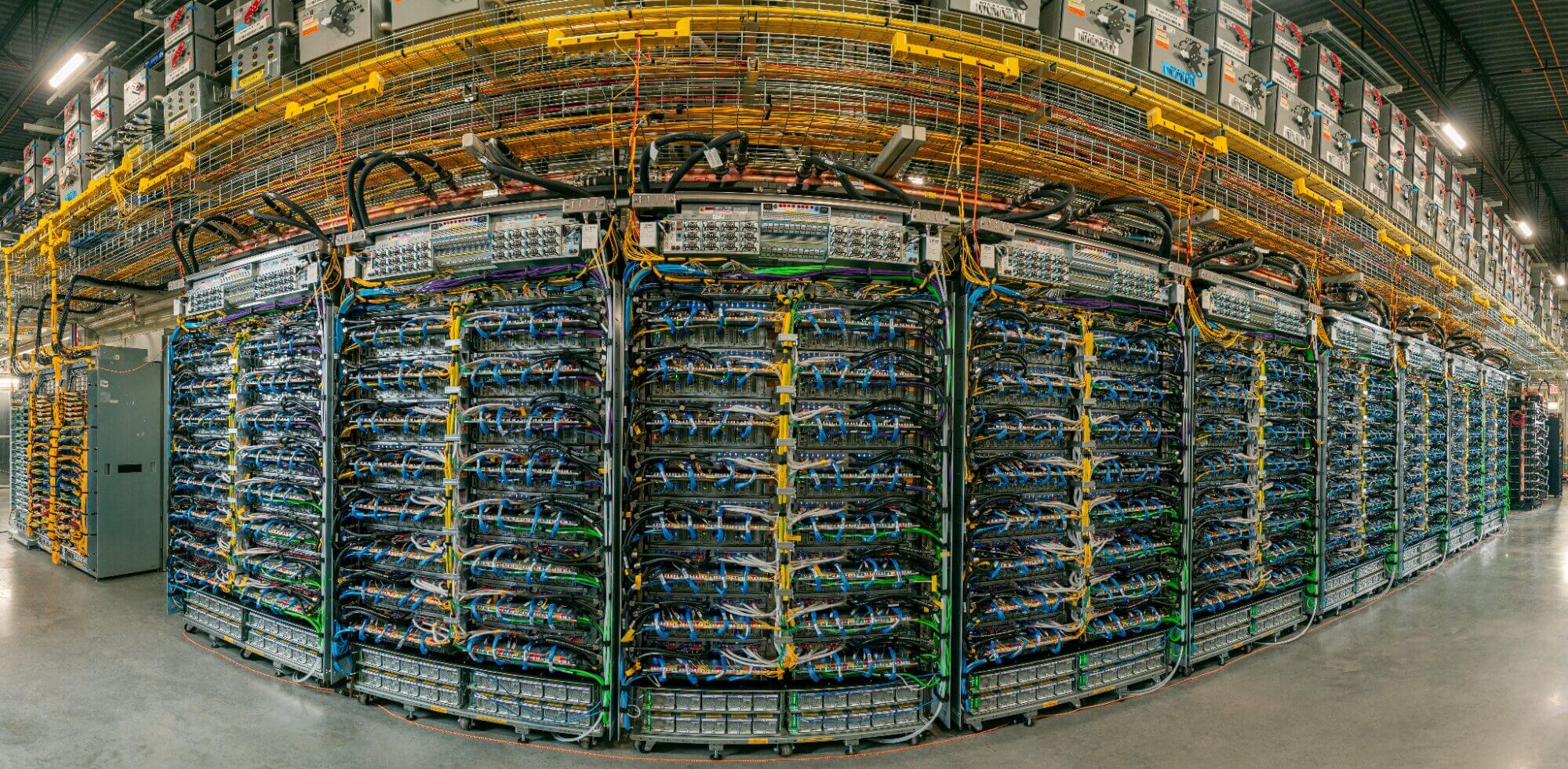















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

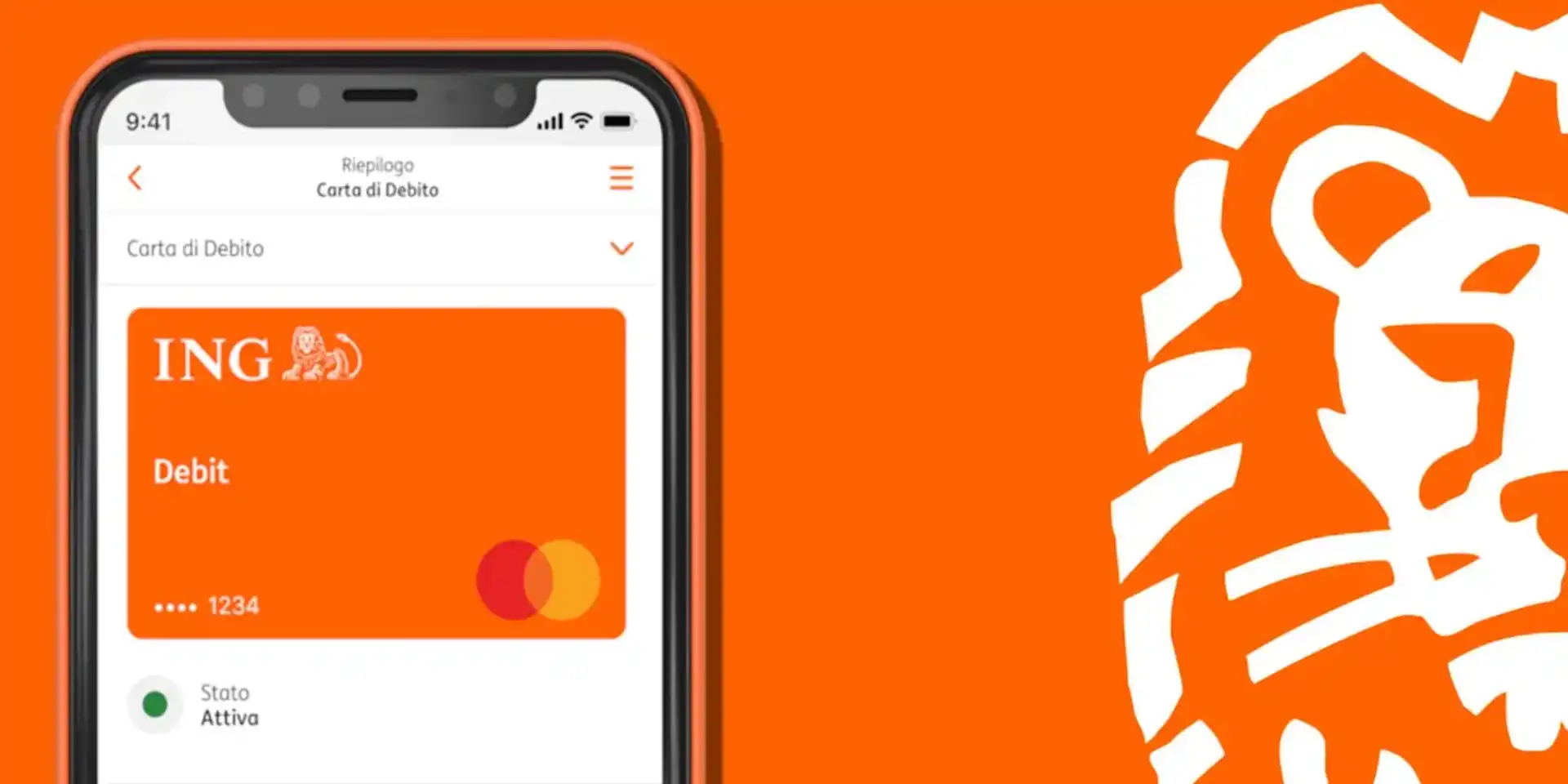
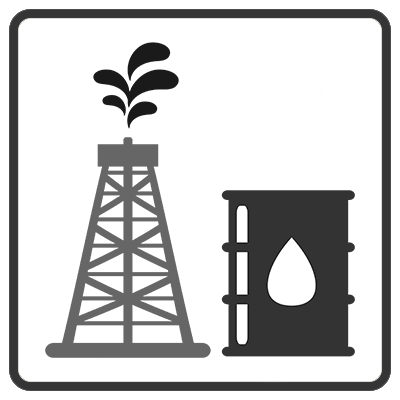

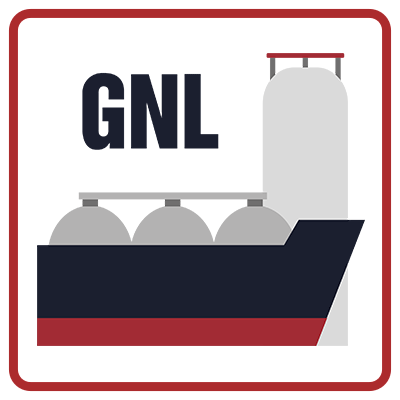







































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































