Gli intellettuali che non chiedono soldi, e la promessa che il mondo non poteva mantenere


Gli intellettuali parlano solo di soldi, non è una notizia: sì, bello “Il grande Gatsby”, ma vuoi mettere le lettere che Francis Scott Fitzgerald scriveva a Max Perkins, il suo pazientissimo editor, chiedendogli sempre soldi, solo soldi, non c’erano soldi che bastassero?
Sono – i soldi, specie quando non ci sono – anche l’unico incentivo alla creatività. Ho scritto i miei migliori libri nell’autunno del 2012 – dopo che in mezzo all’estate la direzione di D era stata presa da una tizia il cui unico segno in decenni di giornalismo fu chiudere la mia rubrica – e nell’estate del 2020, dopo che la pandemia aveva sospeso le pubblicità di abiti da sera e da Elle mi avevano chiesto se potessi scrivere per meno soldi (domanda la risposta alla quale è sempre e solo: no; se accettate provvisoriamente meno soldi, definitivamente non tornerà il giorno in cui ve ne daranno di più, e questo è l’unico insegnamento che ho da lasciare ai vostri figli).
Lo scorso fine settimana è stato quello in cui tutti gli scrittori parlavano di soldi, a me o al mondo. Domenica Facebook mi ha ricordato che cinque anni fa Christian Raimo, a proposito del funerale di Gigi Proietti, aveva pubblicato un post in cui c’erano anche queste righe: «All’inizio degli anni duemila ero un giovane scrittore, e insieme a tutti gli scrittori romani, vecchi e giovani, bravi e meno bravi (io ero sicuramente fra i secondi), collaboravo a Repubblica Roma, scrivevamo articoli sui quartieri romani. Venivamo pagati tantissimo (400 euro a pezzo, mai più visti tanti soldi per un lavoro così leggero)».
Oggi me la prenderei con l’insopportabile posa di quel «(io ero sicuramente tra i secondi)», all’epoca avevo ripubblicato il tutto sulla mia pagina aggiungendo queste righe: «Non commento “io nei primi 2000 per 400 euro non rispondevo manco alla telefonata di quello che mi chiedeva il pezzo” solo perché i primi 2000 sono finiti e devo scrivere un sacco per guadagnare una miseria e non posso passare il lunedì a smistare gli schianti dell’internet, ma un giorno di questa cosa che gli intellettuali italiani ritengano sconveniente farsi pagare bisognerà ragionare».
Che è la stessa cosa che avevo pensato sabato, a pranzo con una scrittrice che mi riferiva con occhi sgranati che un’altra scrittrice si era infine appoggiata a un’agenzia di quelle che trattano per te presenze nei festival e ai convegni (un’altra cosa di cui parlano tantissimo gli intellettuali: quali, tra le agenzie che si occupano delle tue marchette e non del tuo lascito culturale, siano meno cialtrone).
«In un mese ha fatto ottomila euro», sospirava lei, e io le dicevo che non è che fosse esattamente uno sproposito, sono quattro apparizioni alla tariffa minima. Lei, con la faccia con cui la moglie del Gattopardo si faceva il segno della croce quando lui diceva le parolacce, rispondeva che lei va gratis ovunque. Ma perché?, domandavo io. Perché m’imbarazza chiedere soldi. (Le ho lasciato pagare il conto, contando sul fatto che la imbarazzasse dire «dividiamo»).
Gli intellettuali che non chiedono soldi mi fanno ammattire, perché io penso che almeno nelle manifestazioni pubbliche i soldi per gli intellettuali non dovrebbero esserci, che con quei soldi si dovrebbe far funzionare il pronto soccorso o riparare le buche nelle strade, ma poiché invece ci sono soldi stanziati per la cultura – qualunque cosa essa sia – non si capisce perché debbano darli a qualcun altro e non a me.
Se Charlie Brooker dovesse telefonarmi dicendomi «hai mica un’idea per una puntata di “Black Mirror”», gli proporrei la storia in cui uno scrittore cui hanno iniettato il siero della verità, sul palco d’un qualche festival per il quale l’assessorato alla Cultura gli ha staccato un assegno per parlare del suo libro a una cinquantina di pensionati venuti a passare il pomeriggio, dicesse: «Voi pensate che questo intrattenimento sia gratuito, e invece io vengo pagato, per parlarvi per un’oretta, quel che voi prendete di pensione in tre mesi, e coi soldi delle vostre tasse», e quelli a quel punto lo linciano, e poi impalano l’assessore.
Mentr’ero a pranzo con la scrittrice cui i genitori hanno insegnato che parlare di soldi è volgare, Jonathan Bazzi ha postato sui suoi social la foto di quelle temibilissime due voci che stanno in fondo all’estratto conto sulla app della banca: entrate, uscite. Aveva in comune col mio (con quello di molte persone che conosco) il fatto che le uscite fossero ben superiori alle entrate, solo che le cifre erano davvero minuscole: trentacinque euro di entrate, da cui desumo che Mondadori non gli abbia ancora pagato il lavoro di ghost per l’autobiografia di Fedez (che non è male per niente, nei prossimi giorni ne parliamo).
Il commento di Bazzi al proprio estratto conto iniziava con le parole «Questa la mia situazione alla fine del mese scorso. Ma come, ti si legge dappertutto? – spesso ho visto scritto nei commenti ai miei articoli sulla precarietà e la difficoltà nell’avere una vita materiale decente». Bazzi parla spessissimo di soldi, in effetti, e io lo osservo da sempre senza capire se davvero li vorrebbe avere o se preferisca lamentarsi della loro assenza (è un tema narrativo anche quello).
Quand’era in finale allo Strega, ormai cinque anni fa, fotografava il Valentino che avrebbe indossato alla premiazione, e io pensavo che mai prima di quest’epoca c’era stata una tale discrasia tra quel che credi di sapere guardando la superficie (è ricco, veste abiti costosi) e quel che sai se leggi tra le righe (è povero, l’abito costoso è un omaggio dello stilista): vale per gli scrittori così come per chi vende tisane su Instagram. La sera prima di dichiararsi in miseria sui social, era al festival di questo giornale a parlare di moda. Certo, sappiamo che esiste l’economia dello scrocco e non da oggi, magari anche a Dorothy Parker o a Truman Capote ogni tanto qualche munifica mano allungava un capetto decente, ma non dovevano taggare lo sponsor e quindi era tutto meno strano.
Ci sono ormai tre generazioni – la prima è la mia, quella di Bazzi è la seconda – cui il mondo ha fatto una promessa che non poteva mantenere: sarete tutti intellettuali. Farete tutti l’università, avrà senso laurearsi in filosofia, sarete specialissimi e non dovrete mai trovarvi un lavoro noioso perché il mondo vorrà sapere la vostra su tutto: voleva saperla da Umberto Eco, e cos’avete voi di meno. Il Wall Street Journal, analizzando la vittoria di Mamdani, scrive che in America ormai ci sono troppi laureati (e non abbastanza gente che voglia fare i lavori che si rendono disponibili quando gente che non aveva studiato va in pensione), laureati col massimo dei voti perché il diciotto politico è stato sostituito dal trenta politico, e quella folla di inutili portatori di titoli di studio dà la colpa al capitalismo se il libero mercato non dà peso alle sue lauree, «e come osano i datori di lavoro rifiutarsi di pagarli per stare su TikTok?».
Un paragrafo del post di Bazzi diceva: «Tornato dalle vacanze, quest’anno, ho cercato di rendere più strutturate e certe le mie collaborazioni, a modo mio ho chiesto aiuto. Ma ho sollevato il coperchio di un vaso di cui non avrei voluto vedere il contenuto. Compensi inferiori a quello che prende (all’ora) un addetto alle pulizie, contrattualizzazioni come sacri Graal, esclusive imposte (se scrivi anche altrove non va bene!) in cambio di euro zero», e l’inizio e la fine di questo paragrafo mi sono sembrati sorprendenti.
C’è ancora qualcuno che chiede esclusive? Quando ho cominciato le chiedevano, ma le pagavano anche (tranne se eri molto all’inizio e pensavano di potersene approfittare). Adesso, che il culturale e persino il ricreativo ti pagano due lupini e un’oliva, mi sembra incredibile che qualcuno ti chieda di scrivere in esclusiva. Delle vacanze non dico nulla, perché so che quella di Bazzi è una generazione che si percepisce quella che vive peggio di tutti i tempi e guai a dirle che magari se non hai soldi le vacanze son la prima cosa che tagli.
Come sempre accade sull’internet, i commenti aprono finestre su mondi dei quali ignoravi l’esistenza. «Io quando vedo in giro gente che fa dice scrive recensisce, mi chiedo sempre “ma questi come mettono insieme pranzo e cena? Le bollette?”. Io ad esempio sono stata costretta a trovare un lavoro a 25 anni». Ma nel senso che è presto o che è tardi? Si percepisce lavoratrice minorile o ci sta dicendo che fino ai ventiquattro ha sperato d’averla sfangata e di poter fare la poetessa a tempo pieno?
Una commentatrice diceva a Bazzi «ci vorrebbe una norma sui tempi di pagamento e su un minimo di paga», ed era una tra decine o forse centinaia di persone che commentavano dall’interno del settore, e io pensavo che ci vorrebbe un manuale di autoaiuto da fornire agli aspiranti intellettuali non appena iniziano ad aspirare.
Andrebbe detto loro che sì, alcuni editori pagano a centoventi giorni, ma hai sbagliato qualcosa se questo costituisce un problema dopo il primo anno di lavoro, perché dopo un po’ avrai sempre soldi che ti entrano da lavori del semestre precedente, se lavori da più di quattro mesi. Nel mio primo contratto, nel 1995, c’era scritto che m’impegnavo a non far causa se i pagamenti fossero arrivati oltre i molti mesi stabiliti da contratto, e sì, tecnicamente era una clausola vessatoria, ma avevo ventitré anni e non sapevo fare niente, era già tanto che prima o poi mi pagassero. Poi una cresce, diventa meno inutile per chi deve pagarla, e può avanzare più pretese, se le sue mansioni non sono fuori mercato come facilmente lo sono quelle di chi scrive in un secolo in cui la scrittura è diventata come il buon gusto e il senso dell’umorismo in quella battuta di “Harry, ti presento Sally”: tutti pensano di averceli. Tutti pensano di saper scrivere, nessuno vuole leggere.
E sì, tecnicamente già da contratto pagare a centoventi giorni non è legale né morale, ma esiste una legge della domanda e dell’offerta, e il mondo è oggi ben più che nel 1995 pieno di gente che vuole scrivere e di testate disposte a farla scrivere per due spicci pagati a quattro mesi, e lo so che la promessa che avreste potuto fare tutti lavori intellettuali pur non avendo intelletti eccezionali è stata una truffa, però pure voi, figli miei, avreste dovuto sospettare che Wanna Marchi non avesse i numeri del Lotto.
Nei commenti c’è gente che dice quant’è frustrante essersi rassegnata a far altro avendo studiato Lettere, e a me dispiace molto che la civiltà della conversazione sia ormai così a meretrici che, a domandare cosa pensassero di fare con una laurea in Lettere, si debba passare per hater. La laurea in Lettere va benissimo per tua cultura generale, va benissimo se hai la vocazione dell’insegnamento, va benissimo se poi vuoi andare a fare un lavoro qualunque che non richieda una laurea, ma quand’è che l’idea del potere del desiderio ci ha così rovinato il principio di realtà da pensare che una laurea in Lettere garantisca una qualsivoglia carriera?
«E partecipazione gratuita alle conferenze, festival eccetera dove spesso ti trattano anche male. A volte ti pagano vitto e alloggio, pasti non sempre». Il commento lo lascia, sotto il post di Bazzi, una che non è quella con cui ero a pranzo io. Quindi ci sono almeno due scrittrici, in Italia, che vanno in luoghi di lavoro non solo gratis ma portandosi da casa il panino con la frittata, e in cambio neppure ricevono riverenze dagli organizzatori.
Mi viene il sospetto che sì, far tornare i conti del lavoro culturale sia difficile, ma parte di questa difficoltà venga dalla smania di esserci. Dal timore che, se chiedi i soldi, poi t’invitino meno. Come se il tuo vero compenso fosse il nome in cartellone e non il bonifico. Francis Scott Fitzgerald è morto comunque giovane e in miseria, ma prima aveva fatto una vita da ricco. Credo fosse perché aveva il vantaggio di non avere la telecamera nel telefono. Se le sue lettere di lusso e miseria a Max Perkins fossero state post pubblici, si sarebbe fatto bastare la dopamina dei cuoricini e le ciance solidali. Invece viveva, beato lui, nel secolo in cui incassare era grandemente più soddisfacente che lamentarsi perché non si era incassato.
L'articolo Gli intellettuali che non chiedono soldi, e la promessa che il mondo non poteva mantenere proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































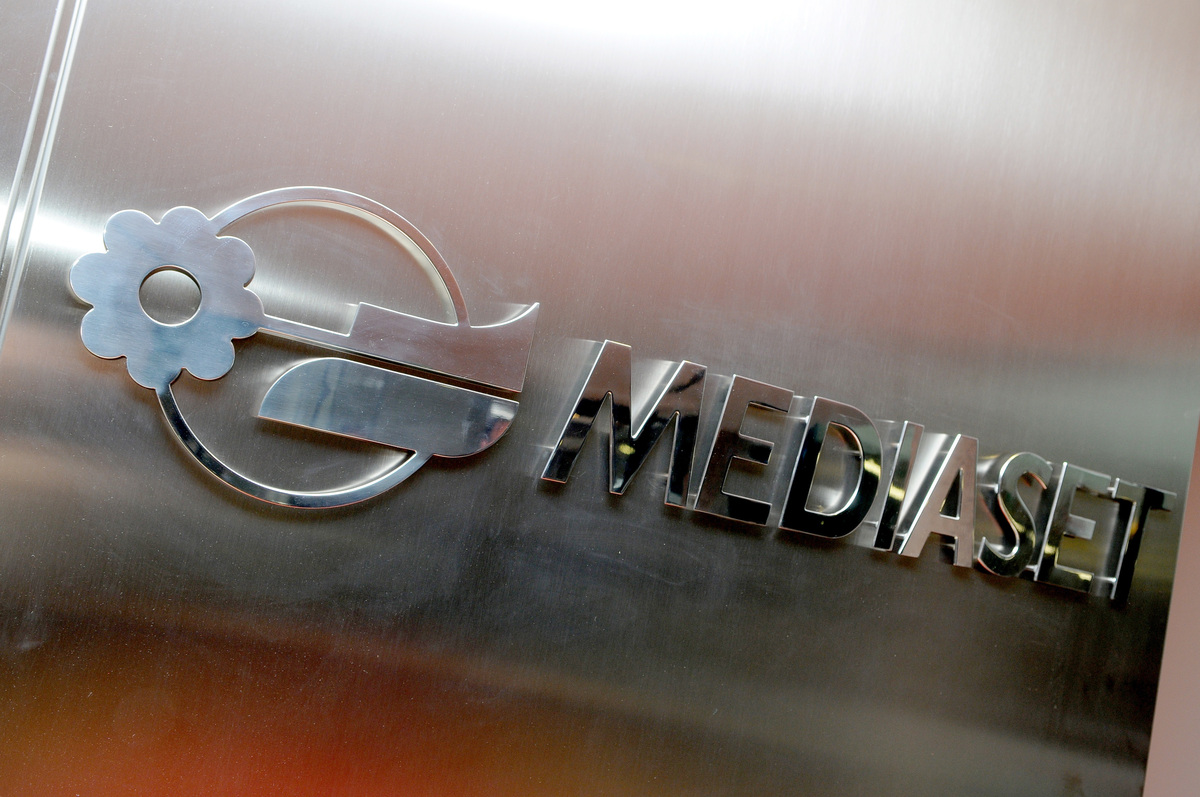























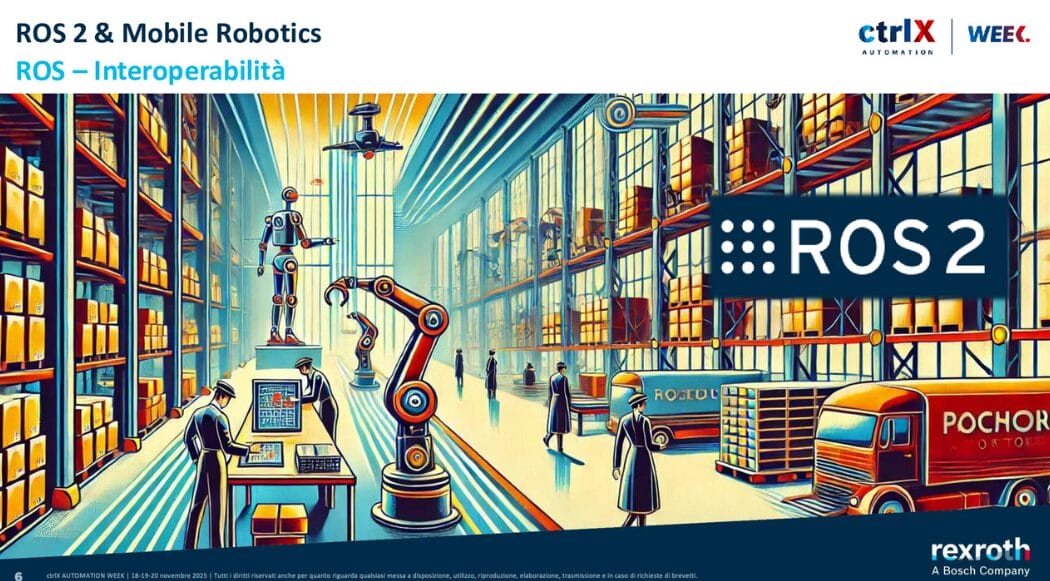











































































































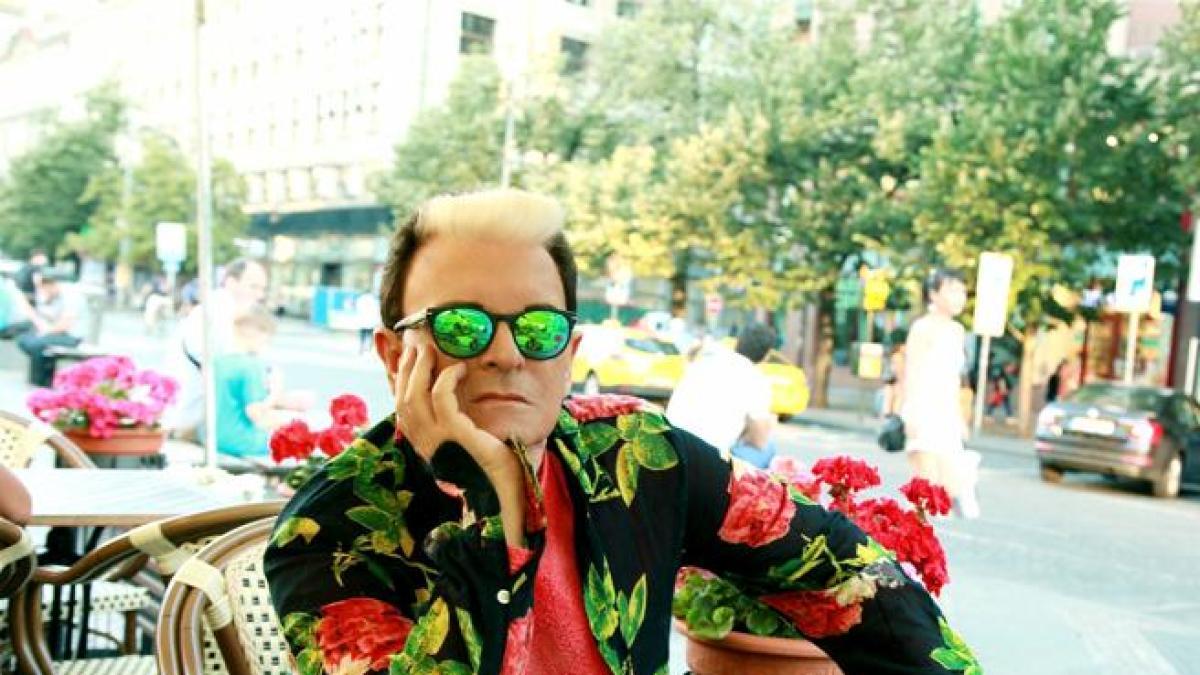

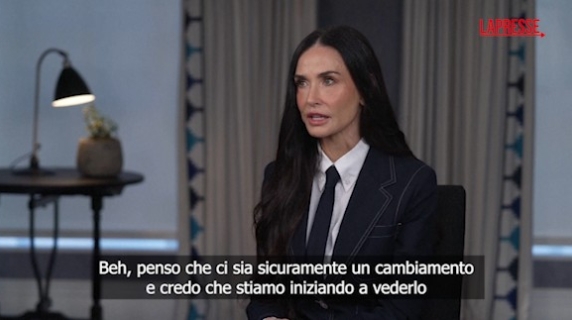




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































