I libri non li legge più nessuno, ma allora perché fanno paura al potere?


C’è un Paese in cui si parla di “tradizione” brandendo il cellulare come una spada laser, dove gli annunci si fanno in diretta, rigorosamente a colpi di selfie, e intanto i libri spariscono dagli scaffali della nostra attenzione. È lo stesso Paese in cui, per fortuna, qualcuno lavora perché le biblioteche restino aperte, vive, frequentate. A Varese quell’“uno” ha un nome e un ruolo: Enzo Laforgia, assessore alla Cultura, che con ostinazione da antieroe continua a difendere il luogo più sovversivo della città—la biblioteca civica—l’unico posto in cui le cose non si comprano e non si vendono. Nel reading “Il rifugio dei libri proibiti”, Giuseppe Civati usa l’ironia come grimaldello: ride (amaramente) delle liturgie della politica istantanea e ci riporta alla sostanza—i libri, appunto—proprio mentre la comunicazione “corriva” ci scivola via tra un reel e l’altro.
Il quarto appuntamento, il terzo nella Biblioteca Morselli di Varese, per il festival Fondamentali, di cui il Comune è protagonista insieme con People e Varesenews, è divertente, graffiante, illuminato anche rispetto al luogo. Civati personalizza il suo reading e scherza spesso sull’assessore e su un certo modo di essere operatori di cultura.
Siamo una società post-alfabetizzata (ma il problema non è solo nostro)
Civati parte da una constatazione brutale: “i libri non li legge più nessuno”. L’Italia naviga in fondo alle classifiche europee, mentre la Francia e la Germania ci superano di cinque o dieci lunghezze. Nel frattempo “la visione ha sbaragliato la lettura”: viviamo nella società post-alfabetizzata, dove il testo scritto diventa opzionale e la discussione pubblica si accorcia fino a diventare slogan. Non è nostalgia: è la presa d’atto che la lettura profonda richiede tempo, concentrazione, un po’ di fatica. Proprio ciò che la politica-spettacolo teme, perché un lettore che segue una trama sa riconoscere anche quella, molto più grezza, della propaganda.
Perché censurare ciò che “non legge nessuno”?
Qui scatta il paradosso: se i libri sono usciti dall’immaginario, perché vietarli? Perché—spiega Civati—un libro è un dispositivo a lunga gittata. Ti obbliga a sostare, a seguire personaggi, cause ed effetti; è lento e per questo pericoloso. E allora ecco l’onda lunga che dagli Stati Uniti arriva sulle nostre sponde: leggi-fotocopia, indici neri, la retorica del “proteggiamo i figli”. La florida stagione dei divieti—Ron DeSantis in testa—ha tolto migliaia di titoli dalle scuole, bastano tre distretti per far diventare censura una norma statale. La parola più pericolosa? “Inclusione”. Più che un programma politico, un vocabolario al contrario.
L’assurdo sfiora il grottesco: Margaret Atwood risponde ai censori con un’edizione ignifuga del Racconto dell’ancella; il Pentagono arriva a bandire libri inoffensivi o perfino fotografie per via di una scritta “sospetta”. Sembra fantascienza? Lo aveva già raccontato Ray Bradbury: in Fahrenheit 451 i pompieri bruciano i libri “per non offendere le minoranze” e regalarci una felicità anestetizzata. La distopia come manuale d’istruzioni del presente.
I bibliotecari, eroi civili (e un assessore che li difende)
Civati sceglie di leggere questo testo in biblioteca. Non è un dettaglio: i bibliotecari sono i custodi di un patrimonio che non appartiene al mercato. In quelle sale si pratica una forma rara di democrazia—l’accesso. Prendi, leggi, restituisci: la circolazione della conoscenza come bene comune. Il loro lavoro è l’antidoto alla deriva in cui il valore di una frase si misura in secondi di visualizzazione. Qui l’assessorato alla Cultura fa la differenza, non solo con orari e bilanci: con una visione che tiene insieme tutela e mediazione, acquisti e attività, scuole e quartieri. Sembra poco, è politica ad alta intensità.
“Uccidere un buon libro è uccidere la ragione”
La difesa più radicale del libro arriva da lontano. Milton lo chiamava “fiala” che conserva la vita di molte menti; Amos Oz sognava di diventare un libro, perché i libri hanno “una vita di scaffale” che sopravvive agli uomini; Tacito ammoniva che bruciare i volumi li rende solo più ricercati; Canetti raccontava la paranoia del bibliofilo assediato; la Cina dell’imperatore Qin bruciò i testi degli antenati, salvo poi farsi travolgere dal cambio di dinastia. La storia insegna: i roghi non cancellano, amplificano. E dove le fiamme si sono alzate—Berlino, 1933—oggi un’opera di Micha Ullman, La biblioteca vuota, mostra il vuoto come memoria: scaffali bianchi, sotterranei, visibili da un oblò. È l’immagine più nitida di ciò che la censura lascia: niente.
La censura che non si vede (ma si sente)
Non esiste solo il divieto con timbro e firma. C’è la censura indiretta, quella delle piattaforme e delle concentrazioni industriali: se un monopolista decide che un titolo non circola, non serve il falò. Civati cita—con brillante paradosso—Marina Berlusconi quando denuncia il rischio che le Big Tech, senza regole, impongano un “mondo omologato”: stessi gusti, stessi consumi. È l’altra metà del problema: non basta difendere i libri dal potere politico, bisogna garantirne la pluralità nel mercato della distribuzione. Anche qui, l’azione locale conta: biblioteche pubbliche che acquistano editoria indipendente, festival che danno voce a chi voce non ha, amministrazioni che investono in lettura come infrastruttura sociale.
Piccoli roghi all’italiana
Non pensiamo d’essere immuni. Dalla lezione su Dostoevskij cancellata alla Bicocca (come se la letteratura russa fosse un’estensione della politica di Putin), fino alle gaffe censorie che scambiano un Veltroni per un sovversivo: l’ilarità non salva dal danno. E poi le manipolazioni linguistiche: quando si agita lo spettro della “sostituzione etnica” o si usa la parola “tradizione” come recinto, non si discute: si esclude. Qui la letteratura è maestra: Machiavelli, nel celebre epistolario, di giorno sta in osteria a litigare “con beccai e fornaciai”, la sera indossa “panni reali e curiali” ed entra “nelle antiche corti degli antichi uomini”. Questa è la tradizione: dialogo tra vivi e morti, ponte che si costruisce leggendo. Non un muro.
Don Chisciotte e la stanza murata
C’è una scena che vale un trattato. Don Chisciotte legge tanto da perdere il senno; i suoi amici—curato, barbiere e due zelanti “censore” domestiche—decidono di salvarlo a modo loro: bruciano i libri e murano la stanza. Quando il cavaliere si risveglia non trova più la porta: gli dicono che l’ha portata via un mago. Ecco la censura come trucco di prestigio: ti tolgo l’oggetto del desiderio e ti racconto una storia. In fondo, lo avevano capito anche i totalitarismi del Novecento: prima si bruciano i libri, poi le persone.
Una scelta politica (di città)
A Varese, per una sera, i libri sono tornati ad essere notizia. Non perché scandalosi, ma perché necessari. Il reading di Civati ha ricordato che la battaglia sulla lettura non è un vezzo da salotto: riguarda la qualità della democrazia, l’educazione sentimentale di una comunità, la sua capacità di distinguere una storia da una fake news. In tempi di comunicazione “corriva”, fare spazio alla lettura profonda è un atto politico: degli autori e di chi amministra.
E allora teniamoci strette le biblioteche, i bibliotecari e chi, in Comune, insiste nel finanziarle, programmarle, farle uscire di sé—nelle scuole, nei quartieri, tra chi legge poco o nulla. Perché la vera “tradizione” vive così: passando di mano in mano, di scaffale in scaffale.
I libri, alla fine, se la cavano quasi da soli. Ma per resistere all’oblio—più che ai roghi—hanno bisogno di noi. E noi, più che mai, abbiamo bisogno di loro.
L'articolo Fare impresa a Varese: oltre 100 partecipanti al Focus Day promosso dalla Camera di Commercio sembra essere il primo su VareseNews.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

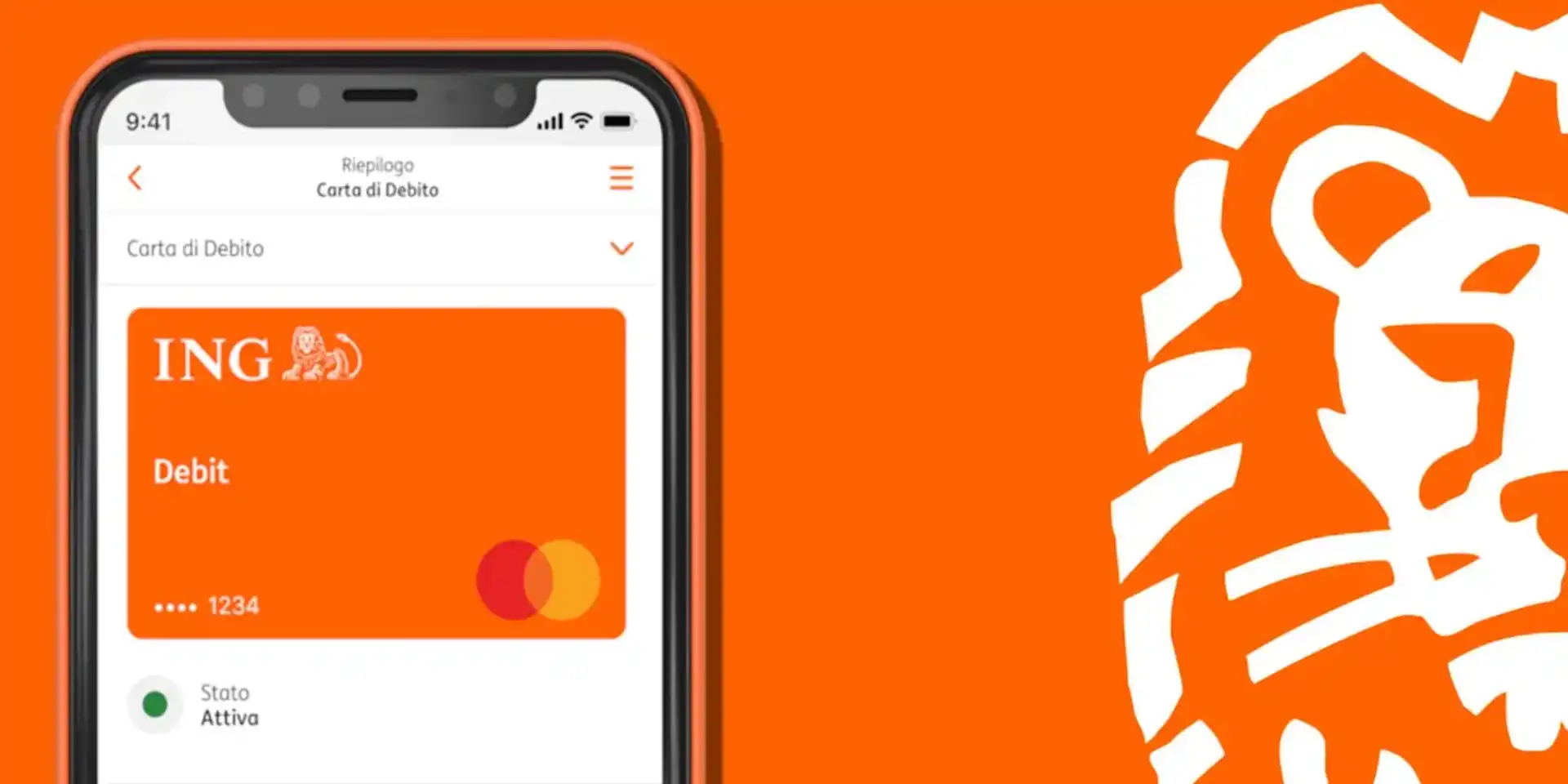










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































