Il caso Kojima–Zerocalcare e la parabola sulla fragilità della libertà artistica


Il regista e designer di videogiochi Hideo Kojima — nome leggendario della saga Metal Gear e oggi impegnato nello sviluppo di Death Stranding 2 — posa insieme al fumettista italiano Michele Rech, in arte Zerocalcare. L’incontro avviene tra gli stand affollati del Lucca Comics & Games, dove entrambi erano ospiti: Zerocalcare per presentare la sua nuova serie per Netflix Due Spicci; Kojima per incontrare fan e creativi del settore. Come lo stesso autore romano ha raccontato in un reel pubblicato sui suoi social, l’incontro nasce da un gesto semplice di entusiasmo, non da fini promozionali. Il fumettista italiano è da sempre un grande fan di Kojima, e ha voluto scattare una foto con lui come farebbe qualsiasi appassionato davanti al proprio idolo.
Prima dello scatto, l’editore di Zerocalcare gli passa la versione nipponica di Kobane Calling, la graphic novel del fumettista romano pubblicata per la prima volta su Internazionale nel 2015 e poi ampliata l’anno seguente da BAO Publishing, in un volume integrale. Racconta la resistenza dei difensori curdi (Ypg e Ypj) del Rojava a Kobane, nel 2015, quando la città siriana al confine con la Turchia divenne teatro di una dura battaglia contro lo Stato Islamico. Nella foto, Kojima tiene in mano il libro con la copertina ben visibile: un simbolo di reciproca stima artistica. Lo scatto viene condiviso da entrambi sui rispettivi profili social, accompagnato da commenti dai toni cordiali. Ma poche ore dopo, la foto scompare dagli account ufficiali del fumettista giapponese.
È bastato questo e nel giro di poche ore dalla pubblicazione decine di siti e account turchi hanno rilanciato l’immagine accusando Hideo Kojima di aver condiviso un post «a sostegno del terrorismo». Le testate filogovernative e i social locali hanno infatti collegato Kobane Calling al Pkk, un’organizzazione curda che il governo di Ankara classifica come terroristica. Da lì, la fotografia — e la sua improvvisa sparizione — si è trasformata in un piccolo caso di polemica internazionale. Pur essendo due Paesi molto diversi, infatti, Turchia e Giappone vantano una solida alleanza. Kojima elimina prontamente il post e Zerocalcare pubblica un video ironico per spiegare l’accaduto, spiegando quanto la barriera linguistica abbia reso tutto più complicato. Questa vicenda non è solo un frammento curioso del mondo nerd: è un caso – studio che parla di qualcosa di molto più vasto, e cioè di come un segno piccolo — una foto, un post, un libro — può diventare detonatore politico.
La fotografia tra Kojima e Zerocalcare assume un preciso significato in un mondo in cui tutto è visibile, condiviso, e malinterpretato. Il segno — il libro in mano al fumettista — viene letto come un messaggio politico, e l’immagine, nel momento in cui viene pubblicata, diventa un simbolo. La rimozione del post non nasce da un ordine, ma da una paura preventiva: quella di perdere credibilità, reputazione e potere di mercato. Il gesto privato scivola così nella sfera politica, e il silenzio diventa una scelta. Un meccanismo tanto sottile quanto universale: l’autocensura.
L’ autocensura (o self-censorship) è la decisione consapevole di un artista, autore o editore di limitare, modificare o non pubblicare un contenuto non per per un’imposizione esterna, ma perché percepito come potenzialmente rischioso a livello economico, reputazionale, politico o sociale. Non si tratta di tacere sotto una minaccia, ma piuttosto scegliere di non dire, non mostrare, non rischiare, per evitare di perdere accesso a un pubblico, a un mercato, o di evitare ripercussioni sulla propria immagine.
L’autocensura non ha necessariamente il tono cupo della repressione: in molti casi è forte la componente pragmatica: è l’autore che anticipa la censura, che sceglie il silenzio o la rimozione prima che qualcuno glielo imponga. Un riflesso preventivo che affonda le radici nel Codice Hays, un manuale ideato negli anni Trenta dal politico statunitense William Harrison Hays. Il volume contiene una serie di regole delle major hollywoodiane riguardanti linguaggi e nudità nei film per evitare scandali morali e garantire che le pellicole potessero raggiungere il grande pubblico. Linee guida successivamente adottate da numerose major, in primis Disney.
Vi sono stati anche numerosi esempi nel mondo dei fumetti. La Comics Code Authority (Cca), attiva dal 1954, fu un organismo interno all’industria del fumetto che imponeva criteri molto stringenti: niente scene di sesso esplicito, niente crimini senza punizione, niente rappresentazioni “indecenti”. Con quell’auto-regolamentazione, l’industria evitava scandali, aggirando leggi restrittive e accessi difficili al pubblico. Tutti esempi di un’industria che si autolimita per prudenza strategica: è la logica del “meglio evitare”, la stessa che spinge creativi, editori e registi a prevenire polemiche o blocchi prima ancora che si manifestino.
Ma esistono casi in cui questa dinamica si spinge oltre, sfiorando il confine della censura vera e propria. È accaduto, per esempio, nel cinema globale. Il film Pixels della Sony ha rimosso una scena in cui degli alieni distruggevano la Grande Muraglia Cinese, per garantire l’uscita nelle sale della Repubblica Popolare. Bohemian Rhapsody è arrivato in Cina con tagli significativi alle scene legate alla sessualità di Freddie Mercury, riducendo uno dei temi centrali del film a un dettaglio implicito. E ancora, nel mondo dell’animazione giapponese, la serie My Hero Academia ha dovuto cambiare il nome di un personaggio dopo che alcuni spettatori avevano riconosciuto un riferimento all’Unità 731, l’unità medica militare responsabile di esperimenti sui prigionieri durante la Seconda guerra mondiale. In tutti questi casi, l’autore o la casa di produzione non si piegano a una censura ufficiale, ma a un calcolo commerciale e geopolitico: adattare la propria opera per non perdere l’accesso a un pubblico o a un mercato miliardario diventa quasi necessario.
Fuori dal contesto cinese, l’autocensura assume forme diverse, più politiche o morali che economiche. In Polonia, diversi artisti e operatori museali hanno dichiarato di autocensurarsi per evitare attriti con un governo populista e conservatore che controlla in parte il sistema culturale. In Malesia, invece, gli editori tendono a eliminare o attenuare contenuti legati a sessualità, nudità o minoranze etniche, uniformandosi alle sensibilità religiose e alle linee guida statali anche quando non ci sono divieti espliciti.
In contesti più autoritari l’autocensura diventa strutturale, una forma di autocontrollo e di supervisione interna in cui l’artista o il cittadino non devono più essere censurati, perché si censurano da soli, mossi dalla paura che precede la parola e dalla consapevolezza che ogni immagine, ogni frase, ogni gesto possono avere conseguenze imprevedibili.
E se nel mondo culturale la pressione è spesso economica o reputazionale, nell’ambito dei social network la dinamica raggiunge il suo massimo livello. Lì, l’autocensura è quotidiana, invisibile, ma costante. Uno studio condotto su cinquecentoventisei utenti della piattaforma cinese Sina Weibo mostra come la maggior parte di loro eviti di pubblicare, commentare o condividere determinati contenuti non solo per timore di una rimozione automatica, ma per paura di ritorsioni sociali, isolamento o sanzioni personali. In rete, la paura non è solo di ciò che si dice, ma di come verrà percepito. Ogni parola diventa potenzialmente incriminante, ogni opinione può costare un profilo, un lavoro o una reputazione.
Il caso della foto tra Kojima e Zerocalcare si inserisce in una triangolazione tra cultura pop, diplomazia e mercato: un fumetto diventa bandiera, un videogioco incontra la guerra curda. Le piattaforme digitali amplificano, l’immagine decolla, qualcuno legge “sostegno”. L’autore anticipa: meglio rimuovere, evitare che il gesto si trasformi in un boomerang.
In un’era in cui la visibilità è parte della reputazione e la reputazione è parte del valore commerciale, l’arte non è più solo espressione libera, è un investimento, un segno e un rischio. Quando l’immagine diventa interfaccia tra brand e geopolitica, l’arte “innocente” non esiste più. Così, un gesto apparentemente leggero – una foto tra due fumettisti al Lucca Comics – si carica di significati che travalicano il fumetto e arrivano alle relazioni internazionali. L’arte oggi non vive al margine del potere, ne è intrappolata. Non solo nei regimi che la vietano, ma anche nei sistemi che la inglobano: le piattaforme social, i database di streaming, i mercati internazionali. L’autocensura diventa un meccanismo invisibile ma potentissimo: muta le forme dell’espressione, restringe le narrazioni, altera anche la scelta del segno.
Il gesto di Zerocalcare e Kojima ci ricorda che l’arte è soggetta tanto alle dinamiche commerciali quanto a quelle geopolitiche, e anche chi è “libero”, lo è entro confini invisibili. Quei confini, spesso, li traccia l’autocensura, prima della legge. La self-censorship non è solo un vuoto di voce, ma un linguaggio a sé: dice senza parlare, e nel silenzio, riscrive il confine stesso della libertà artistica.
L'articolo Il caso Kojima–Zerocalcare e la parabola sulla fragilità della libertà artistica proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























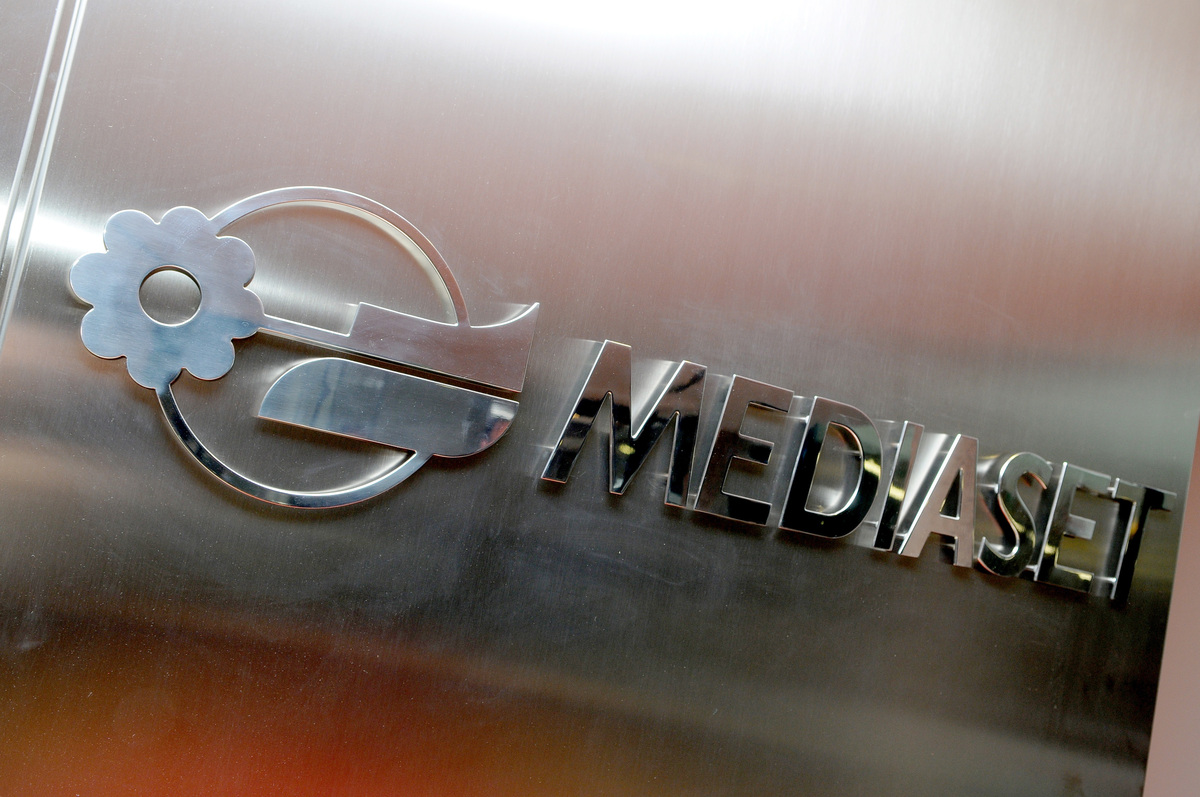



























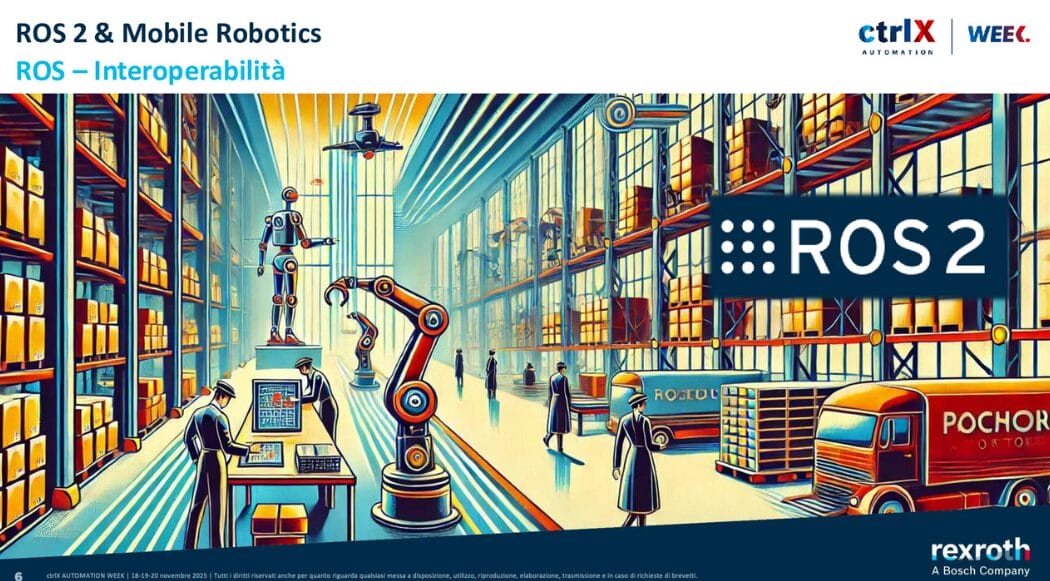











































































































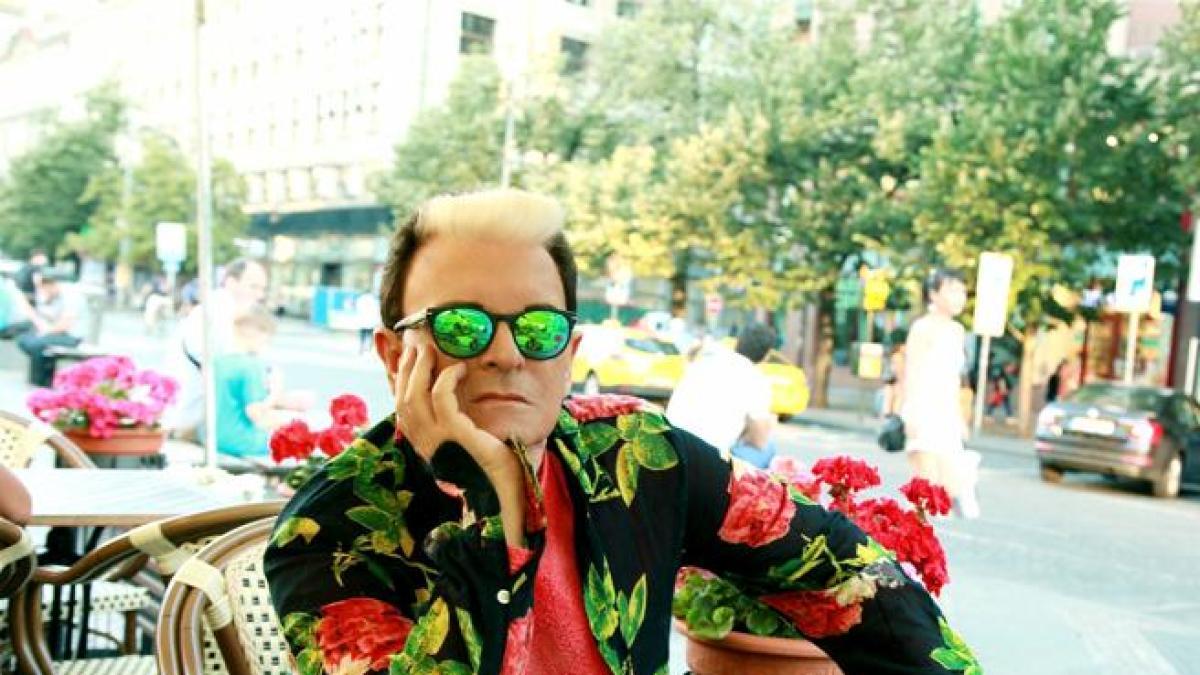

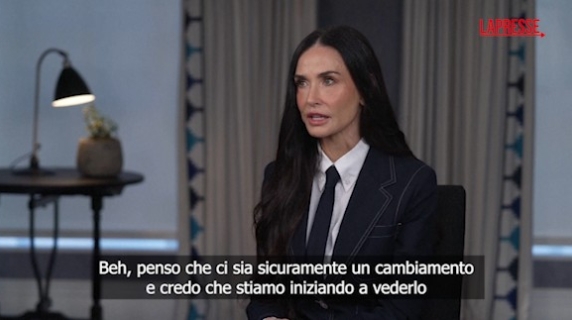




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































