Le gemelle Kessler, e quel mezzo secolo fortunato che ci illudiamo sia la normalità


Quando Alice ed Ellen Kessler cantavano alla tele «una danza molto chic che portiam da l’Amerique» io non ero neppure nata, e così molti di voi. La tv era in bianco e nero, c’era un solo canale, non c’era ancora l’Auditel ma possiamo immaginare che quella prima edizione di “Studio Uno” condotta da Mina facesse numeri inimmaginabili: o uscivi, o guardavi quello. E già se stavi a casa e guardavi quello voleva dire che possedevi un apparecchio televisivo, quindi tanto povero non eri.
All’Italia di quegli anni lì pensavo ieri poco prima che arrivasse la notizia della morte delle gemelle Kessler, che mentre scrivo ancora non si sa come sia avvenuta ma la Bild riporta un’intervista dell’anno scorso in cui Ellen diceva che avevano scritto nel testamento di volere che le loro ceneri fossero messe nella stessa urna.
Ci pensavo perché Concita De Gregorio ha scritto un editoriale sulle fatiche della piccola borghesia, sull’ottusità nostra che ridiamo delle professoresse democratiche (definizione che, se uno non l’ha mai incrociata e la legge in quell’articolo, pensa che venga come minimo da Gasparri, e invece è di Edmondo Berselli), sulle eroiche resistenti che rianimano il mercato librario.
Durante la lettura di quell’articolo ho pensato molte cose, la principale delle quali è che dobbiamo smetterla di pensare che la lettura sia una buona cosa comunque. Certo che lo è, per i bilanci degli editori (dice un amico che fa l’editore: non sono mai libri di merda, finché li pagano). Ma insomma, la quantità di libri per analfabeti che viene acquistata ogni settimana non mi pare culturalmente una buona notizia, ecco.
Però quello che più mi ha colpito nella riflessione di Concita è il finale: «I miei genitori […] avevano avuto accesso al sapere grazie al sacrificio enorme dei loro genitori, sacrificio economico, privazioni. Con il sapere si erano emancipati dalla povertà. Con i loro mestieri hanno mantenuto i figli, molti perché allora se ne facevano molti, hanno comprato una casa, li hanno mandati a studiare le lingue, la musica, le arti, le scienze, li hanno portati in vacanza a conoscere il mondo […] È successo qui, il danno. È in questo piccolo arco di tempo, cinquant’anni non cinquecento, che la povertà del ceto medio ha diserbato la fiducia nel futuro. Come mai, mi chiedo, non ci occupiamo senza altre distrazioni solo di questo».
Mi sento titolata a rispondere, perché io parlo praticamente solo di questo, in un’abbondante maggioranza delle mie conversazioni: di come la seconda metà del Novecento – quella in cui le Kessler hanno ballato, Mina ha cantato, Concita e io siamo andate a scuola, Edmondo Berselli ha scritto, e nessuno di noi ha dovuto occuparsi di correre nei rifugi perché stavano sganciando le bombe, o di non avere l’acqua corrente in casa – non sia rappresentativa.
Ne parliamo come se fosse il passato per antonomasia, il passato tutto, il mondo prima di ora, ma non lo è: è un mezzo secolo brevissimo in cui abbiamo avuto la clamorosa botta di culo di crescere. Ci viene naturale credere che fosse il mondo com’era, perché dal mondo com’era non siamo passati: la tv a colori in Italia arriva che io ho quattro anni, le gemelle Kessler mi son sempre parse modernariato ed erano d’un attimo prima.
I ventenni e i trentenni, che non sanno mai niente, sono giustificati nel non avere idea di quanto fosse raro andare al ristorante o viaggiare trenta o quarant’anni fa, e di quanto comunque già ci si sentisse evolutissimi e di mondo perché avevamo i videoregistratori e il telefono senza fili in casa, il che era un’emancipazione mica da poco rispetto alle interurbane col centralino e alla tv che durante la crisi del petrolio del ’73 interrompeva i programmi alle 22 e 45 per evitare gli sprechi energetici. Più benessere e diritti acquisiamo, più ogni restrizione ci sembra un intollerabile sopruso: oggi, se ci dicessero che dopo una cert’ora non possiamo usare i cellulari, li useremmo per chiamare Amnesty International.
Ogni volta che ci lamentiamo perché il servizio sanitario nazionale ha liste d’attesa di mesi per fare una tac o una risonanza, lo facciamo perché non ci sembra un miracolo che esista un macchinario che ci guarda dentro vedendo se abbiamo tumori o altro, e ci dice in modo indolore e rapido cose che solo quarant’anni fa dovevano aprirci e richiuderci in sala operatoria per scoprire. Niente come il progresso ci fa pensare che ogni miglioria sia un diritto.
Certo che Guido Tersilli nel “Medico della mutua” faceva cinque visite a domicilio al giorno e la sua visita media durava dieci minuti, e oggi dieci minuti il medico te li dedica solo se proprio stai morendo, ma il 1968 di Guido Tersilli sta in quel mezzo secolo di benessere mai più esistito né prima né dopo: se non abbiamo trent’anni, sappiamo che nella storia dell’uomo – per molti più anni di quanto sia durata quell’età dell’oro che rimpiangiamo – la maggioranza degli umani a un medico raramente aveva accesso, e la medicina era arretratissima.
Certo, i nostri genitori ci facevano studiare e ci mandavano all’estero e dalla maestra di pianoforte e dal dentista e a fare ginnastica correttiva, ma la generazione precedente lavava i panni al fiume (alla fontana in piazza, se un fiume non c’era), e le nostre nonne avevano la dentiera perché i denti cadevano e non venivano rimpiazzati. Oggi neanche dobbiamo stendere: abbiamo l’asciugatrice, e il tempo risparmiato lo investiamo guardando video imbecilli di due minuti perché persino le attività ricreative di cinquant’anni fa – guardare un film, leggere un romanzo – ci sembrano troppo impegnative.
Persino allora esistevano i libri di merda, e avevano più mercato di quelli sofisticati, solo che tutto è relativo, e lo scotto che paghiamo all’allargamento del benessere e dell’alfabetizzazione è che quelli che allora erano i libri facili e larghi e popolari oggi ci sembrano capolavori della letteratura: nel 1963, quando “Fratelli d’Italia” (nel senso di Arbasino, non di Giorgia Meloni) vendeva meno di cinquemila copie in otto mesi, il libro che andava per la maggiore era “Lessico famigliare”, mica “Cambiare l’acqua ai fiori”.
Eravamo meno analfabeti quand’eravamo analfabeti? In un certo senso sì, ma adesso le Kessler possiamo guardarle nel telefono, lo stesso posto dove possiamo guardare le serie per decerebrati di Netflix ma anche Buñuel o Woody Allen o Monicelli. Quel pezzo di passato lì è irripetibile ma ne restano brandelli sparsi. Possiamo usarli per addomesticare il nostro gusto a libri meno di merda, film meno di merda, tv meno di merda, e – pur sapendo che il tempo andato non ritornerà – praticare così quella che Concita definirebbe una forma di resistenza.
Certo, però, c’è il problema che il modernariato culturale farà benissimo al nostro gusto ma malissimo ai bilanci dei viventi. Se abbiamo dei figli con velleità di lavoratori culturali, sarà meglio che andiamo a comprare qualche romantasy o a vedere qualche scemenza prodotta da pochi mesi. Che priorità abbiamo: mantenere alto il livello culturale o viva la filiera delle puttanate?
L'articolo Le gemelle Kessler, e quel mezzo secolo fortunato che ci illudiamo sia la normalità proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































![Mondiale Rally. LIVE! Ecco la Ypsilon Rally2 HF Integrale [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/47903459/1200x/lancia-ypsilon-hf-integrale-2.jpg)




























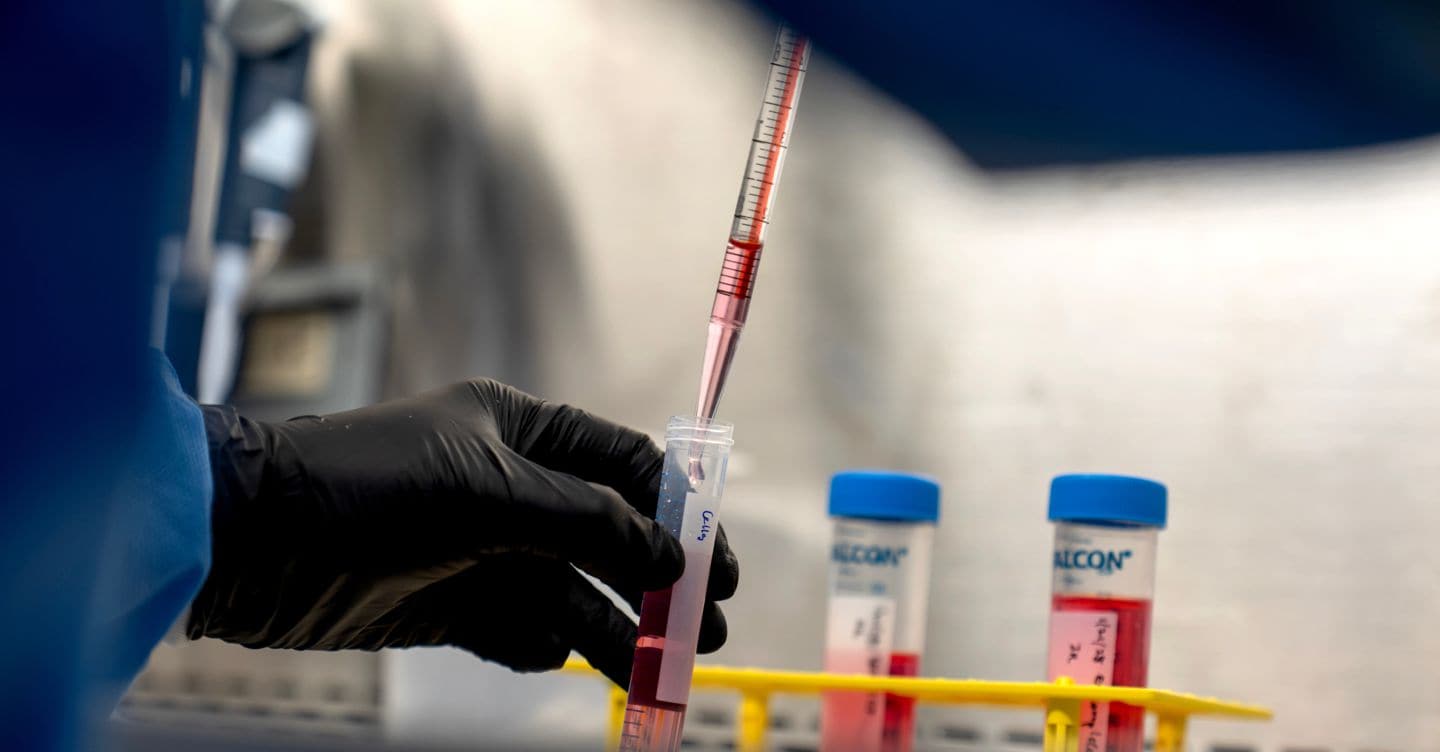




















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)











































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































