L’equiseto è un fossile paleozoico che vive tuttora nei nostri sottoboschi


Una pianta che arriva dal passato e che ha mille usi, in campagna come in cucina. L’equiseto, detto anche “coda cavallina” – traduzione esatta del nome latino equi (di cavallo) saeta (ossia coda, letteralmente crine) – è un fossile vivente, il solo genere esistente di felce appartenente alla famiglia delle Equisetidae, che dominavano i sottoboschi nella tarda era paleozoica: a quel tempo erano grandi alberi che raggiungevano anche i trenta metri di altezza. Si tratta quindi di una delle specie vegetali più antiche presenti sulla Terra, che risale a oltre quattrocento milioni di anni fa, è sopravvissuta praticamente invariata fino ai giorni nostri, ed è cosmopolita, diffusa in tutti i continenti, con l’eccezione di Oceania e Antartide.
Negli ambienti che gli sono congeniali, come fossi, rive di corsi d’acqua e terreni umidi o semiacquatici e argillosi, è facilmente riconoscibile per il suo aspetto particolare: fusti sottili, cilindrici e articolati, privi di vere foglie, ma con ramificazioni che ricordano, appunto, la coda di un cavallo. L’altezza varia da pochi centimetri fino a oltre un metro, a seconda della specie. Tra le più comuni: Equisetum arvense, diffuso in Europa, il più noto, utilizzato anche a scopo officinale; Equisetum hyemale, o equiseto invernale, con fusti più robusti, e il più grande, Equisetum telmateia. Ci sono anche alcune varietà coltivate a scopo ornamentale, ma l’equiseto è soprattutto utile. «L’equiseto fa bene alle ossa e al campo», dice un vecchio proverbio ed è proprio così.
In erboristeria e fitoterapia, è noto per le sue proprietà diuretiche, remineralizzanti, soprattutto per il tessuto osseo, e cicatrizzanti. Viene impiegato in tisane, decotti e integratori per favorire la salute di ossa, unghie e capelli, grazie all’alto contenuto di silice e sali minerali, mentre, sotto forma di impacchi, aiuta nella guarigione di ferite e infiammazioni della pelle. Sotto forma di estratti standardizzati in silicio è utile nella prevenzione e nella cura dell’osteoporosi, mentre a scopo diuretico può essere utilizzato lo stesso estratto fluido. Inoltre, serve contro le smagliature cutanee, grazie alle sue proprietà rassodanti, leviganti ed elasticizzanti e, grazie alle proprietà astringenti può essere utilizzato come base per lavaggi per palpebre arrossate, colliri per le congiuntive infiammate, sciacqui e gargarismi per le mucose della bocca e della gola.
Chi vuole ricorrere il meno possibile a prodotti industriali può usarne, come avveniva in passato, i fusti ruvidi e ricchi di granuli di silicio per lucidare metalli e legno. In agricoltura biologica i macerati di equiseto sono impiegati come rimedio naturale contro funghi e parassiti delle piante, grazie al loro effetto protettivo e rinforzante, ma anche come fertilizzante naturale: l’estratto di equiseto apporta al terreno sali minerali come calcio, magnesio e potassio e migliora la qualità del suolo e la struttura del terreno nel tempo, fornendo sostanze nutritive essenziali alle piante. L’equiseto è apprezzato anche nel campo della cosmetica. Se gli antichi Romani lo usavano come sostituto del sapone, oggi è un ingrediente di creme antirughe e anti-ageing e nei prodotti utili in caso di cellulite.
E infine, sì, può essere usato anche in cucina. Ad esempio, per aggiungere un tocco di sapore insolito e selvatico ai risotti, per arricchire di sali minerali zuppe e minestroni o insaporire frittate e omelette. La polvere, mescolata alla preparazione della pasta fresca dona colore e aroma. I giovani germogli fertili, che crescono solo in primavera, possono essere impanati, pastellati e fritti per ottenere un contorno croccante, oppure cotti al burro, o aggiunti alle insalate. Ma ci sono anche tante altre combinazioni per ricette davvero originali, ed è noto anche come “pesce di montagna” perché se bollito in acqua o nel brodo sprigiona un aroma marino.
Attenzione, tutto questo vale per l’Equisetum arvense, che comunque da noi è il più diffuso, mentre altre specie, come quelle palustri, possono essere tossiche. Inoltre, come per tutte le piante ricche di sali minerali, non dev’essere consumato in quantità eccessive e con cautela in caso di malattie renali, gravidanza e problemi gastrici.
L'articolo L’equiseto è un fossile paleozoico che vive tuttora nei nostri sottoboschi proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

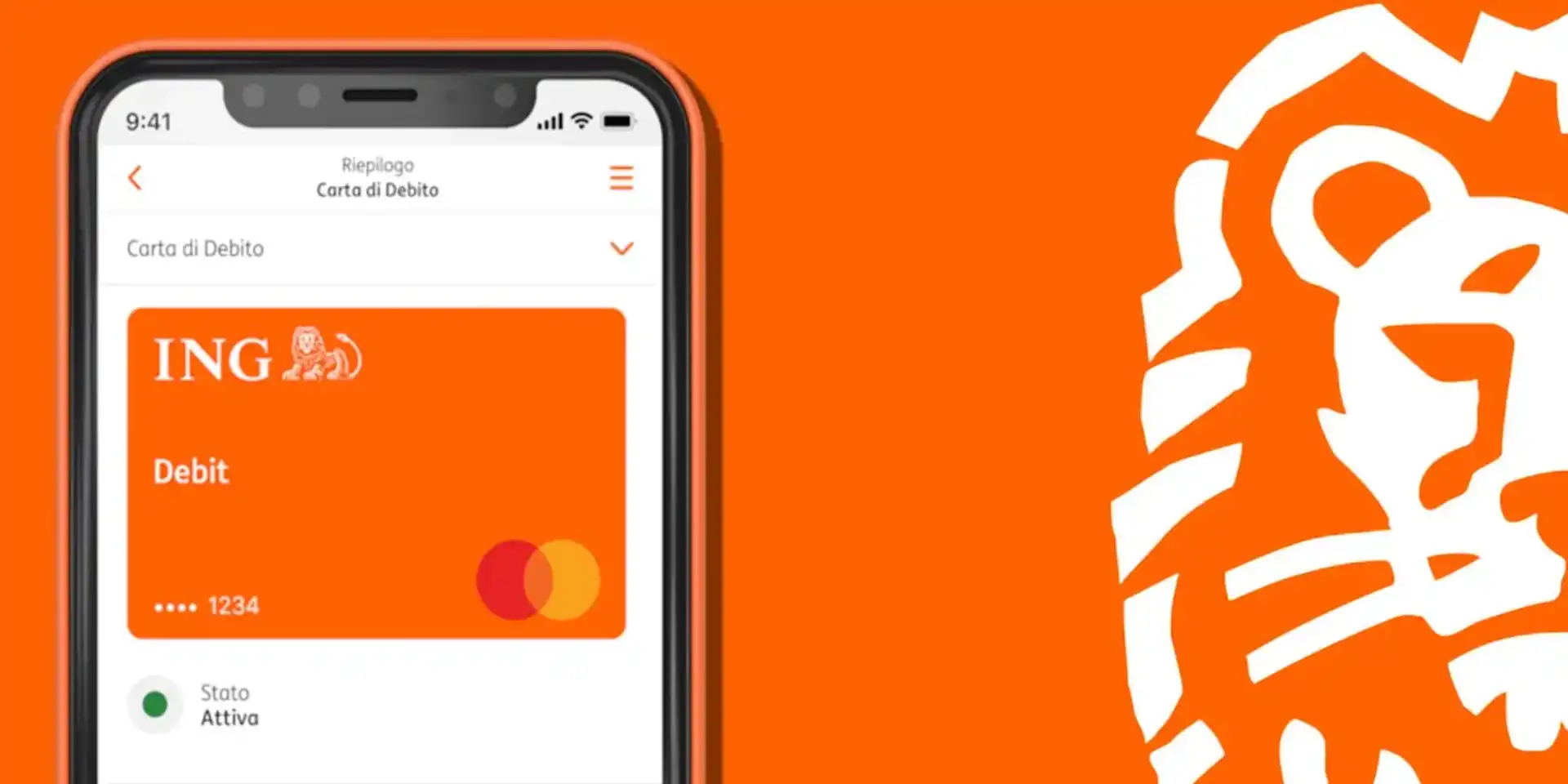










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































