L’impatto del riscaldamento domestico sulla qualità dell’aria


Il lockdown 2020: un periodo senza precedenti per i trasporti
Possiamo dire che chiunque ricorda il lockdown iniziato il 9 marzo 2020, un periodo senza precedenti nel quale la maggior parte delle persone doveva rimanere a casa, le strade erano pressoché deserte e il traffico quasi azzerato. A ricordarlo così ci si potrebbe aspettare un periodo con cieli più puliti e aria migliore, se è vero che molto dell’inquinamento è dovuto ai mezzi di trasporto a combustibili fossili, che in quel periodo erano stati drasticamente ridotti. Eppure, i dati sulla qualità dell’aria raccontano una storia diversa. Proprio in quel mese, nel marzo 2020, i livelli di polveri sottili (PM2.5 e PM10) sono aumentati rispetto alla media degli anni precedenti, specialmente nel Nord Italia. Come è possibile?
La qualità dell’aria durante il lockdown
Per rispondere a questa domanda, in un recente studio insieme ad altri colleghi delle università di Roma Tor Vergata e Torino abbiamo analizzato la qualità dell’aria nei comuni italiani prima, durante e dopo il periodo del lockdown, per comprendere come le restrizioni alla mobilità abbiano influenzato le concentrazioni di inquinanti atmosferici. In particolare, abbiamo sfruttato il periodo del primo lockdown (da marzo a maggio 2020), che ha rappresentato un esperimento naturale senza precedenti per studiare la relazione tra attività antropiche e qualità dell'aria. Sempre in quel periodo è scattato, come ogni anno, l’obbligo dello spegnimento del riscaldamento domestico e degli uffici in base alla zona climatica. Il nostro Paese, infatti, è diviso in sei zone climatiche (dalla A alla F) che determinano quando il riscaldamento centralizzato può essere acceso per legge.
I risultati hanno rivelato un quadro più complesso del previsto. L'effetto del lockdown sulla qualità dell'aria non è stato lineare, ma è stato diverso in base alla particella inquinante e al periodo considerato (Figura 1). Per il biossido di azoto (NO2), principalmente associato alle emissioni del trasporto pubblico e privato, abbiamo osservato una riduzione costante durante tutto il periodo del lockdown, coerentemente con la drastica diminuzione della mobilità documentata dai dati Google, che ha registrato cali fino al 90% negli spostamenti verso luoghi di lavoro. Per le polveri sottili, invece, il pattern è stato più complesso. A marzo 2020, quando il riscaldamento centralizzato era ancora attivo nella maggior parte delle zone climatiche (specialmente nel Nord Italia), le concentrazioni di PM2.5 e PM10 sono risultate superiori (di 2,26 μg/m³ per PM2.5 e 2,44 μg/m³ per PM10) rispetto alla media nei corrispondenti giorni del 2018 e 2019. Ad aprile e maggio, dopo lo spegnimento del riscaldamento centralizzato nelle diverse zone, l'effetto complessivo del lockdown è diventato negativo, documentando un miglioramento della qualità dell'aria. Quello che si osserva dai dati, quindi, è che le polveri sottili diminuiscono a partire dallo spegnimento obbligatorio del riscaldamento, anche controllando per tutti gli altri fattori meteorologici e socioeconomici che possono influire sugli inquinanti.
Figura 1. Livello giornaliero di inquinanti nel 2020 e nel 2018-2019.

Fonte: Beccari, G., Becchetti, L., Conzo, G., Conzo, P., De Santis, D., Salustri, F. (2025). The controversial environmental effects of COVID-19 lockdown on quality of air: evidence from Italian municipalities. Energy Economics, 151, 108904.
Un’ulteriore evidenza a supporto dell’efficientamento energetico edilizio
Questi risultati hanno rilevanza diretta per le politiche europee di efficientamento energetico degli edifici. Per esempio, la recente Direttiva EPBD 2024 (Energy performance of buildings directive, anche nota come "Case Green") prevede, dal 1° gennaio 2025, la cessazione degli incentivi per caldaie autonome a combustibili fossili, mantenendoli solo per sistemi ibridi con quote significative di energie rinnovabili. La nostra ricerca supporta empiricamente questa direttiva. Il riscaldamento residenziale basato su combustibili fossili costituisce una fonte principale delle concentrazioni di particolato, con effetti che possono addirittura contrastare eventuali benefici derivanti dalla riduzione della mobilità. La sostituzione delle tecnologie di riscaldamento tradizionali con sistemi a basse emissioni, come per esempio le pompe di calore elettriche o qualsiasi sistema che usi energia da fonti rinnovabili, rappresenta quindi un intervento prioritario per migliorare la qualità dell'aria, specialmente nelle aree urbane densamente popolate. La transizione verso edifici a emissioni zero, prevista dalla Direttiva europea entro il 2050, non è solo una necessità climatica, ma anche una priorità per la salute pubblica, come documentano le oltre 50.000 morti annue in Italia attribuite all'esposizione a particolato secondo l'Agenzia europea dell’ambiente. Delle quali dovremmo ricordarci ogni volta che rimandiamo il problema.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































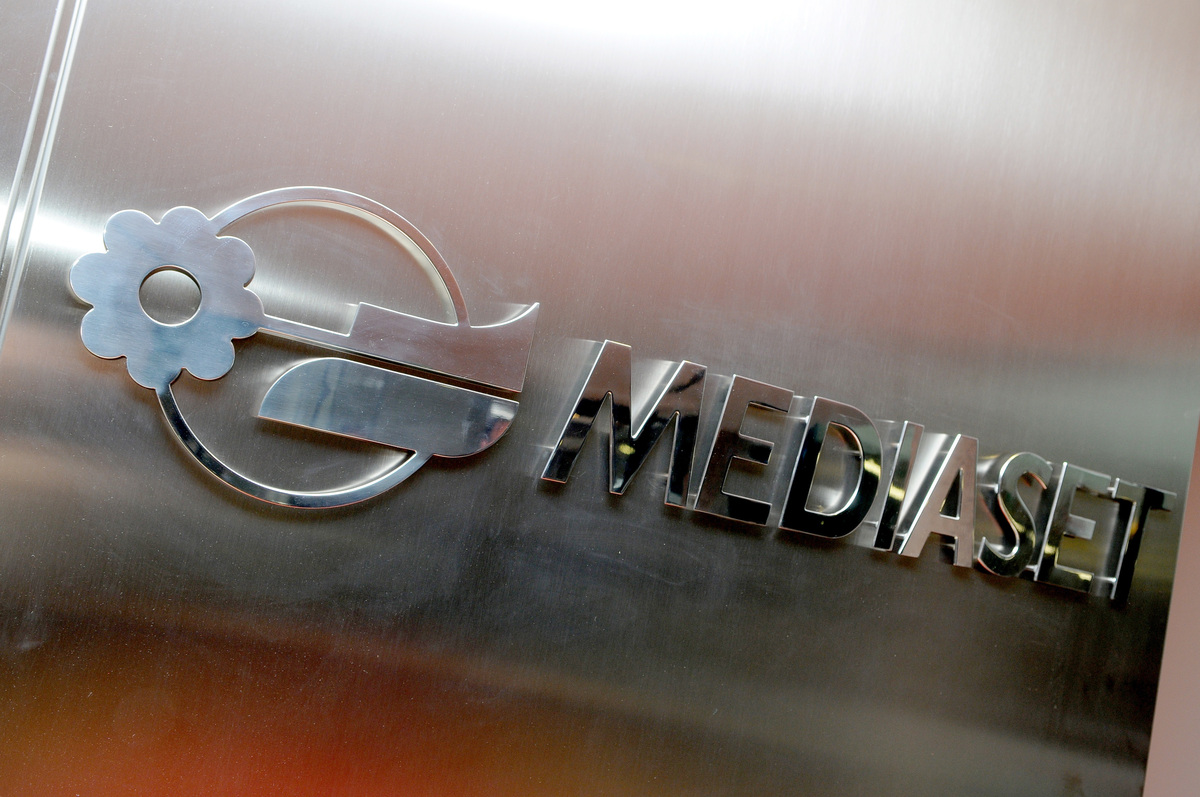























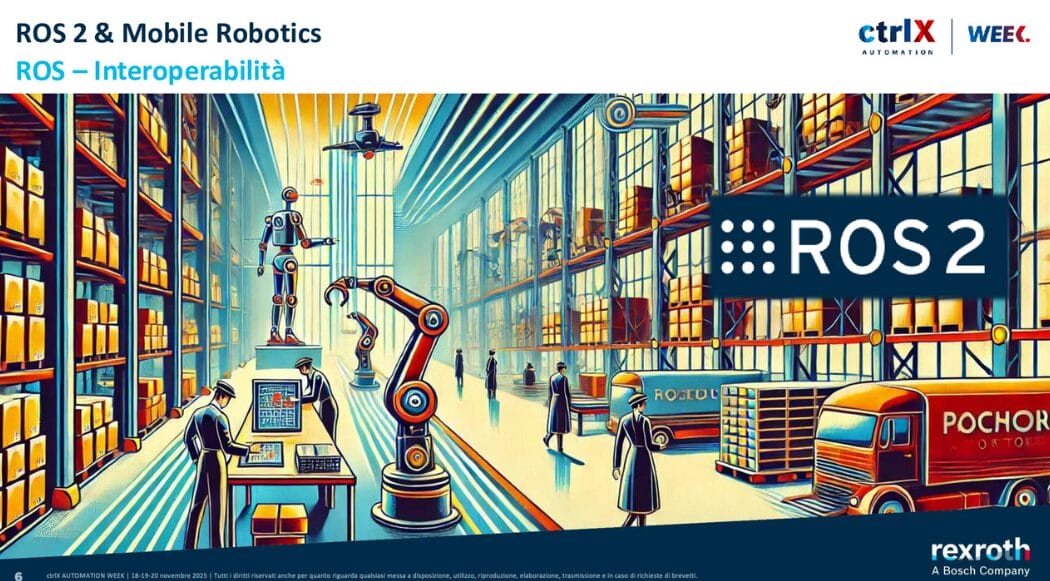











































































































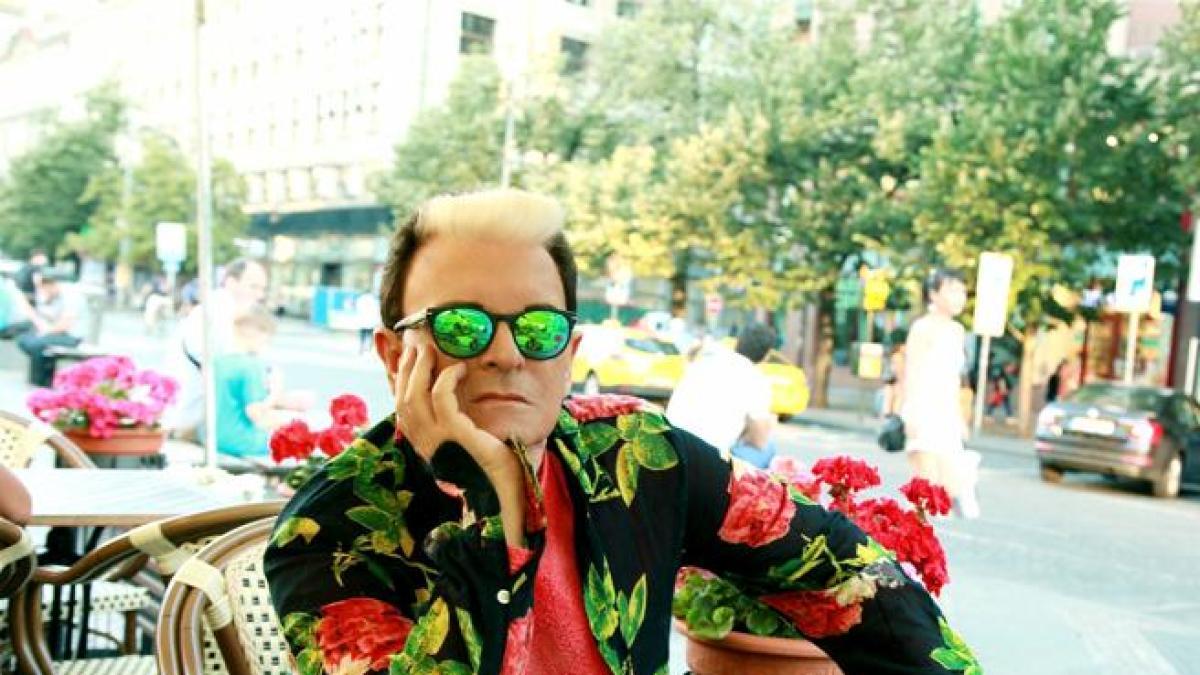

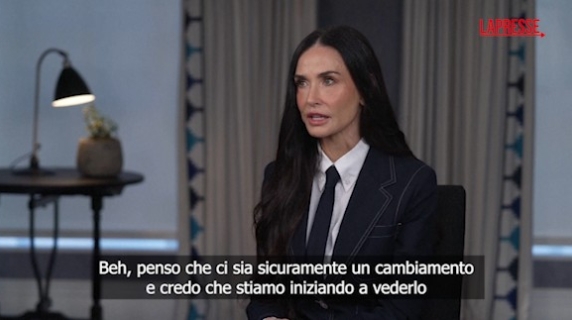




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































