Mondadori, gli spazzini di Birmingham, e quelli che non sanno fare il loro lavoro


Che cos’hanno in comune gli spazzini di Birmingham, il libro di Mauro Corona, il cappuccino imbevibile di ieri mattina, l’autista che deve venirmi a prendere in aeroporto, la mancanza di infermieri negli ospedali? Hanno tutti in comune l’essere espressione d’una deriva temo irreversibile.
L’aneddoto che racconto più spesso a cena è d’una ventina d’anni fa, e si svolge in una spa thailandese di lusso, un comprensorio turistico dove a farsi trattamenti di bellezza andava Kate Moss e noialtre provinciali convinte che emularla ci avrebbe rese parimenti fighe.
Alla fine del mio soggiorno, il direttore dell’albergo mi chiese se ero soddisfatta, e io gli dissi che, abituata alle massaggiatrici italiane con cui è impossibile rilassarsi perché vogliono fare conversazione, ero deliziata dal non aver in dieci giorni sentito la voce di nessuno dei lavoratori della spa se non nelle parole «is the pressure all right?».
È a quel punto che, dico in genere ai miei commensali, si capisce che era un mondo senza telefoni con la telecamera e quindi con meno timore di linciaggi e danni reputazionali. Al punto in cui il direttore dell’albergo mi spiega che lui il personale lo fa andare, prima di iniziare a lavorare, per sei mesi nel paesino vicino al quale si trova l’albergo. Dove, diversamente da Bangkok, non c’è niente: non un cinema, non un centro commerciale, niente. Una specie di rieducazione: «Devono capire che la loro vita è servire».
Questo è il punto in cui lo screenshot è accompagnato dalle parole «Soncini è per lo schiavismo», e quello di oggi è il mondo in cui quella cosa lì il direttore non la direbbe più, ma non solo per il terrore di passare per schiavista agli occhi dei moralizzatori: perché, ve lo dico senza bisogno di tornare a controllare se il servizio in quel posto sia peggiorato, oggi non riuscirebbe a disintossicare nessuno dalle distrazioni, per le quali non servono più né il cinema né il centro commerciale. Le abbiamo in tasca, assieme all’illusione che sia sano avere più ambizioni che talenti.
Tutto questo ha prodotto una deriva in cui nessuno, in nessun codice postale, in nessun settore, in nessuna fascia d’età o di reddito, sa o vuole o può fare più nessun lavoro. Può essere che sia una buona notizia per i lavori più umili – il fattorino di Glovo che sbaglia indirizzo nonostante abbia una cartina nel telefono se ne fotte di far bene il suo lavoro perché in realtà vuol fare il concorrente di “Amici” – ma anche lì non è detto: e se poi il talento per “Amici” non ce l’ha e in compenso come fattorino è troppo scarso per contare sulle mance?
Se anche a voi è venuto in mente, alla notizia della morte di Mauro Di Francesco, di rivedere “Sapore di mare 2”, avrete notato che quel che era esilarante nell’83 – il commendatore che pensa la servitù dei tempi di suo padre sì fosse efficiente, l’autista che s’indebita per fare anche lui le ferie al Forte perché non è che contesta le classi sociali: non le capisce proprio – oggi è noiosamente documentaristico: certo che lo chauffeur non sa vuole può fare il proprio lavoro, come tutti.
Temo d’aver già scritto che, da sempre, una delle cose che mi fanno più dare testate al muro sul lavoro è la risposta «eh, può capitare». E anche d’aver già scritto che il più incredibile degli «eh, può capitare», in una vita di capiredattori cialtroni, lo sentii da uno che aveva sbagliato il nome di una assai famosa rubrichista in cima alla sua nuova rubrica (giuro che non ero io: mi hanno sbagliato nome quasi ovunque, ma ancora non nelle rubriche sui giornali).
Ieri i ricordi di Facebook mi hanno riproposto un post di otto anni fa. Mettevo crudelmente a paragone due cose che mi erano appena successe: la pubblicazione d’un editoriale su un quotidiano americano, e quella – su un settimanale italiano – d’un articolo sul primo documentario mai girato su Joan Didion.
La sinossi della prima esperienza faceva così: «Invio di prima stesura. Lunga telefonata in cui la editor comunica: parti che sfoltirebbe, che aggiungerebbe, riferimenti che vuole ampliati, focus che le sembra importante, oltre a farti molte domande che ti aiutino a capire che minchia volevi scrivere. Primo invio suo di testo rivisto. Tra note con suggerimenti, note con richiesta di bibliografia, tagli, aggiunte, rimaneggiamenti di frasi, sono 217 revisioni in tutto. Segue invio mio, reinvio suo, un totale di una sessantina di mail e undici versioni del testo. Alla sessantesima mail, quando pensi che più di così si sviene, ti scrive: allora abbiamo finito, passo il testo ai fact checker».
La sinossi della seconda (più ordinaria nelle mie giornate) così: «Mandi un pezzo su Joan Didion. Nessuno apre il file. Il giorno dopo, quando lo stanno passando a due minuti dalla chiusura, qualcuno – avendoli tu terrorizzati circa il cambiare cose senza chiederti, sennò come procedura standard manco ti consulterebbero – ti scrive che non capisce l’“infine” in “a 83 anni, è infine protagonista d’un documentario”. Rispondi che è per legarsi alla frase successiva sul perché non ce ne fosse uno finora. Dopo cinque minuti ti chiamano dicendo che non hanno capito. Spieghi: è il primo documentario su di lei, è strano, essendo lei un personaggio gigantesco della cultura americana, e il regista racconta, come hai scritto, di averglielo chiesto anche lui, come mai niente finora. Poi aggiungi “ma se vi dà fastidio toglietelo”. Ti dicono che sì, è meglio, fila di più. Quando il giornale arriva in edicola, c’è scritto “a 83 anni, è per la prima volta protagonista d’un documentario di Netflix”. Che in italiano vuol dire che ne aveva già fatti per Sky, NatGeo, e persino RaiStoria». Probabilmente mi dissero: eh, può capitare.
Otto anni dopo, è più facile che i modi del quotidiano americano abbiano preso a somigliare a quelli del settimanale italiano che viceversa: il mondo si è italianizzato.
Birmingham è piena di spazzatura perché gli spazzini sostitutivi presi perché i titolari erano in sciopero non vanno neanche loro a lavorare; il New York Times racconta che quelli che di mestiere devono curare le allergie ci hanno messo quindici anni di allergia alle arachidi in crescita per capire che tenere i bambini distanti dalle arachidi più che dal fuoco non faceva mai sviluppar loro la tolleranza; il cappuccino una mattina ti arriva senza schiuma, una troppo caldo, una si son dimenticati che l’avevi chiesto decaffeinato; l’autista al quale chiedi disponibilità tra una settimana dopo ti risponderà dopo sei giorni (nel frattempo l’avrai rimpiazzato con uno spazzino di Birmingham); e l’unica soluzione possibile alla mancanza di infermieri sarebbe pagarli di più.
Solo che i soldi per pagarli di più non ce li hai. Ce li avresti tagliando le pensioni a gente che ormai vive cent’anni e pretende di continuare ad andare in pensione a sessanta, ma non lo puoi fare perché perderesti il consenso dei giovani, giovani che non vogliono possono sanno lavorare, e contano quindi sull’essere mantenuti dalle pensioni dei nonni.
Una settimana dopo l’uscita del nuovo libro di Mauro Corona, l’editore Mondadori ha pubblicato un contrito post: «Cari lettori, ci siamo accorti di un errore. Nel nuovo libro di Mauro Corona, “I sentieri degli aghi di pino”, uscito martedì scorso, mancano tre pagine tra il capitolo 8 e il capitolo 9. Sono pagine che sono saltate durante la composizione del file a partire dai quaderni di Mauro», e io vorrei sapere tutto di questa vicenda.
In che senso a partire dai quaderni di Mauro, quello vi dà i quaderni e voi li mettete in fila? E in che senso una settimana dopo, per una settimana (per tre settimane, considerato che avete tutti, autore ed editore, le copie stampate un paio di settimane prima dell’uscita) nessuno ha aperto il libro? O il libro è così a caso che anche leggendolo era difficile accorgersene? Chi se n’è accorto, Bianca Berlinguer? Un lettore al firmacopie? Un nipote dell’autore che voleva un prestito e in cambio gli ha svelato l’errore?
Ma una cialtronata editoriale non è esattamente una notizia: credo d’aver già raccontato di quando io, maniaca del controllo all’estremo opposto rispetto a Mauro Corona, mi accorsi mentre si avviava la stampa che la bozza vss (visto si stampi, quella così tante volte rivista che nessuno mai la rilegge, nessuno tranne me) conteneva un «i sms», perché l’accuratissimo redattore cui avevo detto di cambiare «messaggi» in «sms» non aveva preso l’iniziativa di sostituire l’articolo determinativo. Poi dice li rimpiazzano con l’intelligenza artificiale.
La vicenda Mondadori/Corona non è eccezionale. A essere illuminanti sono i commenti all’annuncio su Instagram. «Ciò vi rende umani». «Grandi, umiltà». «Solo chi non lavora non sbaglia!». «Bravi perché avete spiegato con chiarezza che sbagliare è normale e naturale. Spero manterrete anche internamente questo atteggiamento, non solo a favore di social». Un mondo di gente che non sa può vuole fare nessun lavoro non solo trova rassicurante che neanche gli altri sappiano vogliano possano fare il loro, ma ci tiene a scongiurare il pericolosissimo precedente che, se uno si dimostra proprio negato in un lavoro, qualcuno lo preghi di sgomberare la scrivania.
L'articolo Mondadori, gli spazzini di Birmingham, e quelli che non sanno fare il loro lavoro proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






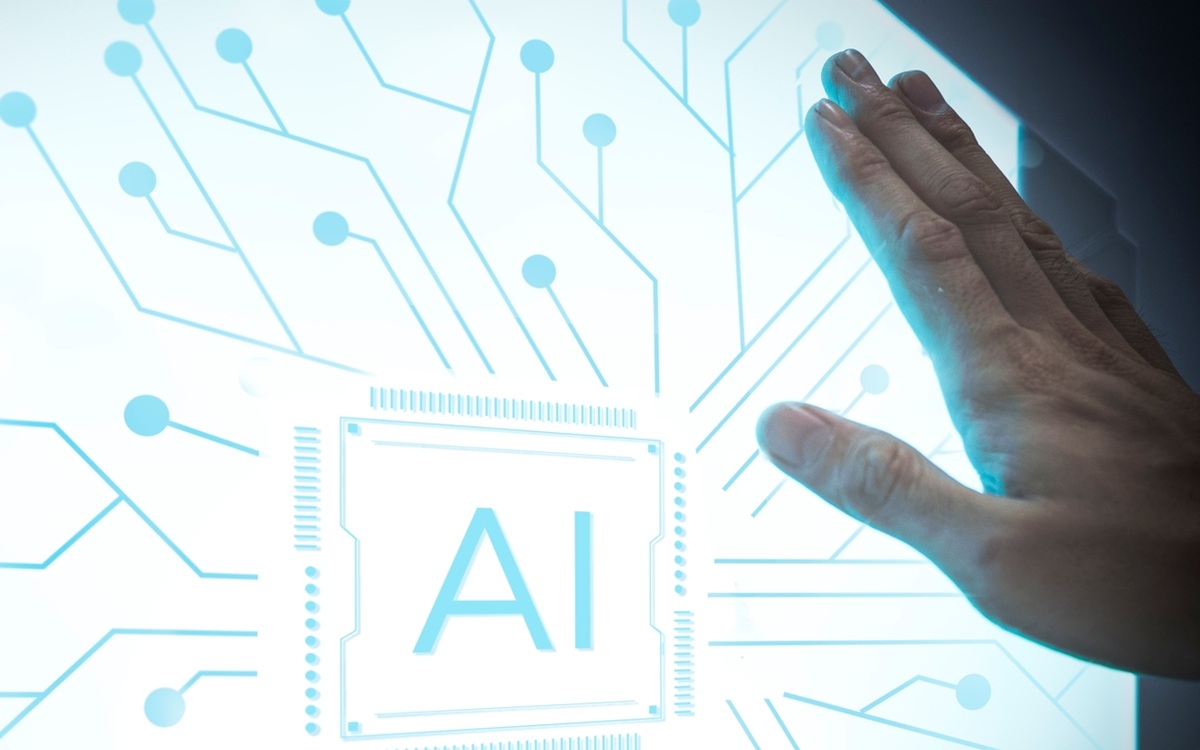









































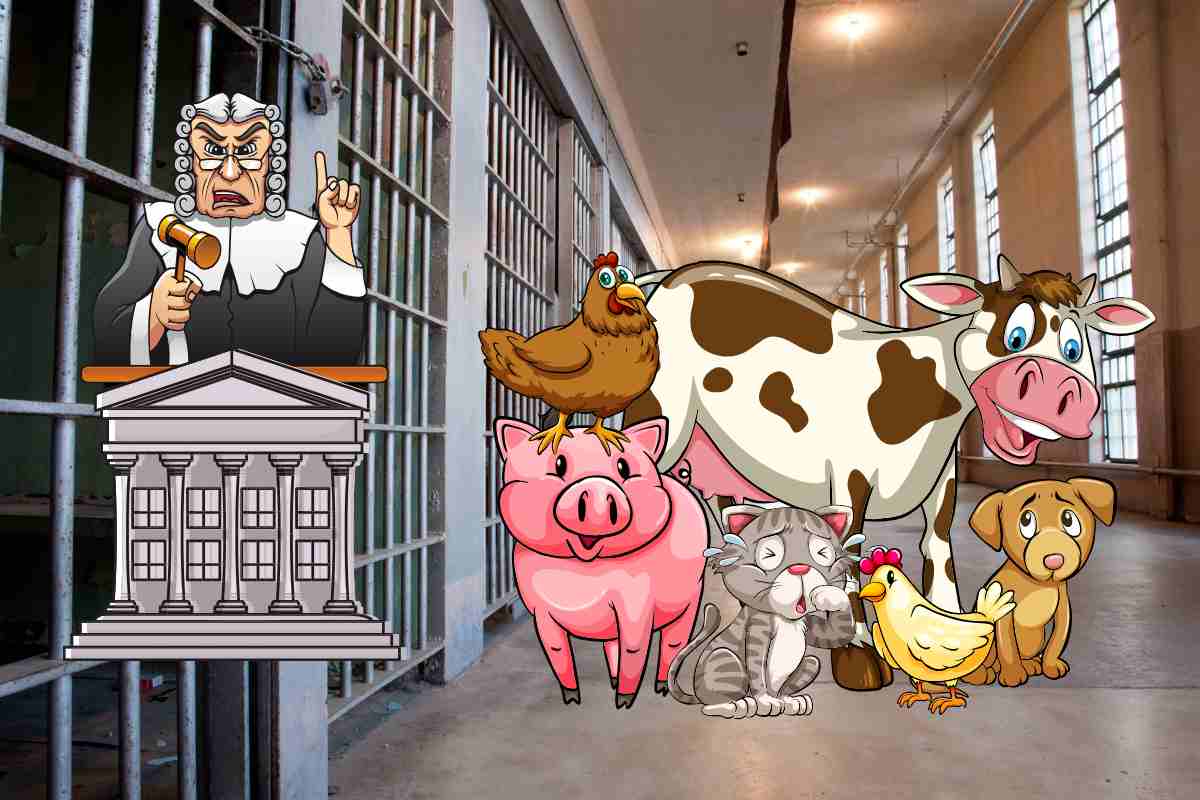









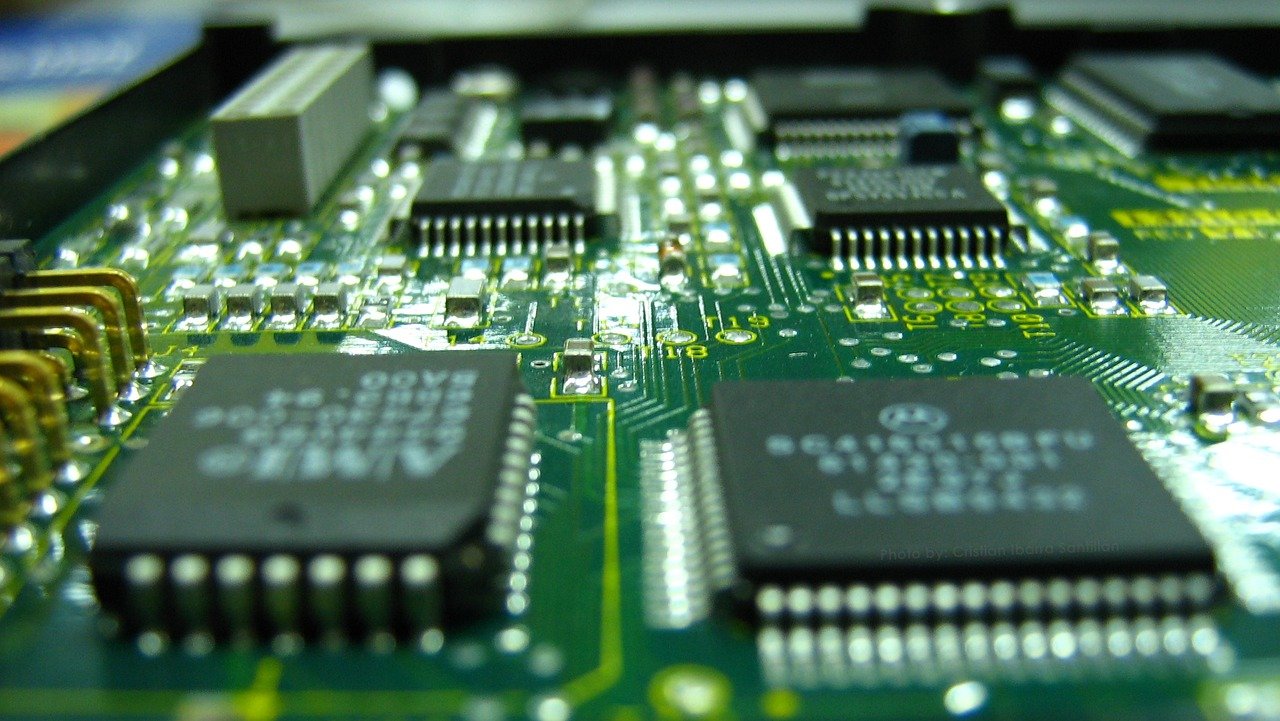

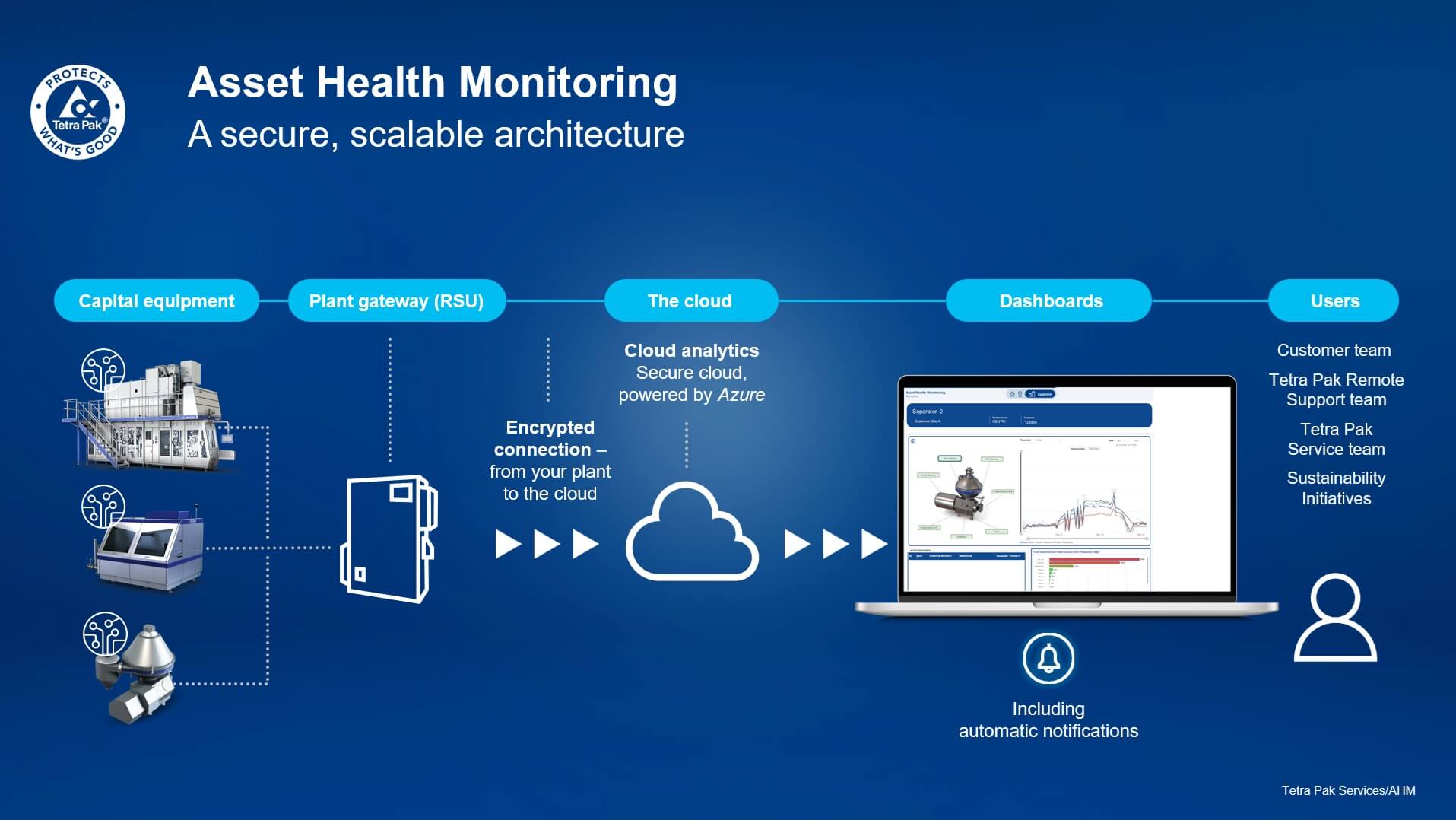
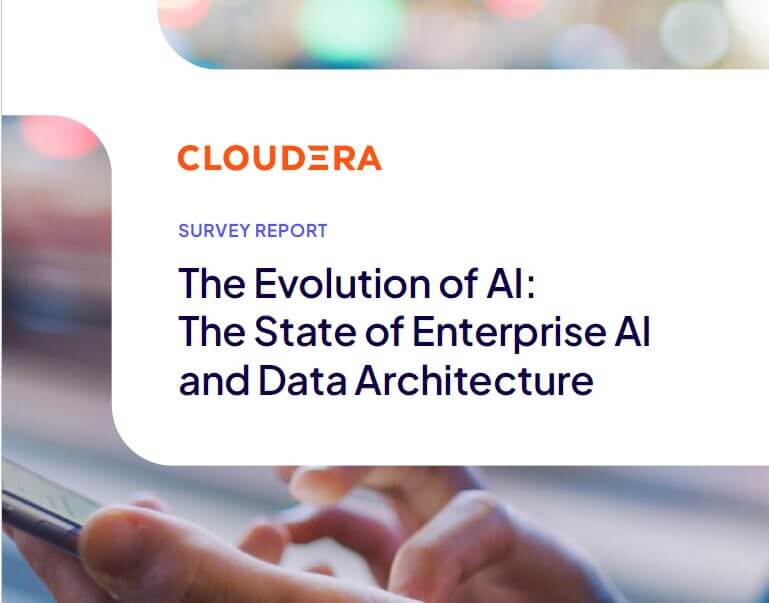
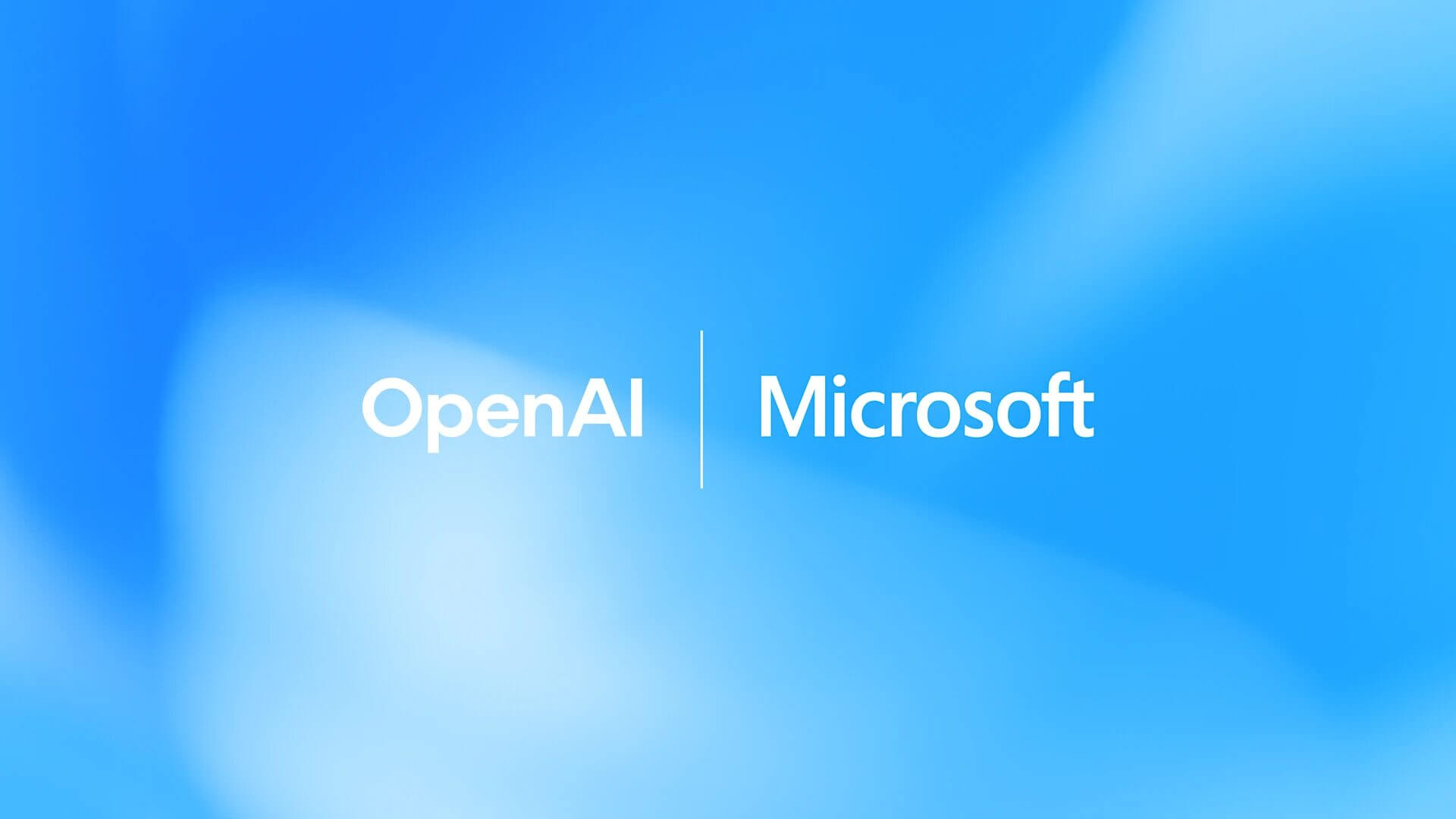

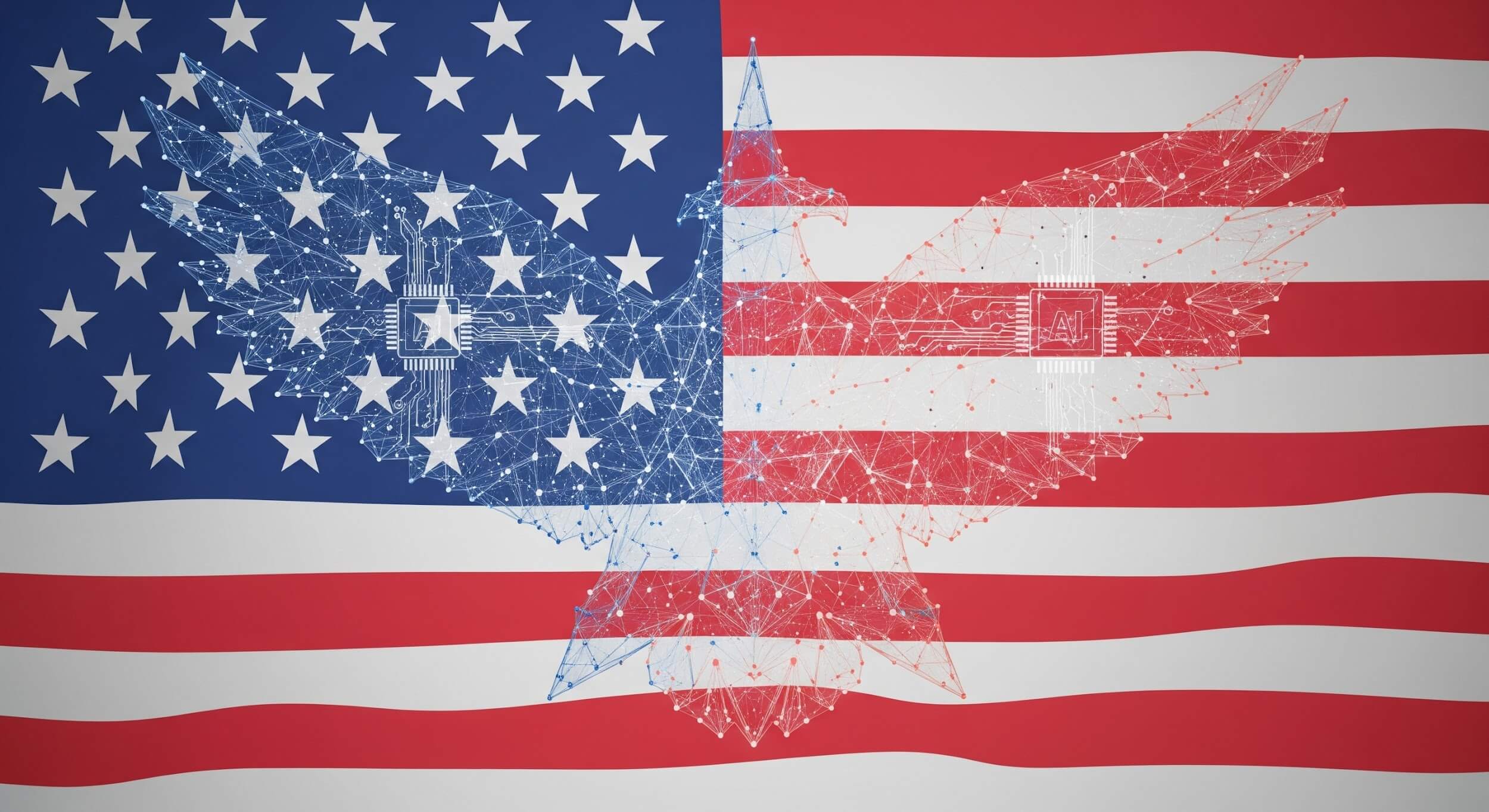















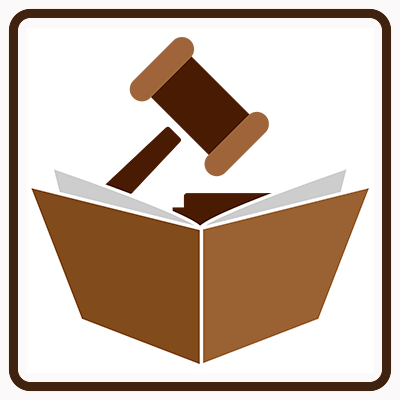




















































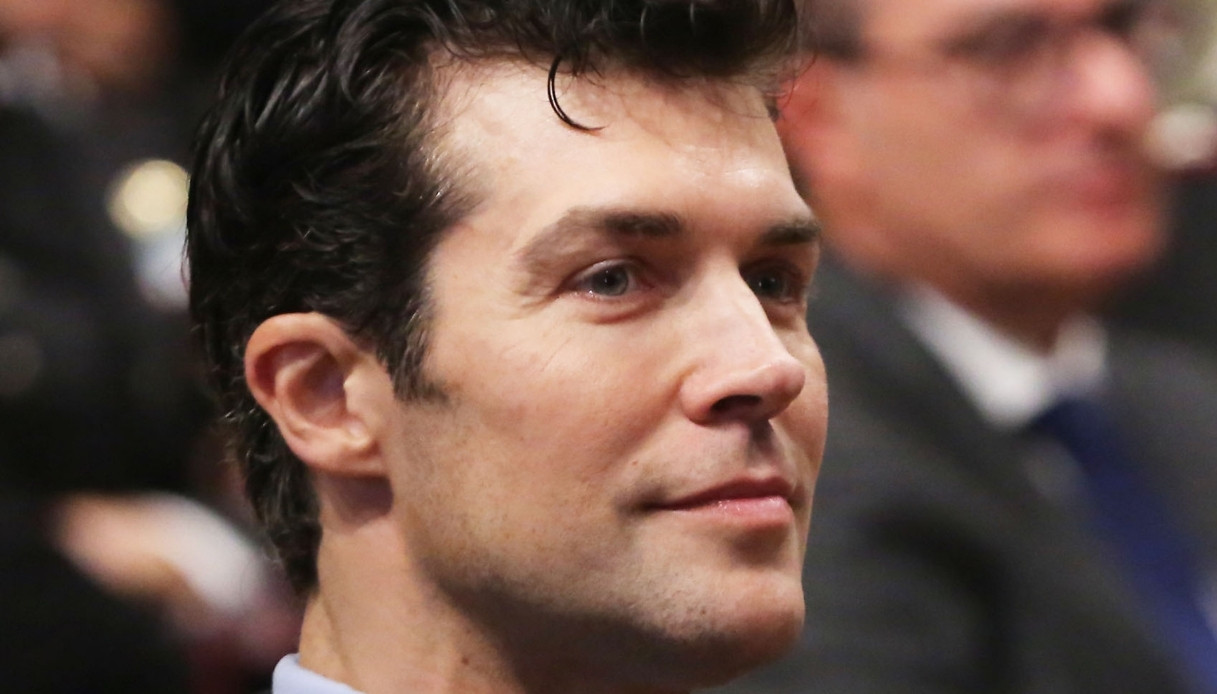

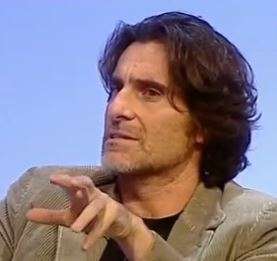

























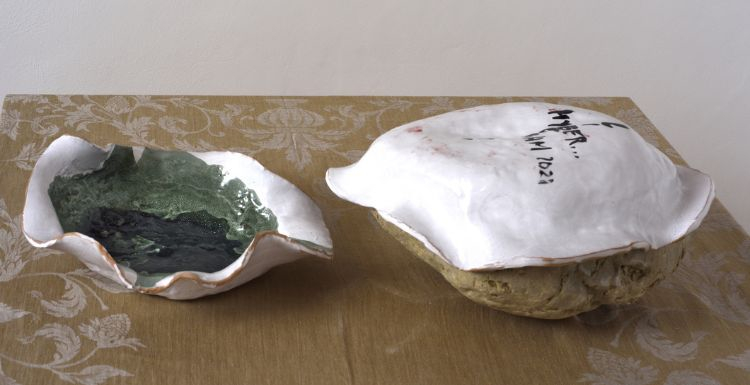





















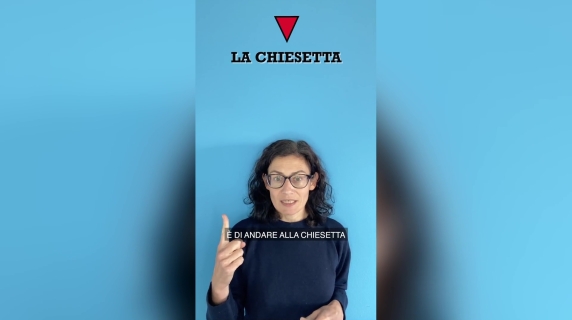


-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































