Che cosa rimane quando impari che puoi stare senza tutto


Chiara apre la gabbia del canarino per pulirla.
Abbiamo dieci anni, ma a me nel ricordo sembriamo due adulte. La cucina è sui toni del marrone chiaro e del giallo. Lei tira fuori il canarino mentre le due sorelle piccole, gemelle, saltellano eccitate per la stanza.
– Vuoi tenerlo? – mi dice. Io allungo le mani ma il canarino si mette a battere le ali fortissimo, un rumore insostenibile. Mi faccio indietro. – Fa schifo.
Lei ride. – Dài, prendilo! – mi porge il canarino che batte le ali convulso ma non vola. Scuoto la testa.
– Prendilo!
– Manco morta, – mi rabbuio. Poi ho un’idea: – E se lo lasciassimo libero per casa?
Chiara ride: – Sei pazza. Tu sei sempre pazza.
– Dài! – dico, e ormai ho deciso. La convincerò a tutti i costi. – Dài! Vediamo cosa fa! – Chiara dice no, no, no. Abbiamo dieci anni ma sappiamo già che, per motivi diversi, io e lei non siamo come i nostri compagni di classe, non siamo come i nostri coetanei, non siamo come gli altri. Lo sappiamo in modo definitivo. Le nostre famiglie sono diverse dalle altre. I nostri genitori sono diversi dagli altri. Per questo so perfettamente che non dovrei insistere. Chiara e io sappiamo in modo molto piú netto di tanti nostri coetanei cosa vuol dire la parola «conseguenze». Lo stesso dico: – Eddai! – ancora una volta.
Lei adesso tituba. Poi, alla fine, cede; come ogni volta. Diventa serissima, dice: – Siamo morte. Però lancia in aria il canarino e quello vola, e le sue sorelle ridono. E pure io rido, ma di meno perché voglio semplicemente godermi il suo sorriso, soprattutto se è merito mio. Guardo Chiara a cui adesso si accendono gli occhi mentre guarda volare il canarino.
– Vola! Vola! – dice, e lo segue felice nella stanza muovendo le mani sotto l’uccellino, come per far galleggiare un palloncino in aria. In tutto quel gioco, ci accorgiamo troppo tardi delle chiavi nella toppa.
– Non aver paura, – le dico, il cuore mi batte cosí forte che non sento niente, – ci sono io con te.
– Ho paura, – mi dice, – ma ci sei tu con me.
Ci prendiamo le mani, come due supereroi pronti alla lotta. Solo che poi perdiamo sempre.
Oppure no.
***
Il panino con la frittata non l’avevo mai mangiato.
Chiara aveva nove anni, i capelli neri, lunghi, lisci, le sopracciglia folte con una leggera peluria che le univa al centro, un’ombra scura anche sulle labbra, gli occhi marroni e la pelle olivastra quasi che qualcuno avesse deciso a tavolino «come la facciamo una bambina del Sud?», un grembiule bianco abbottonato fino al collo, appena stirato, lindo, e mi stava tendendo una metà del panino. Poco prima, lo aveva diviso a metà leccandosi le labbra per la concentrazione, attentissima a non sporcarsi il grembiule. Io ci stavo mettendo una vita a decidere se prenderlo.
Frequentavamo la stessa classe dal primo giorno di scuola, adesso facevamo la quinta elementare ma non ci eravamo mai parlate davvero. O meglio, io non le avevo mai parlato. A lei, e in linea di massima a nessuno. Quindi mentre Chiara mi tendeva il panino io la guardavo, ponderavo se prenderlo o meno e nello stesso momento riflettevo sul suo essere cosí dichiaratamente una «bambina del Sud».
Chiara, avrei scoperto, non era nemmeno del Sud, la sua famiglia veniva dall’Albania. Erano arrivati a Bari ai tempi del nonno o del bisnonno; suo padre era barese fino al midollo, non sapeva una parola di albanese, sua madre era bionda, di stirpe normanna, aveva la pelle chiara chiara e si prendeva le botte zitta e buona in perfetto stile del Sud. Aveva una voce finissima. Anche quando suo marito se la mangiava, lei era come fosse tutta concentrata a cercare di intonare una nota troppo alta, a cui non arrivava: «No, ti prego Raffaele». Non le davi davvero peso, perché non sentivi la paura, ma questo impegno totale nel bel canto. Oppure, sempre calma, con la nota alta: «Dài Raffaele, non davanti alle bambine». Ma tanto pure le bambine le prendevano.
Per tanto tempo io e Chiara avremmo pensato che non gliene importasse niente, a sua madre, delle botte; e quindi delle figlie. Piú avanti, avremmo capito che dietro il comportamento di sua madre c’era un insegnamento fondamentale: la paura non la devi mai mostrare, altrimenti ti attacca e ti dilania. Non indietreggiare quando ti colpiscono, ma non attaccare nemmeno; solo chi non ha mai avuto davvero ragione di aver paura pensa che la difesa migliore sia l’attacco. Se attacchi, puoi morire. Se sfidi, puoi morire. Il segreto è rimanere immobili. Quando ti attaccano, tu resisti e basta. Si stancheranno di non essere supplicati di smetterla.
Ma queste sono solo parole. A volte funzionano, a volte no. Chiara e io avremmo capito presto che massime, nella vita, non ce ne sono. A seconda di cosa succede, devi fare tu. Si cresce e si impara che la paura ha infinite abilità. Sono strabilianti, le abilità della paura. Una piú spaventosa dell’altra. Solo che noi a quel tempo eravamo piccole e mangiavamo il panino con la frittata lei, il Kinder Brioss io. Piú che di provare a capire, a imparare, cercavamo di stare in campana.
Alla fine però ho ceduto. Ho allungato le mani verso le sue e c’è stata questa specie di contatto. Allora ho visto che Chiara aveva una leggera peluria anche sulle mani. Io odiavo e avrei sempre odiato i peli ma quella sua peluria mi ha fatto pensare subito: che mani carine. Dio, che mani carinissime. Ho preso il panino con la frittata ma mi sembrava una cosa molto da meridionali, e allora siccome volevo distinguermi, e infatti avevo il Kinder Brioss, le ho detto: – P-però è una m-merenda da mia nonna –. Mi sono girata un attimo fingendo di fare stretching e mi sono infilata il panino in tasca, convinta che non mi avrebbe vista.
Invece naturalmente mi ha sgamato subito ma non ha detto niente. Solo: – Ma cosa vuol dire da tua nonna, – piegando un po’ la testa. Qualunque cosa significasse quella serie di azioni – sgamarmi ma non dire niente –, io non lo sapevo ancora ma era molto da Chiara. Parte di quell’enigma, tutto mio, che si chiama Chiara.
A quei tempi una delle ossessioni che coltivavo era cercare di non essere meridionale. Mi veniva dalla mia famiglia. A volte in Puglia finiva l’acqua, perché pure i muri lo sanno che il Tavoliere soffre di sete. Ci dicevano: quelli del Sud non vogliono lavorare e rubano i soldi a quelli del Nord. Noi ci sentivamo un po’ sfigati ma pure un po’ orgogliosi. Per esempio, pensavamo di avere una fortuna che quelli del Nord non avrebbero mai avuto: il mare.
Non dico il mare splendido delle nostre pittoresche città del Sud in cui la gente parla solo in dialetto e staziona dalla mattina alla sera su una sdraio con una birra in mano a prendere il sole, perché al Sud c’è sempre il sole, e poi quando il sole tramonta la gente si alza, si stiracchia, e va a rubare i soldi a quelli del Nord (che poi è sempre un lavoro). Non intendo il mare davanti al quale gli uomini del Sud rubano agli uomini del Nord le loro donne nordiche palesemente inconsapevoli, se le mettono sul groppone e le stordiscono fino a quando queste non li sposano. Non parlo del mare bellissimo ma solcato solo da malavitosi che in aquascooter contrabbandano organi, armi, droga e pesce. Non dico il mare del Sud inquadrato da un sole che è un faro gigantesco tanto che certo che hai sempre freddo, tu, sei freddolosa perché sei del Sud.
Non intendo dire che avevamo il mare nelle nostre città dove i pescatori uccidevano i polpi con un morso in testa e poi li arricciavano sul molo. O il mare del capitone di natale che quando lo ammazzi con un calcio fa un gemito. Dico proprio dentro. Nel corpo. Installato come un pacemaker, dicevamo per tutta la vita che senza mare non potevamo stare. Saremmo morti.
Invece poi si impara che puoi stare senza tutto. Stai senza tutto e hai le mani vuote e alzi gli occhi al cielo perché ti viene istintivo alzare gli occhi al cielo e, mostrando al cielo le mani vuote, un po’ arrabbiato ma anche un po’ fiducioso (te la aspetti una ricompensa, cazzo) dici cristo, e adesso, che si fa? I cani, quando fai finta di tirargli una pallina in alto, in aria, verso le nuvole, contro il cielo, col sole in faccia, e invece non gli hai tirato niente, rimangono a muso in su contro il cielo, col sole in faccia, ad aspettare fiduciosi, anzi non fiduciosi, certi, che la pallina stia per scendere. Aspetterebbero per ore. Smettono solo perché a un certo punto si dimenticano cosa stavano aspettando. Non rimangono delusi. Semplicemente si dedicano ad altro. Ma quando sono lí, col muso in su come un siluro pronto al lancio, con quel nasino che gli sgocciola, stanno tranquilli ad aspettare che torni giú. Devono prenderla al volo. Non hanno paura che la pallina che non hanno visto librarsi nell’aria non torni indietro. Non hanno paura di non prenderla al volo. Hanno solo una voglia pazzesca di prenderla al volo. Cosí, con le mani vuote, gli occhi verso il cielo, e il diritto, che senti cristallino anche se non ne sei conscio, a una ricompensa, ma anche soltanto a una soluzione, cosí anche tu.
Avrei fatto qualunque cosa perché Chiara e io non restassimo col muso in su e le mani vuote. Soprattutto avrei fatto qualunque cosa perché Chiara non lo facesse. L’ho capito quasi subito.

Tratto da “Chiara”, di Antonella Lattanzi, Einaudi, 18€, 176 pp.
© 2025 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
L'articolo Che cosa rimane quando impari che puoi stare senza tutto proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

















































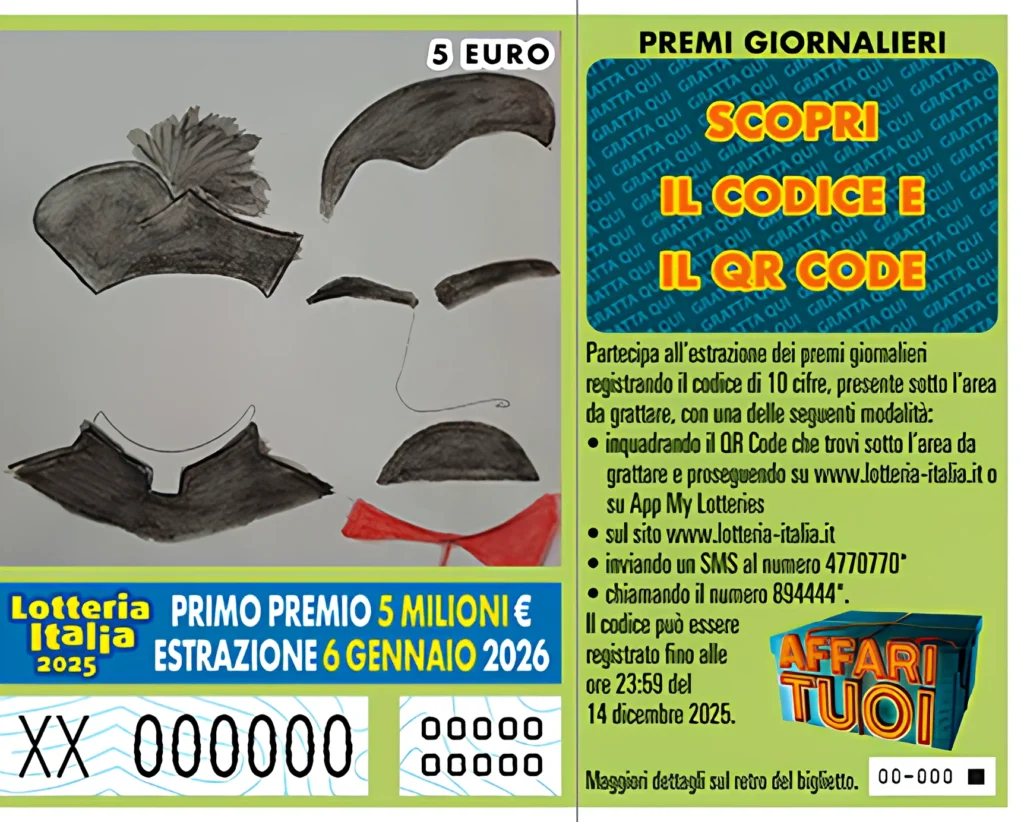








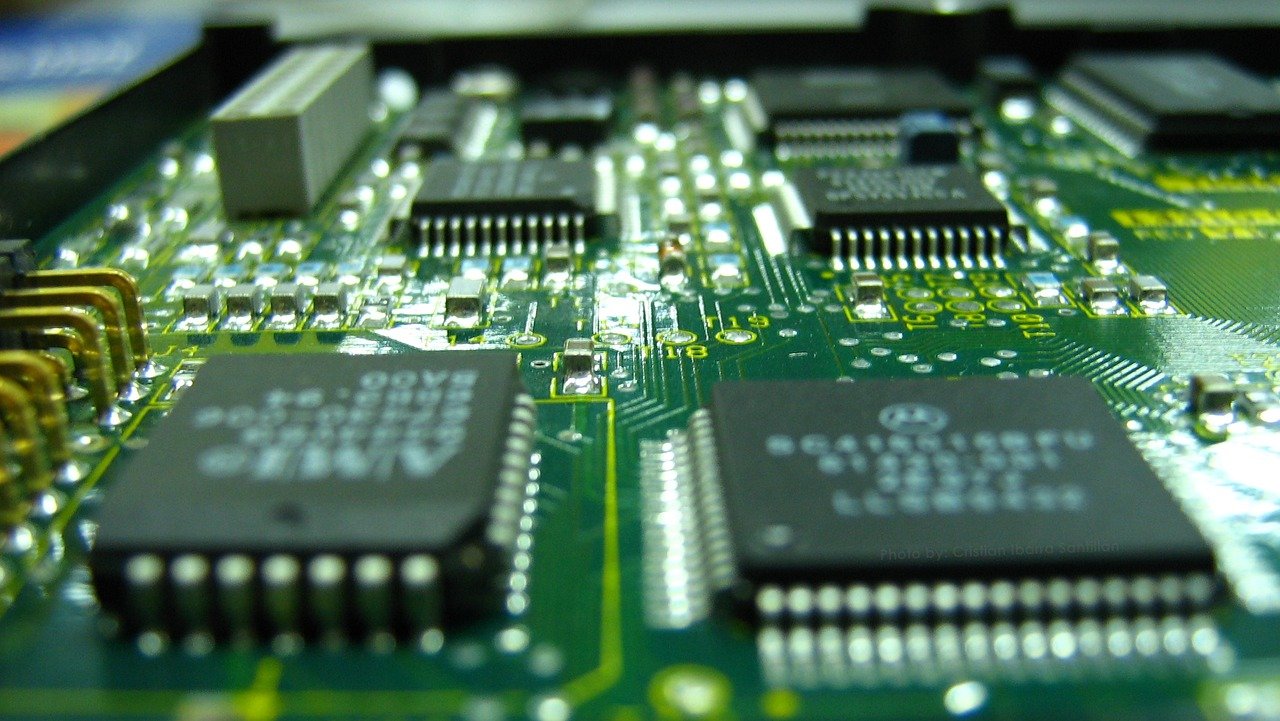

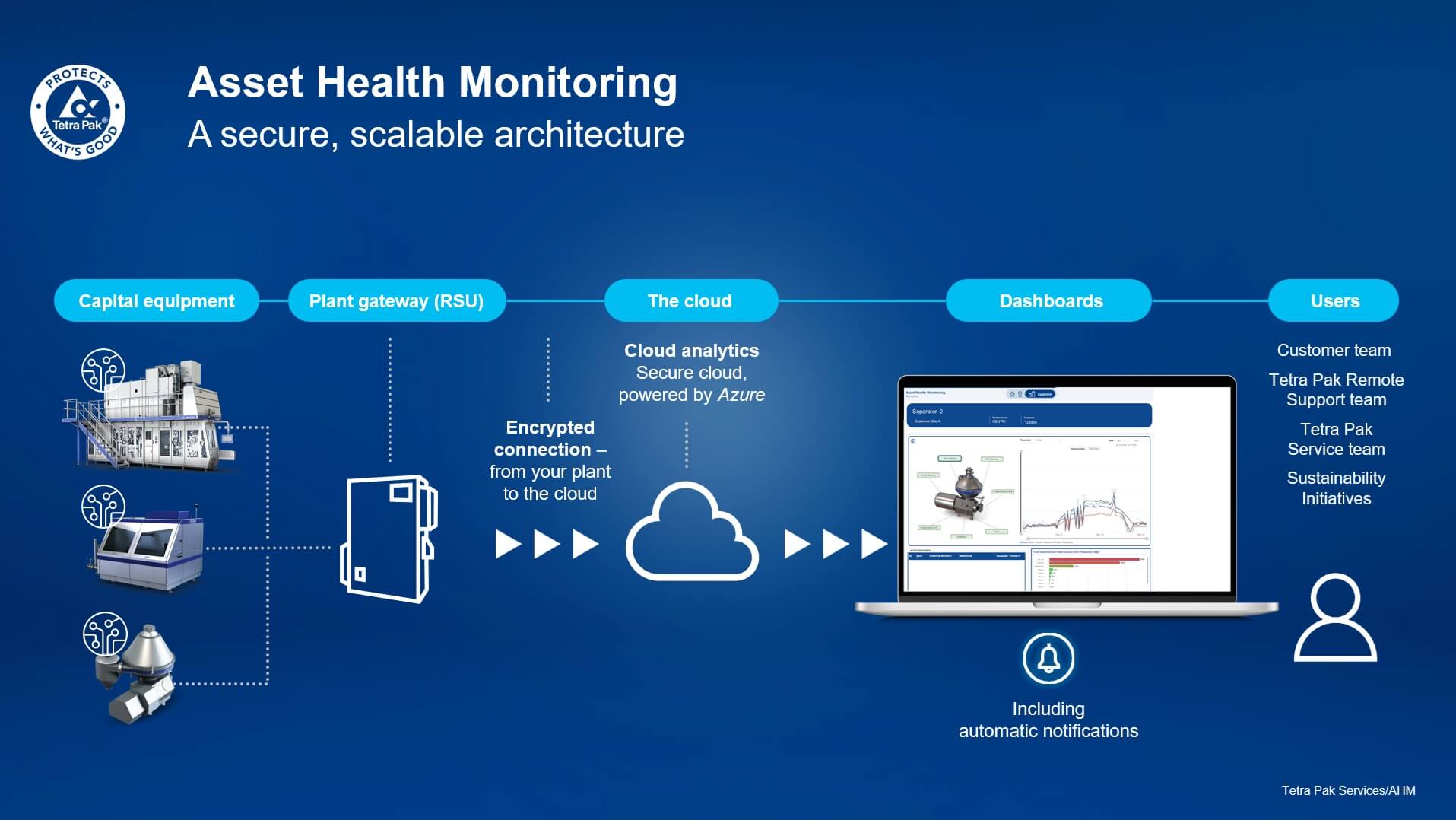
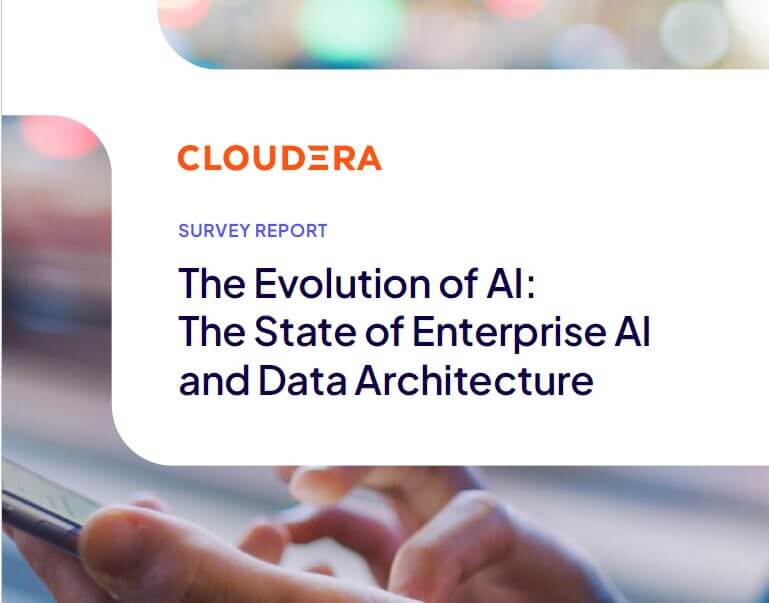
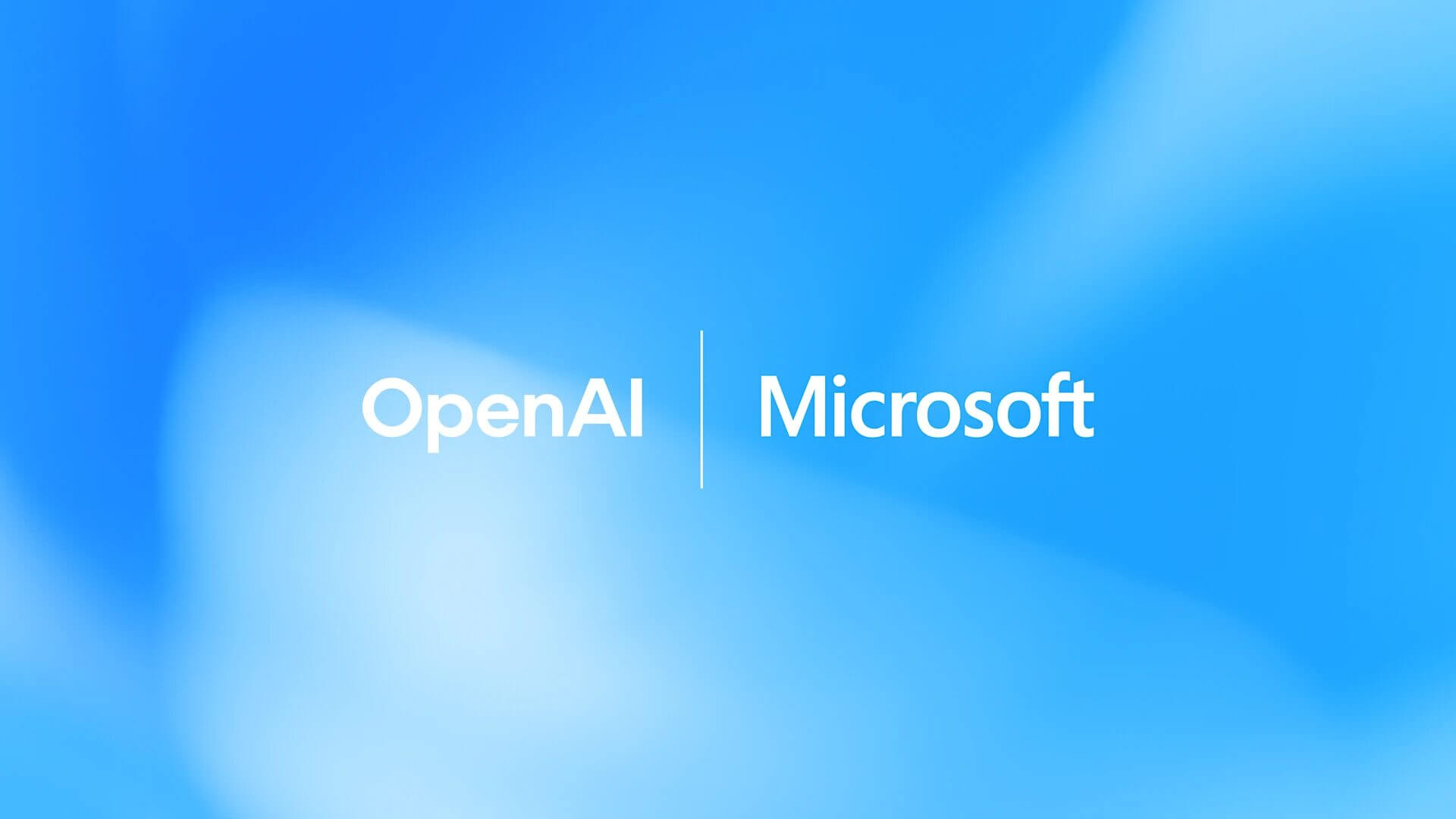

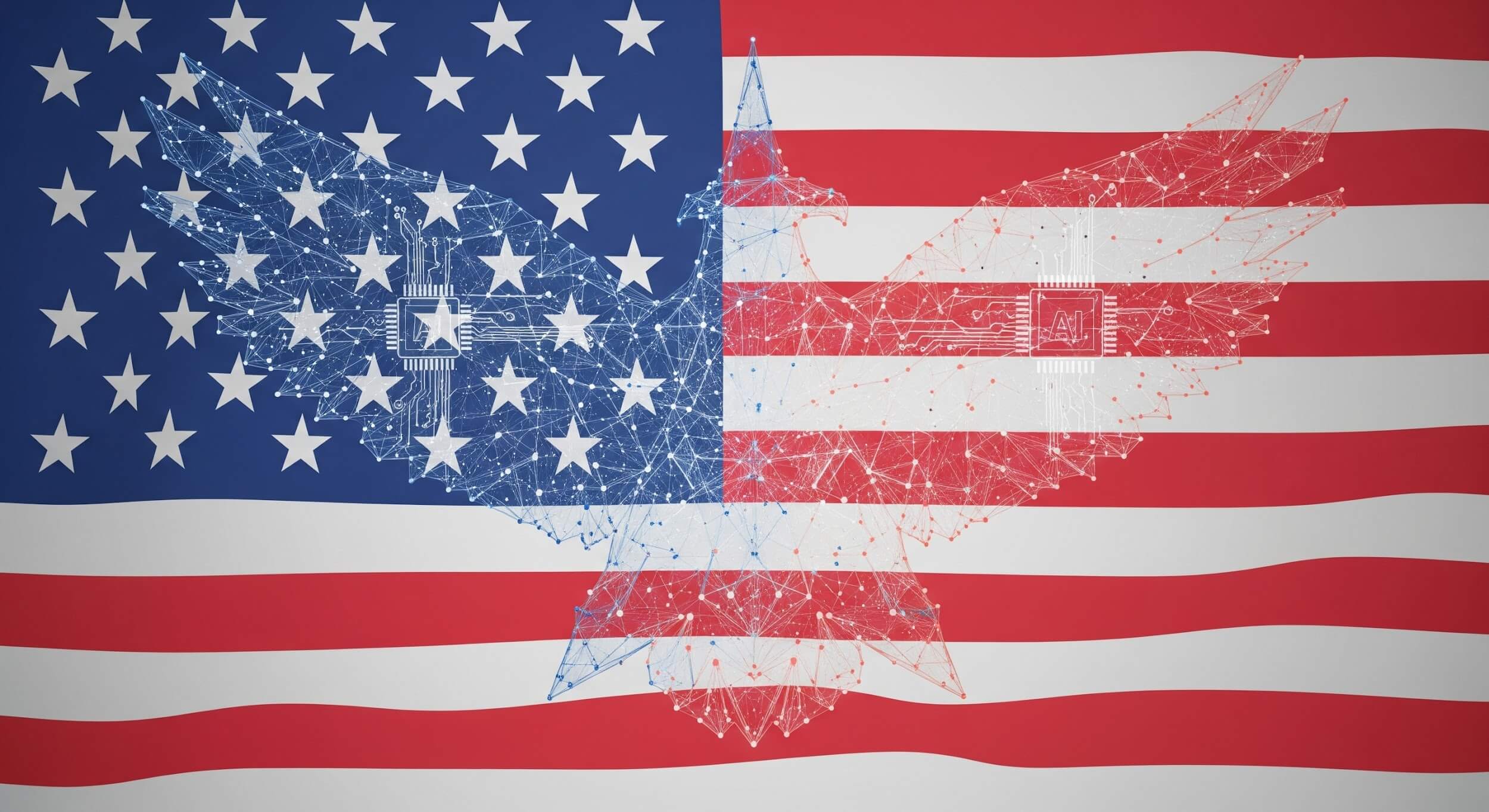















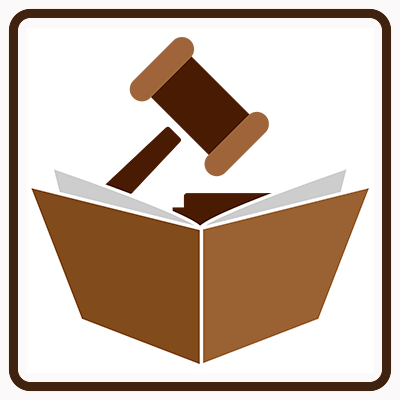








































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































