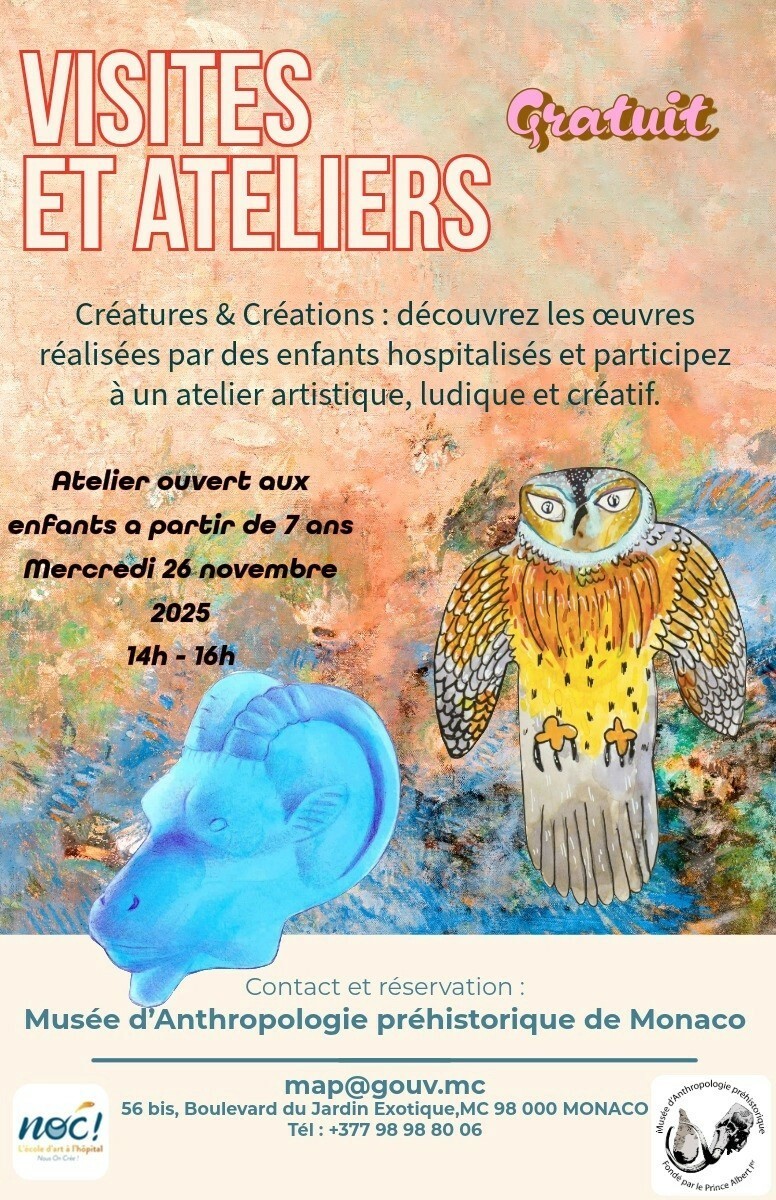Perché il mercato dell’arte indiana corre controcorrente

Il rallentamento generalizzato dei principali mercati dell’arte, determinato dalla contrazione dei capitali speculativi e dall’incertezza macroeconomica, non coinvolge l’India. In un momento in cui New York, Londra e Hong Kong segnalano cali nelle vendite di fascia alta e una maggiore cautela da parte dei grandi collezionisti, il mercato indiano mostra una dinamica opposta: crescita sostenuta delle aste, espansione infrastrutturale e rafforzamento del collezionismo domestico. Questa divergenza è il risultato di un sistema complesso, nel quale si intrecciano stratificazioni storiche, logiche identitarie e strategie finanziarie.
All’inizio del XX secolo la Bengal School of Art elaborò un linguaggio visivo in netta discontinuità con quello coloniale, radicandolo in tradizioni locali e in un progetto culturale nazionale. Questo momento non va letto solo come un passaggio estetico, ma come la costruzione di una piattaforma simbolica sulla quale l’arte poté assumere un ruolo strutturale nella formazione dell’identità moderna indiana. Tale intreccio precoce tra produzione culturale e orizzonte politico ha lasciato un’impronta durevole: ancora oggi, il mercato opera all’interno di una cornice in cui arte e appartenenza nazionale sono strettamente connesse, condizione che differenzia il caso indiano da molti altri contesti emergenti.
Nel 2024 il volume delle aste d’arte in India ha raggiunto circa 187 milioni di dollari (pari a 1.559 crore di rupie), con un incremento superiore al 21% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, la soglia d’ingresso nel segmento alto del mercato è salita da circa 240mila dollari nel 2021 a oltre 920mila nel 2024, segnalando una ridefinizione delle dinamiche di accesso e un consolidamento della domanda qualificata. Le grandi case d’asta internazionali aumentano la loro presenza nel Paese, ma il motore principale resta interno: la crescita è alimentata da capitali domestici e da una nuova classe di collezionisti che non si limita ad acquistare, ma costruisce infrastrutture culturali e simboliche di lungo periodo.
Il mecenatismo attivo
Collezionisti come Kiran Nadar, Sangita Jindal e la famiglia Ambani hanno assunto un ruolo di mecenatismo attivo che va oltre la semplice acquisizione di opere. Il Kiran Nadar Museum of Art, primo museo privato dedicato all’arte moderna e contemporanea in India, è in fase di ampliamento con un nuovo edificio di 100mila metri quadrati, progettato da Adjaye Associates nei pressi di Nuova Delhi, destinato a diventare un centro di riferimento per la scena artistica nazionale.
La Jsw Foundation, guidata da Sangita Jindal, affianca al sostegno alla creazione contemporanea una strategia di valorizzazione del patrimonio storico e artigianale: tra i progetti più rilevanti figura il restauro del complesso di Hampi, antica capitale dell’Impero Vijayanagara nel Karnataka e sito patrimonio mondiale Unesco dal 1986. L’intervento, che ha coinvolto scavi archeologici, conservazione architettonica e programmi educativi per le comunità locali, ha restituito visibilità internazionale a uno dei luoghi simbolo dell’heritage indiano, intrecciando tutela del passato e produzione culturale contemporanea. Parallelamente, la fondazione lavora alla salvaguardia delle arti e dei mestieri tradizionali, sostenendo reti di artigiani e programmi di trasmissione intergenerazionale delle competenze, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di radicamento territoriale.
Anche la famiglia Ambani sta investendo in modo sistematico nella costruzione di infrastrutture culturali: nel 2023 ha inaugurato a Mumbai il Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, un vasto complesso multidisciplinare che ospita teatri, gallerie e spazi espositivi, con una programmazione che intreccia produzione locale e circuiti globali. L’obiettivo è creare un hub culturale di livello internazionale, in grado di posizionare Mumbai come capitale creativa asiatica e di attrarre istituzioni e collezionisti da tutto il mondo.
In questo scenario, il collezionismo indiano non è soltanto una pratica di accumulazione privata: agisce come dispositivo di produzione istituzionale e territoriale, capace di ridisegnare l’ecosistema culturale nazionale e di incidere sul posizionamento internazionale del Paese.
La libertà espressiva a rischio
L’espansione del mercato si inserisce però in un quadro politico e culturale complesso. Secondo Anish Kapoor, la libertà espressiva nel Paese è oggi sottoposta a forti pressioni, e molti artisti praticano forme di autocensura. Questo elemento non va inteso come un fattore esterno, ma come una delle componenti che plasmano il funzionamento del sistema: l’orientamento identitario e celebrativo di molta produzione artistica si intreccia con la domanda dei collezionisti e con le logiche del mercato. In un contesto in cui la legittimazione culturale passa attraverso la consonanza con narrazioni condivise, l’espansione economica non entra necessariamente in contraddizione con un campo espressivo parzialmente vincolato. Nel contesto dell’arte indiana, ‘narrazione condivisa’ non va inteso come un’espressione generica: indica piuttosto l’insieme di valori, temi e simboli condivisi dalla società o promossi dalle élite culturali e politiche, che diventano riferimento per la produzione e la legittimazione artistica (come la mitologia hindu, l’epoca moghul, o l’estetica della Bengal School).
Non solo crescita economica
La traiettoria indiana non può essere ricondotta a un semplice boom quantitativo favorito dalla crescita economica. È piuttosto il risultato di una sedimentazione storica profonda, di un collezionismo strutturato, di strategie finanziarie endogene relativamente indipendenti dai cicli globali e di un rapporto peculiare fra produzione artistica, identità nazionale e costruzione istituzionale. Questo insieme produce un ecosistema complesso, nel quale attori pubblici e privati, capitali economici e simbolici, tradizioni culturali e logiche di mercato interagiscono in modo non lineare.
Nel breve periodo, questa architettura garantisce al mercato indiano una resilienza che molti sistemi occidentali non riescono a esprimere. La combinazione di domanda interna, progetti infrastrutturali e legittimazione culturale fornisce una base solida su cui costruire valore. Ma le implicazioni più interessanti si collocano nel medio-lungo periodo: la capacità del sistema di agire come polo autonomo, dotato di proprie regole e priorità, segnala una trasformazione più ampia nella geografia culturale globale. L’India non si limita a crescere in termini di volumi: sta costruendo un modello alternativo, nel quale la centralità dei capitali locali e delle istituzioni culturali interne riduce la dipendenza dai centri occidentali e apre la strada a una pluralità di poli di produzione e scambio.
Questa configurazione ha potenzialità, ma anche tensioni. Da un lato, la struttura endogena consente al mercato indiano di essere meno esposto ai cicli finanziari globali e di sviluppare traiettorie proprie. Dall’altro, la sfida sarà mantenere equilibrio tra espansione economica, diversità espressiva e apertura internazionale. Sarà interessante osservare se l’India riuscirà a rafforzare le proprie istituzioni, ampliare gli spazi di libertà creativa e consolidare la fiducia dei collezionisti: da questo dipenderà la sua capacità di affermarsi come nuovo baricentro culturale globale, non più periferico, ma protagonista nella ridefinizione delle gerarchie e dei flussi del sistema dell’arte internazionale.
Andrea Rurale è lecturer del dipartimento di marketing all’Università Bocconi.
L’articolo Perché il mercato dell’arte indiana corre controcorrente è tratto da Forbes Italia.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

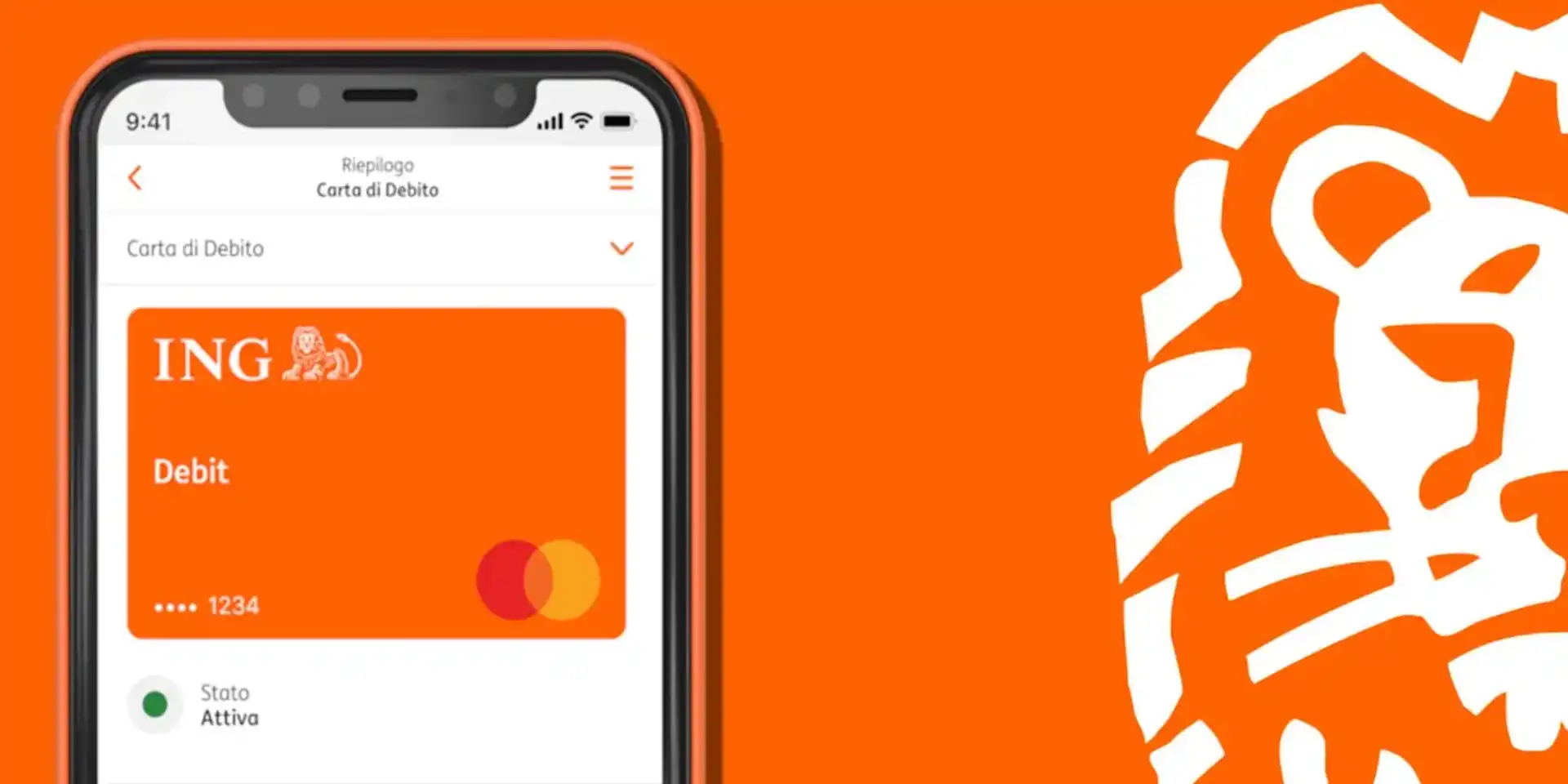














































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)