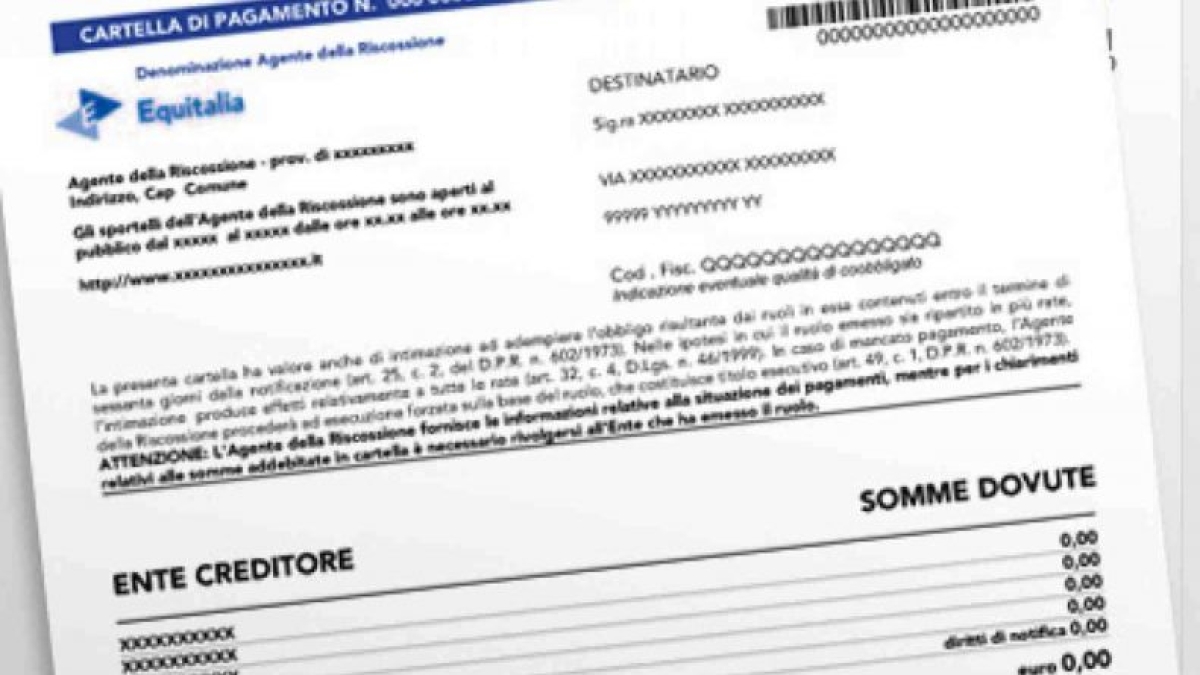Sviluppare applicazioni sicure con i robot, che cosa dicono le edizioni 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2

LE NORME SULA ROBOTICA
Sviluppare applicazioni sicure con i robot, che cosa dicono le edizioni 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2
Le edizioni 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2 rappresentano il nuovo punto di riferimento per la sicurezza nella robotica industriale. I due documenti, aggiornati dopo oltre un decennio, integrano anche i requisiti per le applicazioni collaborative, introducono la valutazione dei rischi legati alla cybersecurity e definiscono una nuova classificazione dei robot, fornendo a costruttori e integratori un quadro normativo allineato al futuro Regolamento Macchine…

L’evoluzione della robotica industriale ha imposto una profonda revisione dei riferimenti normativi per la sicurezza, un processo culminato con la pubblicazione delle edizioni 2025 delle norme UNI EN ISO 10218, parte 1 e parte 2, che aggiornano, dopo oltre un decennio, le precedenti versioni.
I due documenti aggiornano i requisiti imposti a chi sviluppa, progetta e implementa applicazioni con i robot per rispondere alle sfide dettate dalle nuove tecnologie, dalla crescente interconnessione dei sistemi produttivi e dal nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, che diventerà pienamente applicativo a partire da gennaio 2027. Le norme ridefiniscono alcuni paradigmi fondamentali per la progettazione e l’integrazione dei robot e dei sistemi robotizzati, con l’obiettivo di fornire a costruttori, integratori e utilizzatori finali strumenti più solidi per la gestione dei rischi.
Un nuovo quadro normativo per la sicurezza
Le norme della serie 10218 sono norme tecniche di tipo C, ovvero documenti verticali che si applicano a una specifica famiglia di macchine. La loro applicazione, sebbene volontaria, conferisce la “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla legislazione europea. Questo significa che un costruttore o un integratore che segue scrupolosamente le indicazioni della norma è ragionevolmente certo di aver soddisfatto gli obblighi di legge per gli aspetti coperti dalla norma stessa. Nello specifico, gli allegati Z (per la parte 2) e ZA (per la parte 1) forniscono tabelle di corrispondenza dettagliate tra i paragrafi della norma e i requisiti della Direttiva Macchine, rendendo esplicito il collegamento.
Le nuove edizioni sono state pensate per essere armonizzate sia con la Direttiva Macchine 2006/42/CE, ancora in vigore, sia con il futuro Regolamento Macchine. È interessante notare come la parte 2 della norma fornisca presunzione di conformità non solo per i requisiti generali, ma anche per aspetti specifici come le operazioni di sollevamento, assimilando di fatto il robot che movimenta carichi a una macchina di sollevamento a tutti gli effetti.
UNI EN ISO 10218-1, il robot come macchina incompleta
La norma UNI EN ISO 10218-1 si concentra sul robot industriale inteso come “quasi-macchina”. Il robot da solo, infatti, non è una macchina completa e produttiva, ma un componente che necessita di essere integrato in un sistema più complesso per poter operare in sicurezza. Il documento specifica i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e le informazioni per l’uso che il costruttore del robot deve fornire all’integratore.
Dalla quasi-macchina alla cella: le definizioni
Per comprendere appieno la portata delle due norme, è fondamentale la terminologia. La norma distingue tra:
- Robot: l’insieme di manipolatore, controller e mezzi di programmazione.
- Sistema di robot: il robot a cui vengono aggiunti l’organo di presa (end-effector) e i relativi sensori.
- Applicazione di robot: il sistema di robot integrato con il pezzo da lavorare e altre macchine asservite.
- Cella con robot: l’applicazione completa, che include lo spazio protetto, le barriere e gli eventuali ostacoli.
La classificazione dei robot
Una delle novità più significative è l’introduzione di una classificazione dei robot in due categorie. I robot di Classe 1 sono definiti da parametri precisi: una massa mobile inferiore o uguale a 10 kg, la capacità di generare una forza massima di 50 Newton e una velocità massima di 250 millimetri al secondo.
Tutti gli altri robot rientrano nella Classe 2. Non è una distinzione puramente formale, ma una segmentazione che ha implicazioni dirette sui requisiti di sicurezza funzionale e sulle metodologie di prova. Per i robot di Classe 1, ad esempio, la norma specifica i test da eseguire per verificare la forza massima esercitabile, riconoscendo la loro intrinseca minore pericolosità.
La sicurezza informatica
In linea con il nuovo Regolamento Macchine, la norma introduce formalmente i requisiti relativi alla cybersecurity. Il costruttore deve condurre un’analisi dei rischi per identificare le minacce informatiche che potrebbero portare a movimenti imprevisti e pericolosi.
Pur non prescrivendo soluzioni tecniche, la norma suggerisce misure preventive come la gestione delle porte di comunicazione o l’uso di sistemi di autenticazione. Su questo fronte, è importante segnalare che è in preparazione una specifica norma europea (la EN 50742) che fornirà requisiti tecnici precisi contro la corruzione dei dati e che sarà armonizzata con il nuovo Regolamento.
UNI EN ISO 10218-2, l’integrazione del sistema robotizzato
Se la parte 1 riguarda il singolo robot, la norma UNI EN ISO 10218-2 si occupa dell’applicazione finale: il sistema o la cella robotizzata. È questo il documento di riferimento per gli integratori, che hanno la responsabilità di assemblare tutti i componenti in un insieme sicuro e funzionale.
Il ruolo centrale dell’integratore
L’integratore è definito come l’entità che progetta, fornisce, costruisce o assembla l’applicazione del robot o la cella robotizzata e che supervisiona le misure antiinfortunistiche. La sua responsabilità è fondamentale e la valutazione dei rischi che deve condurre è un processo che richiede il coinvolgimento di diverse figure, incluso l’utilizzatore finale.
L’integratore deve inoltre garantire il principio del “single point of control”, assicurando che, in presenza di più postazioni di comando, solo una possa essere attiva alla volta. Infine, deve distinguere tra la verifica (la conferma documentale e ispettiva della conformità dei componenti) e la validazione (le prove pratiche e i test funzionali dell’intera applicazione).
Dettagli per le applicazioni collaborative
L’integrazione dei principi della specifica tecnica ISO/TS 15066 è un pilastro di entrambe le norme. La parte 2 fornisce requisiti dettagliati per le quattro principali modalità di funzionamento collaborativo. Tra queste, la “limitazione di potenza e forza” (Power and Force Limiting) è l’unica che ammette un contatto fisico tra operatore e robot in movimento. La “guida manuale” (hand guiding), invece, non avviene tramite teach pendant, ma afferrando direttamente l’end-effector. Un aspetto innovativo introdotto nella valutazione dei rischi è la necessità di considerare il “comportamento riflessivo” dell’operatore: non solo la lesione da contatto, ma anche i pericoli secondari derivanti da una reazione istintiva, come un sobbalzo che potrebbe causare un inciampo.
Layout, messa in servizio e manutenzione
Vengono introdotti capitoli interamente nuovi dedicati a queste fasi. La norma fornisce indicazioni per progettare gli spazi in modo da garantire accessi sicuri, introducendo anche il principio di “recuperabilità” di una persona priva di sensi, che impone di prevedere spazi adeguati per l’intervento di mezzi di primo soccorso come le barelle. Un aspetto di grande concretezza riguarda la fase di installazione e collaudo: il documento ammette l’uso di misure di sicurezza temporanee, a condizione che venga condotta un’analisi dei rischi specifica per queste fasi transitorie.
Ambiti specifici e prospettive
Per i robot mobili industriali (IMR), la norma può essere usata come riferimento di base, ma è necessaria un’analisi dei rischi specifica, in attesa di documenti normativi dedicati già in preparazione. Infine, una nota critica emersa dagli stessi addetti ai lavori è che la norma, pur essendo il frutto di un grande lavoro di sintesi, risulta a tratti “migliorabile” e contenente aspetti già trattati in altri standard, il che contribuisce alla sua notevole estensione.
L'articolo Sviluppare applicazioni sicure con i robot, che cosa dicono le edizioni 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2 proviene da Innovation Post.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































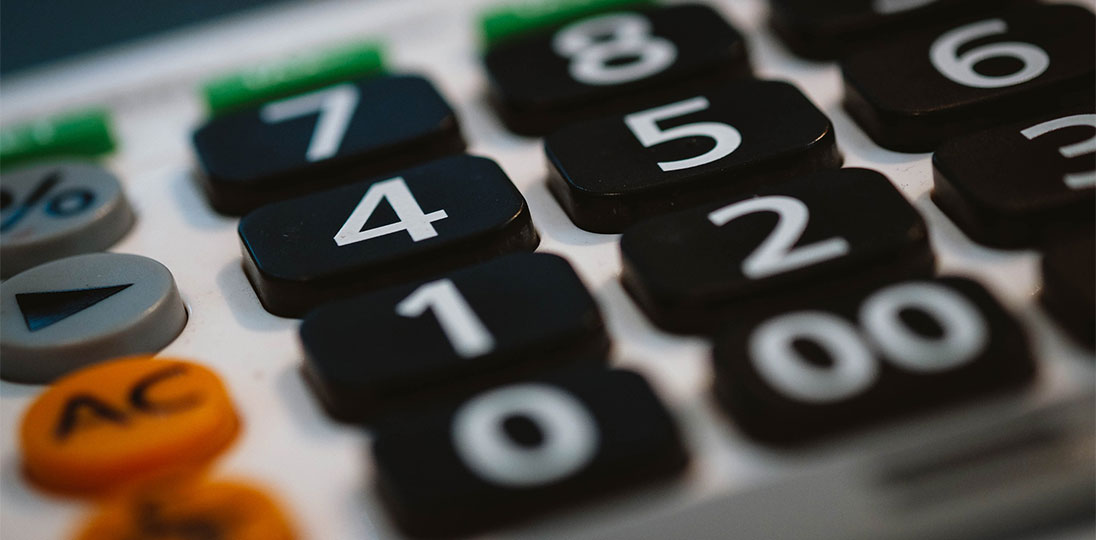







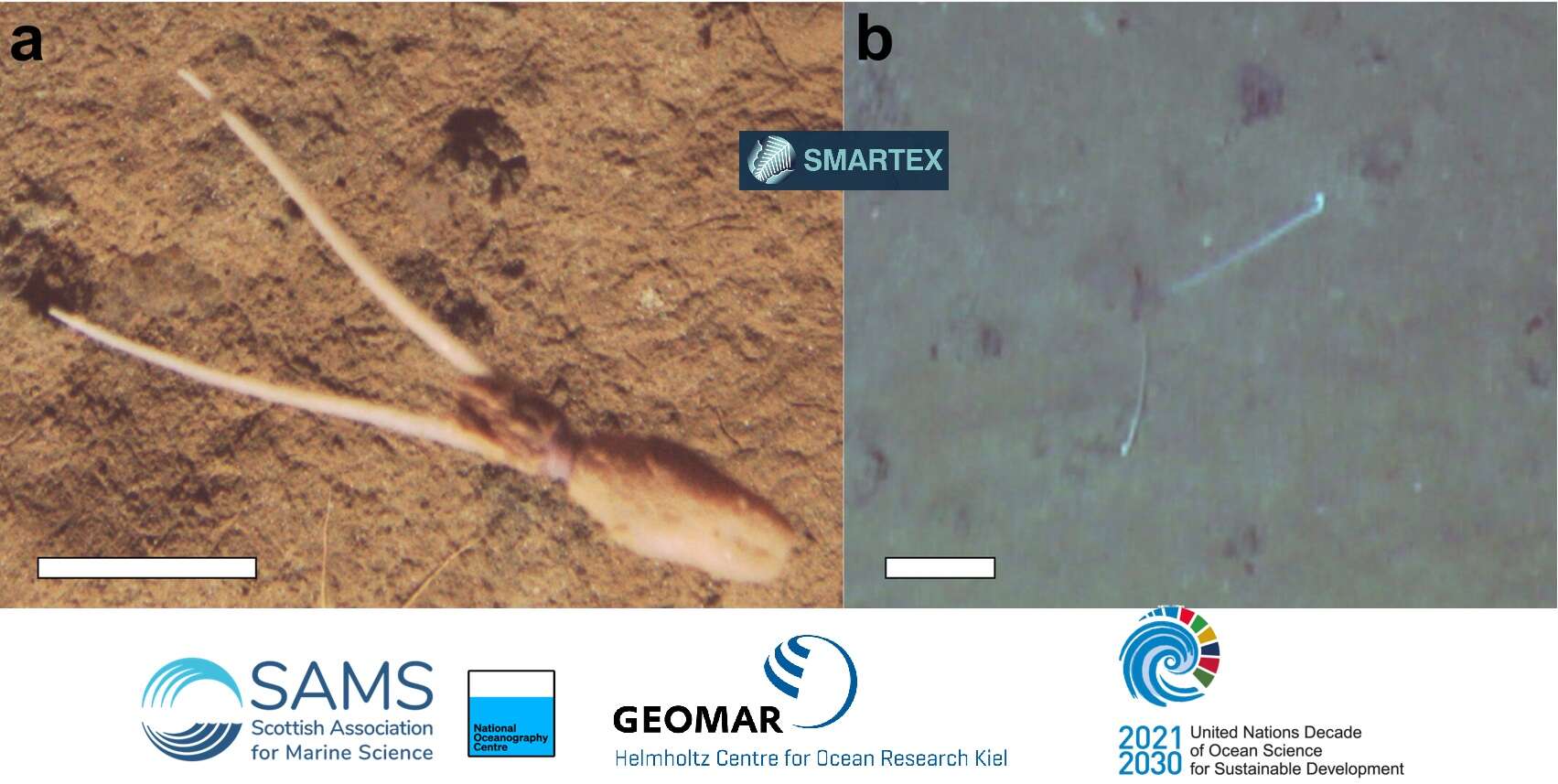






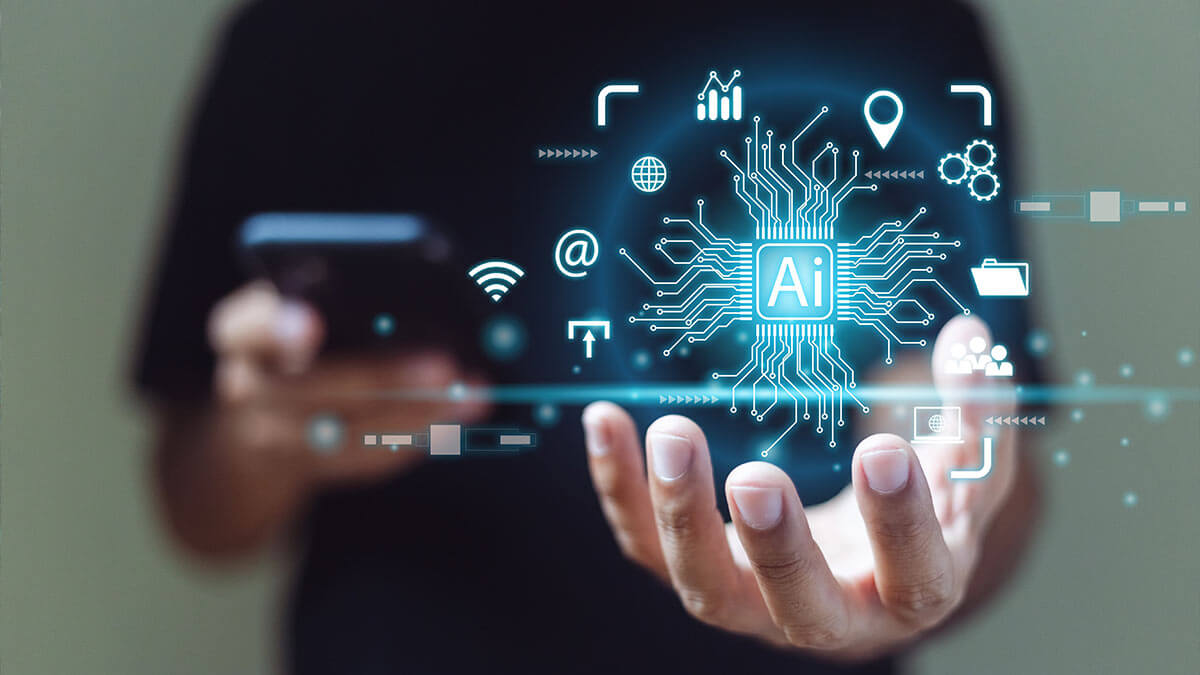


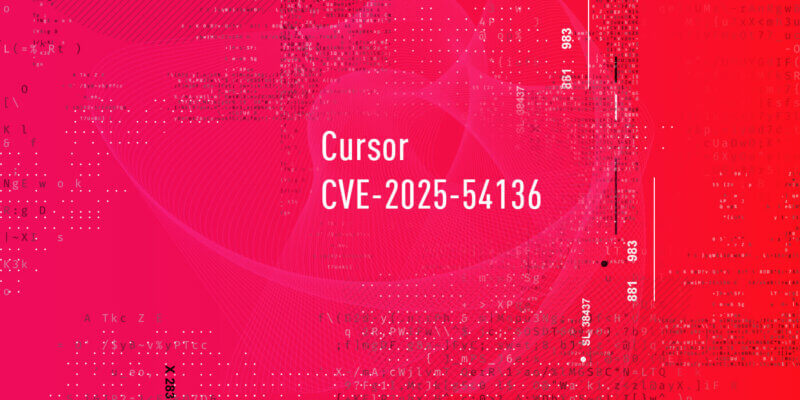















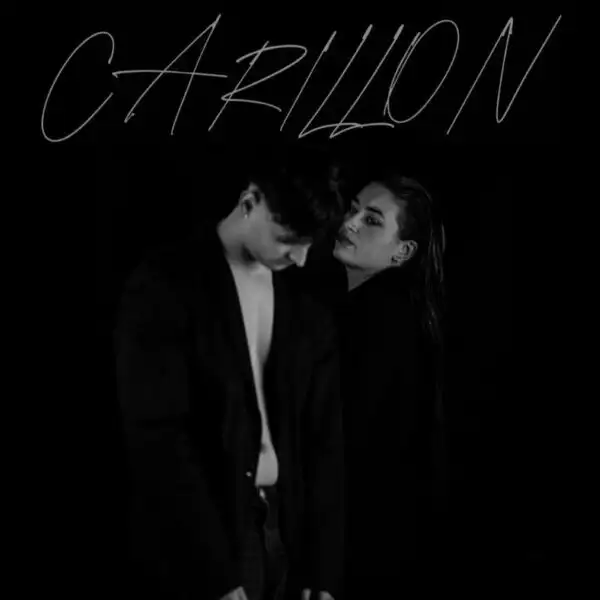





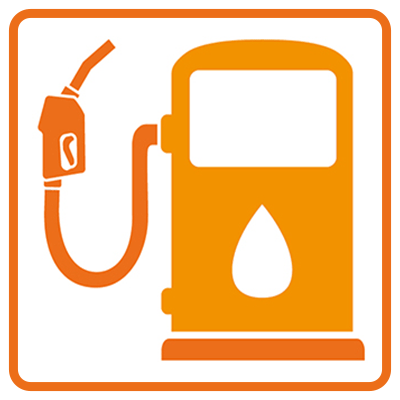




























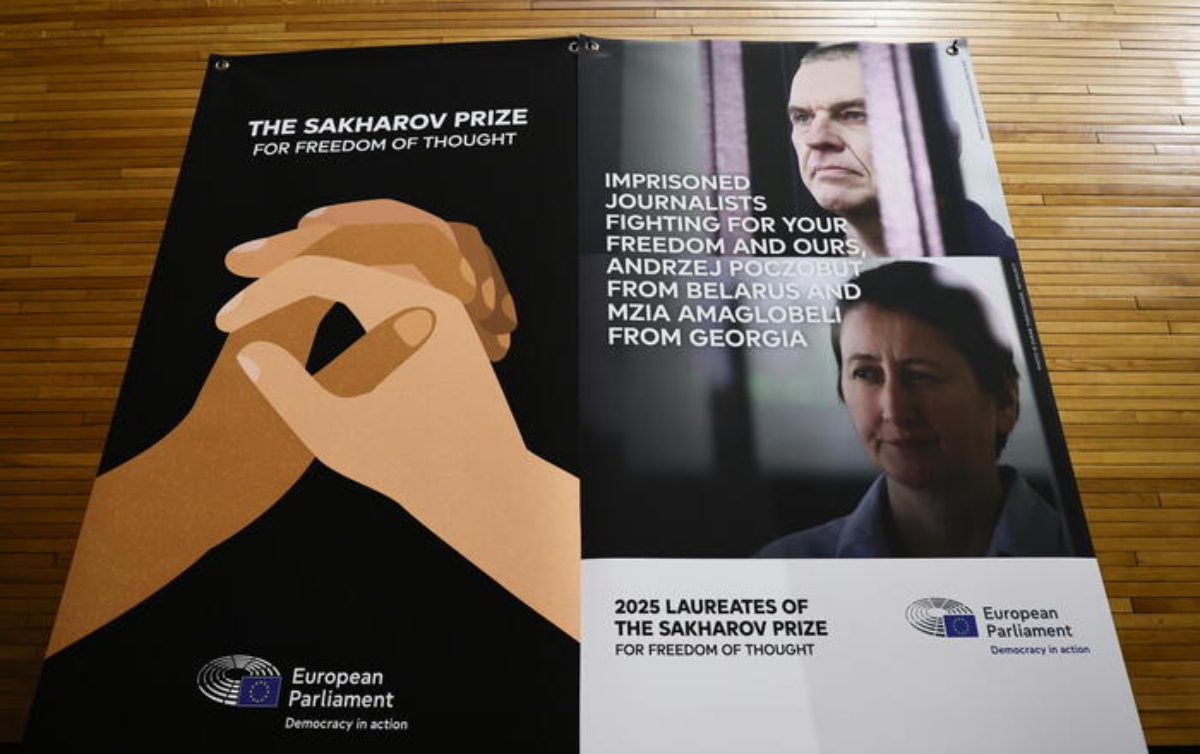



































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)