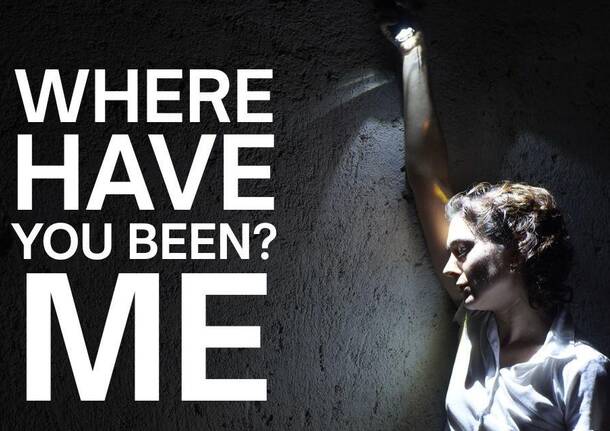Il trumpismo e il sogno americano svanito

 Donald Trump
Donald TrumpIl 20 novembre è il centenario della nascita di Robert Kennedy. Il mensile Studi cattolici dedica un Quaderno di approfondimento sulla figura dello statista americano assassinato nel 1968. Il dossier, «Bob Kennedy 1925–1968-2025 C’era una volta il sogno americano», è curato da Alberto Mattioli, autore con Mauro Colombo del volume Parola di Bob. Le “profezie” di Robert F. Kennedy rilette e commentate dai protagonisti del nostro tempo (In Dialogo). A partire da questo anniversario e guardando all’oggi, per gentile concessione dell’editore del mensile pubblichiamo uno stralcio del saggio di Gianluca Pastori, docente di Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa all’Università cattolica del Sacro Cuore, su «Il trumpismo: una sfida all’anima dell’America?».
A poco più di cent’anni dalla nascita di Robert Kennedy, il 4 luglio 2026, gli Stati Uniti celebreranno il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza: un appuntamento importante per un Paese che appare in profonda difficoltà. Da tempo, la politica e la società americane sono attraversate da fratture profonde. Il successo di Donald Trump nelle elezioni del 2024 è, allo stesso tempo, causa ed effetto di questa situazione. Trump esprime – spesso in forma esasperata – il malessere di un Paese in crisi di identità. D’altra parte, questo malessere contribuisce, in larga misura, a spiegare il successo del tycoon nonostante le difficoltà politiche e i problemi giudiziari. Su questo sfondo, non stupisce che il messaggio di Trump evochi costantemente il ritorno a una mitica età dell’oro, quando l’America era grande e temuta. Il discorso di insediamento del Presidente è stato un continuo rilanciare questi temi, temi che, nei mesi successivi, sono riaffiorati più volte nella retorica del Presidente e dei suoi collaboratori. (…)
Gli Stati Uniti oggi: uno scontro di valori?
Dietro al successo di Donald Trump c’è, quindi, una molteplicità di fattori, saldati da uno storytelling efficace e veicolato da una rete di canali che, rispetto al mandato precedente, è più ampia e differenziata. Soprattutto, rispetto al mandato precedente, la dimensione valoriale sembra avere assunto un peso molto maggiore. Nel 2016, lo slogan Make America Great Again doveva ancora essere riempito di contenuti e si associava soprattutto a un’idea di potenza e mani libere. Oggi le cose appaiono diverse. Il messaggio che sostiene la retorica trumpiana è sempre più quello della one nation under God, con l’enfasi posta, anzitutto, sul tema dell’unità. I tentativi di condizionare la posizione di università e media, la cancellazione delle politiche di diversità, equità e inclusione (Dei) e i provvedimenti adottati in tema di genere si muovono tutti in questa direzione, assecondando il “riflusso conservatore” che sembra attraversare la società americana e al quale l’amministrazione ha dato una torsione particolare.
Ancora una volta, il fenomeno anticipa la nascita dell’amministrazione e lo stesso coinvolgimento di Trump in politica. Nonostante l’esplodere dei movimenti #MeToo e Black Lives Matter, fra il 2015 e il 2020, il dibattito sulla cosiddetta cancel culture attraversa la politica, l’accademia e la società americane ben da prima del loro emergere, alimentato sia “da destra” sia “da sinistra”. Lo stesso vale per il dibattito sull’intersezionalismo e i temi legati all’identità, che si sono via via posti al cuore del dibattito politico. Proprio intorno a questi temi si è radicata, infatti, la polarizzazione repubblicani/democratici. In questo senso, prima ancora che una contrapposizione di politiche, quello attuale appare come uno scontro di valori, alimentato dalla convinzione – condivisa da parte dell’elettorato democratico – che il fronte progressista si sia spinto troppo avanti sul fronte dei diritti individuali a scapito di un impegno per quelli politici e sociali che ha tradizionalmente costituito una delle sue maggiori fonti di consenso.
Anche a ciò si lega il sostegno che il Presidente è riuscito a raccogliere negli ambienti religiosi, soprattutto fra gli evangelici bianchi e i nazionalisti cristiani. In passato, altri Presidenti hanno goduto di tale sostegno: anche qui, il riferimento immediato è Ronald Reagan, i cui successi si legano in buona parte alla mobilitazione del voto evangelico e di quello degli Stati del Sud, sino allora saldamente democratici. In tempi più recenti, i cristiani rinati sono stati un bacino importante per George W. Bush nel 2000 e nel 2004. Nel 2024, tuttavia, Trump è riuscito a intercettare anche quote anche quote significative di voto cattolico (aiutato in questo dalla scelta del convertito J.D. Vance come candidato alla vicepresidenza), aggregando il consenso sostanzialmente trasversale emerso, per esempio, in alcune sentenze della Corte suprema, dove i cattolici di nomina conservatrice (il Chief Justice John Roberts e i giudici Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett) formano oggi la maggioranza.
La portata di questo scontro è difficile da quantificare, alla luce, fra l’altro, della tendenza di parti importanti di entrambi gli schieramenti a negare all’interlocutore legittimità politica. Soprattutto a destra, gruppi radicali vedono, inoltre, in questi sviluppi, il possibile innesco di una vera guerra civile, destinata a portare alla rigenerazione del Paese e dei suoi cittadini attraverso la violenza. È un’idea che ha animato alcuni dei partecipanti ai Capitol Riots del gennaio 2021 e che affiora in taluni segmenti del movimento Maga. È un timore concreto (almeno a livello di percezioni) se è vero che – secondo un sondaggio del 2022 – più del 50% degli intervistati che si sono definiti “convintamente repubblicani” riteneva molto o piuttosto probabile lo scoppio di un simile scontro entro un decennio. È uno dei tanti segni di come la violenza (che continua a essere considerata preoccupante, specie quando colpisce la propria parte) appaia a certe condizioni giustificabile, soprattutto per le generazioni più giovani.
Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha avuto il suo peso nell’alimentare questo processo. Le scelte del Presidente e il suo linguaggio hanno contribuito molto sia ad alimentare il gioco delle reciproche delegittimazioni, sia a sdoganare la violenza verbale di cui quella fisica si alimenta. L’idea di essere stato «salvato da Dio [dall’attentato del luglio 2024] per fare l’America di nuovo grande» è stata usata per dare all’azione di Trump un carattere messianico che colloca chi la critica non solo dalla parte sbagliata della storia, ma anche di un confine morale. L’assassinio di Charlie Kirk e la sua promozione a “grande eroe americano” e “martire della fede cristiana” hanno alzato ancora di più i toni e allontanato le parti dal campo del confronto politico. Non a caso, anche quello che appare uno dei principali candidati democratici alle elezioni del 2028, il governatore della California Gavin Newsom, sembra avere abbracciato la strada (rischiosa) dell’irrisione come strategia per sostenere la sua immagine.
Gli Usa di domani
Nonostante l’intento ironico della campagna di Newsom e il suo obiettivo di “giocare” con lo stile comunicativo del Presidente, questa scelta appare una vittoria di Trump e della sua capacità di dettare le regole del gioco. Gli attacchi continui, scomposti e contraddittori contro Joe Biden, il suo entourage, i vertici democratici e quanti si oppongono alla sua visione cesarista del potere sono altrettante declinazioni di un modo di fare politica dove la realtà sfuma dietro a una narrazione irrigidita nella contrapposizione “noi”/“loro”. Alla fine del primo mandato, il Washington Post aveva calcolato oltre 30.500 affermazioni false o fuorvianti fatte dal Presidente nei quattro anni precedenti: una cifra che conferma come il legame con la realtà fosse – e resti – un aspetto secondario del suo stile comunicativo. Il ruolo che teorie cospirazioniste come quelle sulla “vittoria rubata” nel 2020 o sulle fantomatiche origini kenyane di Barack Obama hanno nel costruire la narrazione trumpiana è un altro indice di questo atteggiamento.
È difficile dire se e quando questa tendenza si potrà rovesciare. Dando per scontata l’uscita di scena di Trump alla fine del mandato, il vicepresidente Vance si sta muovendo per consolidare la sua posizione di successore in pectore e accreditarsi come campione di un nuovo “trumpismo senza Trump”. Vance si è già segnalato per la durezza delle sue posizioni, sia in campo interno sia internazionale. Alla Sicherheitskonferenz di Monaco del febbraio 2025, per esempio, il Vicepresidente ha colpito negativamente gli alleati europei, mettendo in luce quanto siano distanti gli Stati Uniti e il Vecchio continente anche sul modo di intendere i valori alla base del legame transatlantico. La sua enfasi sui temi etico-religiosi – affiorata ampiamente anche a Monaco, nonostante l’oggetto dei lavori fosse altro – è un ulteriore fattore di scollamento e appare divisivo all’interno degli stessi Stati Uniti, dove la percentuale dei cittadini che si identificano come “cristiani” è diminuita di sedici punti percentuali fra il 2007 e il 2023-2024.
Il tema che emerge è – ancora una volta – quello della “battaglia per l’anima della Nazione”: lo slogan che ha accompagnato il candidato Joe Biden nella campagna presidenziale del 2020 e che si presenta oggi come la sfida che gli Stati Uniti devono affrontare. È una sfida resa difficile dalla polarizzazione del Paese, da un clima politico tossico e dalla presenza di un Presidente che ha trasformato il dibattito pubblico in un referendum permanente sulla sua figura. Il disprezzo per l’opposizione politica, l’ostilità verso i “pesi e contrappesi” del sistema costituzionale e la personalizzazione estrema dell’azione di governo aggravano questa situazione, così come l’aggravano le condizioni di un Partito democratico che sembra avere perso la spinta propositiva e realizzativa degli anni migliori e che – come ha dimostrato la sconfitta di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca – sembra fare fatica a definire una piattaforma che possa uscire dal recinto identitario e andare incontro davvero alle richieste dell’elettorato.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


















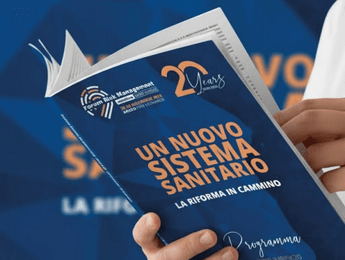























.png)












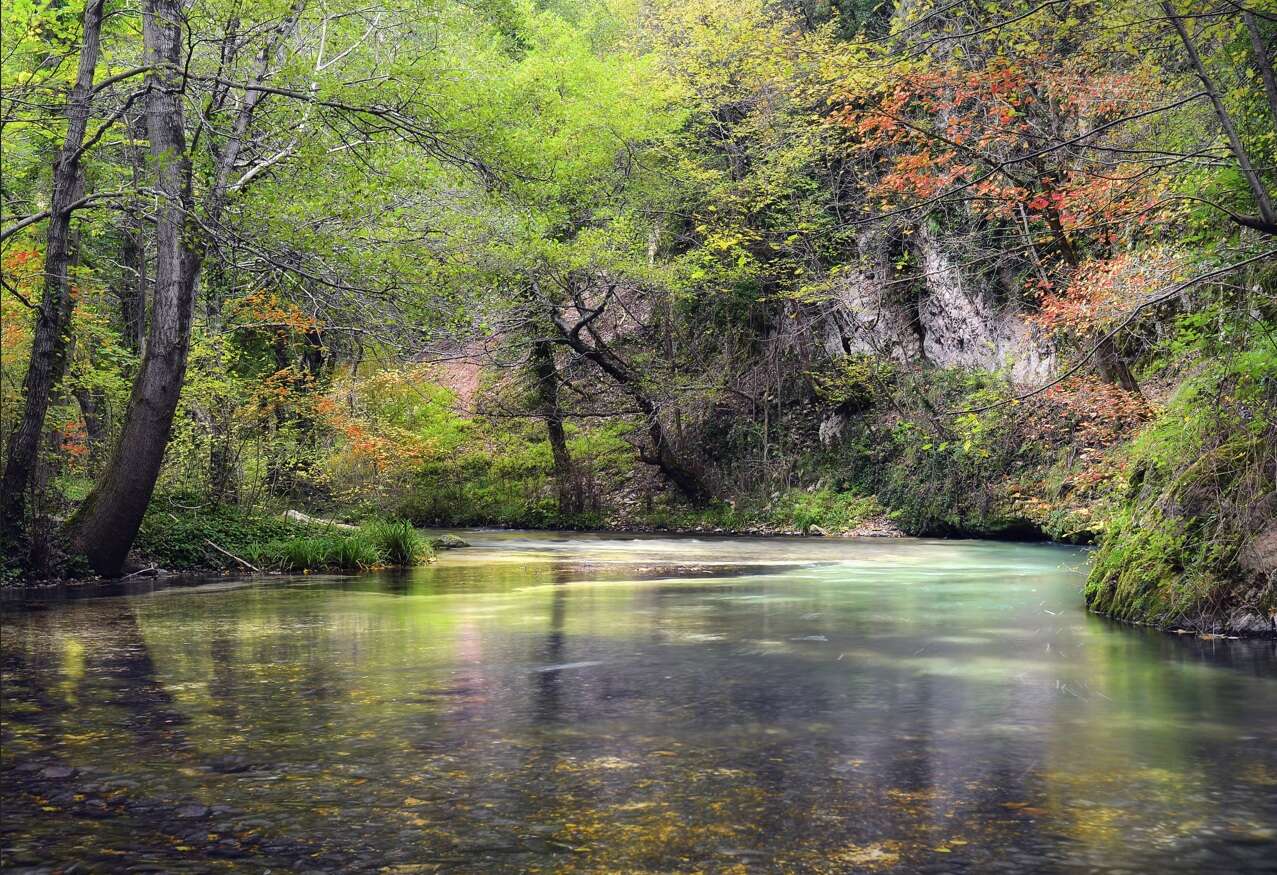






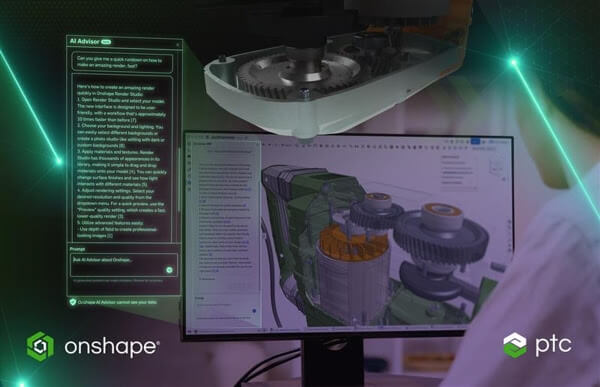



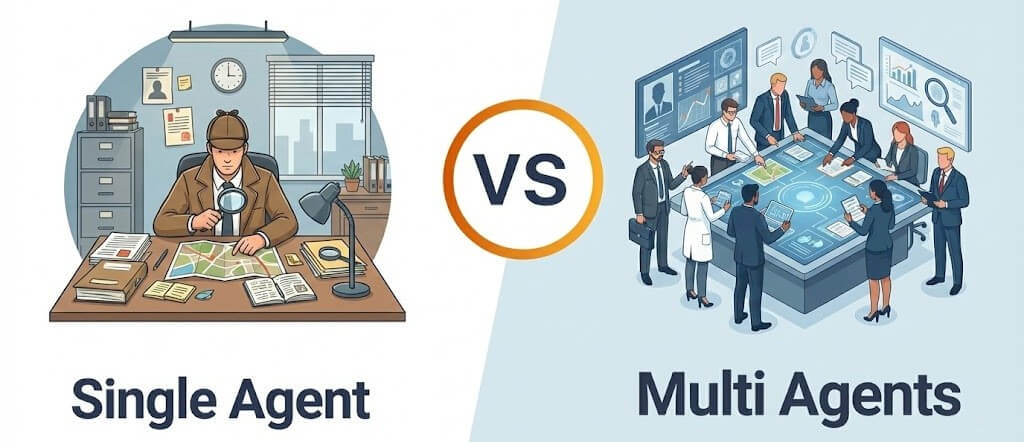

















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-felice-guarda-laptop-personale.jpg)











































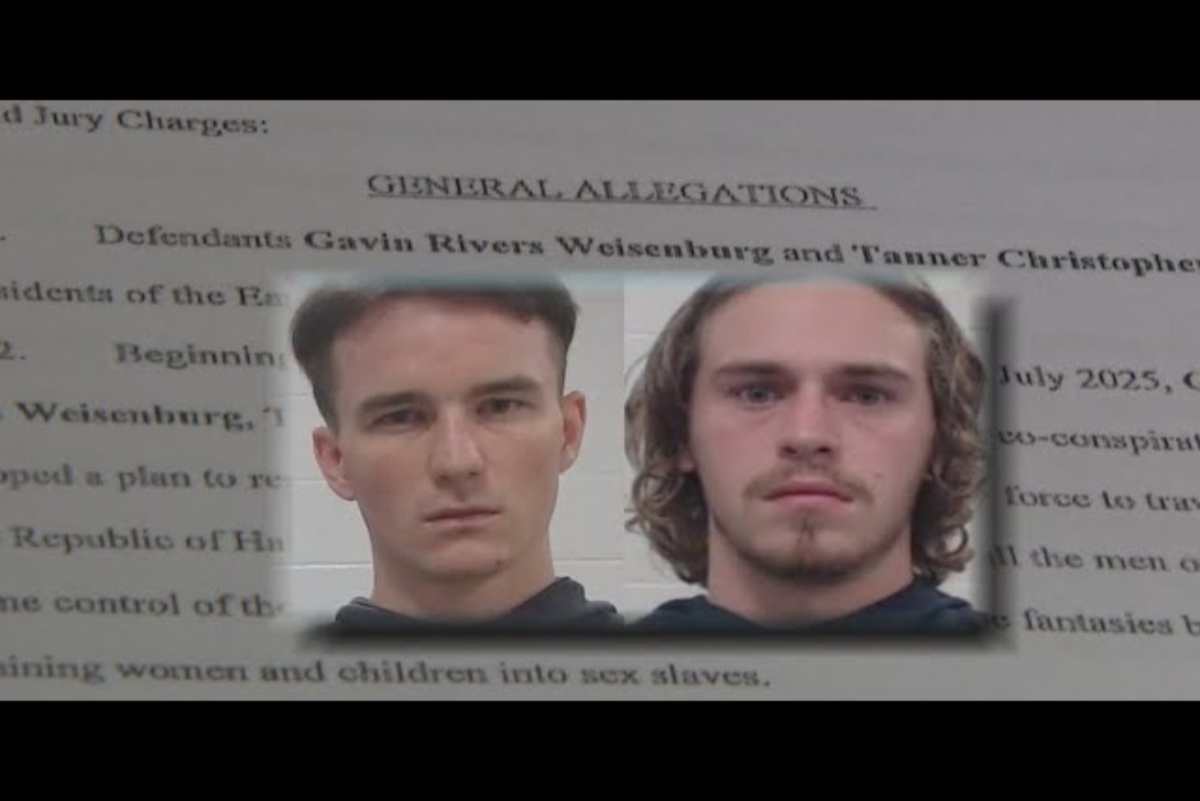






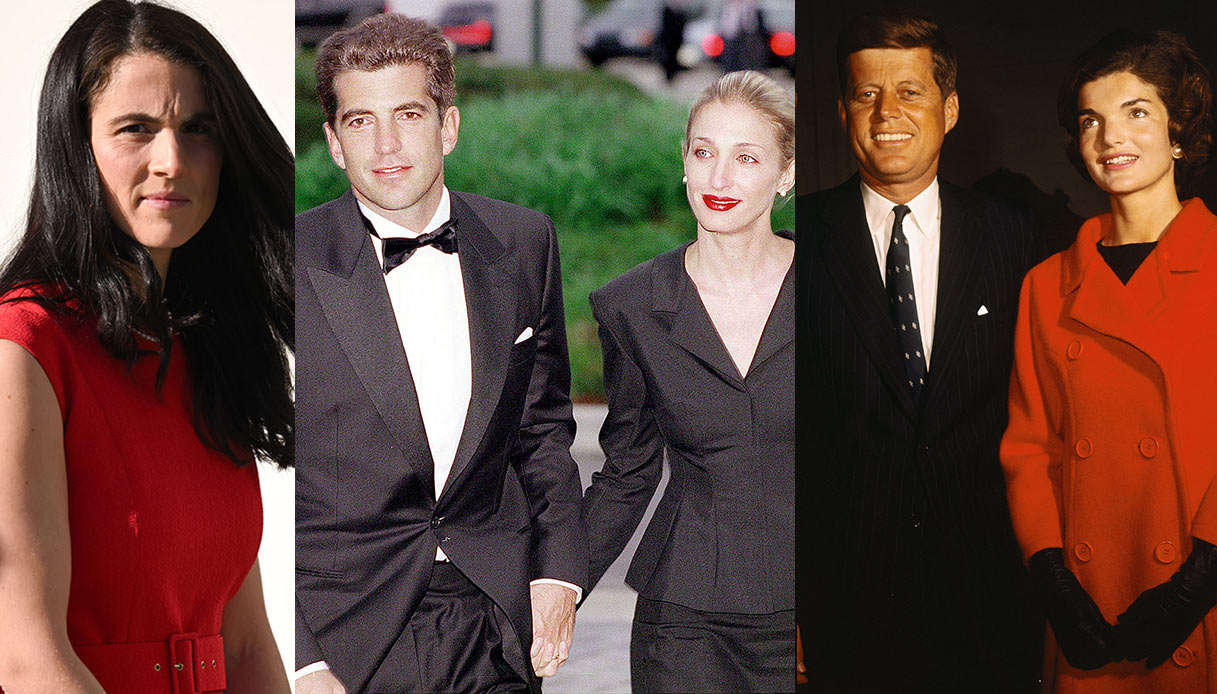





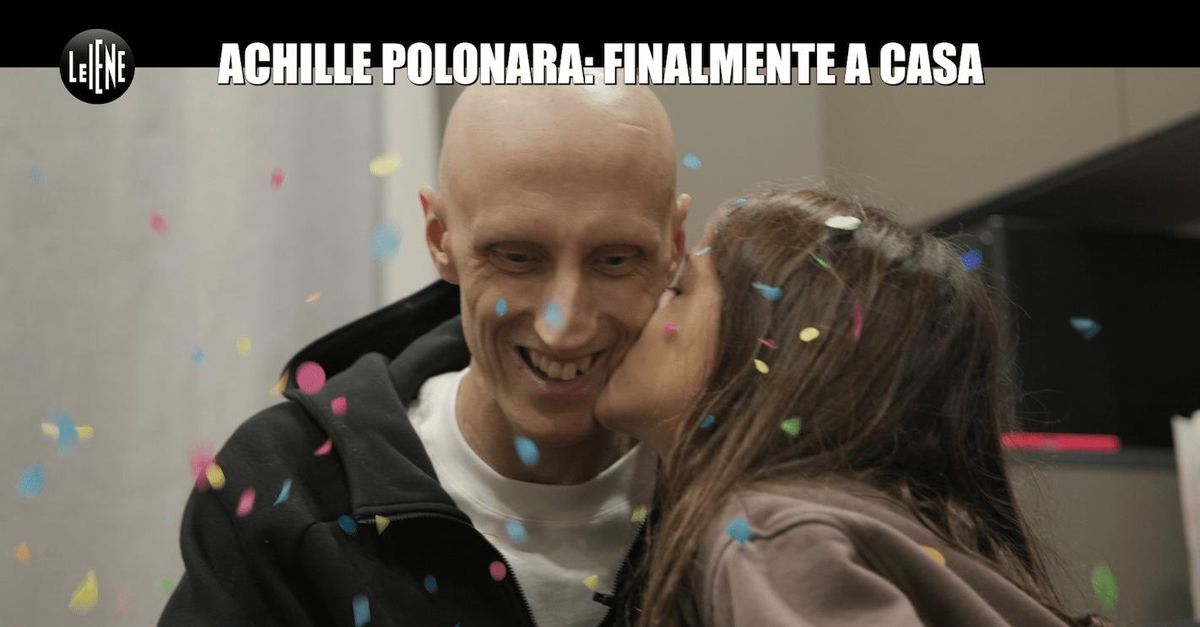

















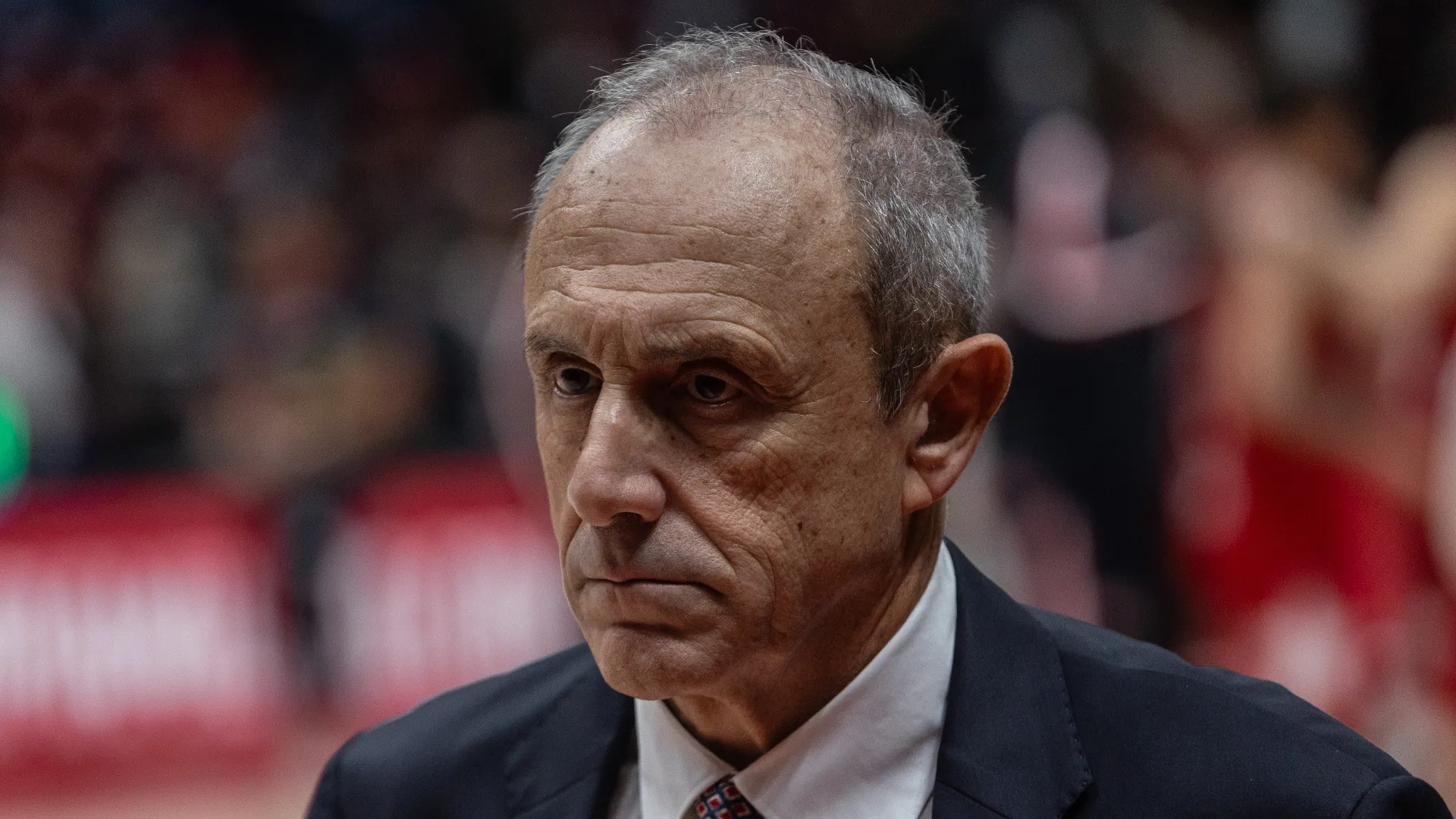


























ddd-1763990389998.jpeg--una_partita_di_monopoly_a___torino__da_oggi_e_realta.jpeg?1763990390034#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)