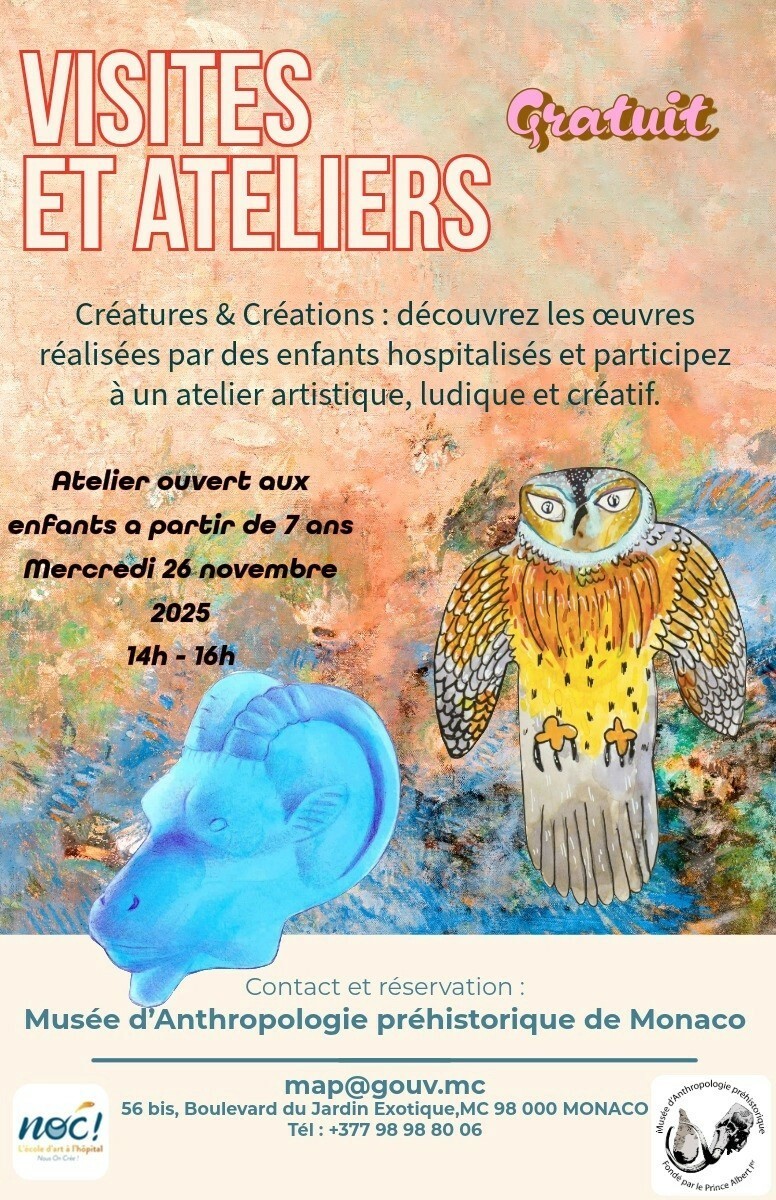Il Green Deal sotto la pressione della mobilità militare europea

Bruxelles – Con la sicurezza europea che assume un ruolo sempre più centrale nelle politiche dell’Unione europea, la mobilità militare si sta ritagliando un ruolo fondamentale proprio nel momento in cui la Commissione è pronta a investire miliardi di euro nelle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, la spinta a rafforzare la difesa europea rischia di mettere in secondo piano una delle priorità fondamentali di Bruxelles: la protezione dell’ambiente.
“La priorità dovrebbe essere destinare questo aumento di bilancio a progetti ferroviari e di elettrificazione”, avverte l’eurodeputato Reinier van Lanschot, esperto di difesa del gruppo Verdi/EFA al Parlamento europeo e membro della commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE), riferendosi alla necessità di “rafforzare sia la sicurezza dell’Europa che il suo impegno per un futuro sostenibile e a basse emissioni di carbonio”.
Tuttavia, gli Stati membri potrebbero accantonare gli obiettivi del Green Deal sfruttando la nuova attenzione dell’UE sulla difesa. L’Italia è forse l’esempio più eclatante. Il governo ha giustificato le deroghe alle norme ambientali per la costruzione del ponte sullo Stretto citando il suo presunto doppio uso e la potenziale inclusione nella rete TEN-T. In risposta, la Commissione ha formalmente richiesto ulteriori chiarimenti sull’impatto ambientale del progetto.
Nel frattempo, cresce l’opposizione sul campo contro iniziative che, secondo i critici, apportano pochi o nessun beneficio climatico all’Unione. Ma dove questa resistenza non è stata ancora messa a tacere, deve affrontare crescenti pressioni politiche e finanziarie da parte di Bruxelles per accelerare la realizzazione di infrastrutture pensate per facilitare i movimenti delle truppe, sotto la bandiera della sicurezza energetica e della promozione di soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio.
Un equilibrio fragile
Sia la mobilità militare sia la protezione dell’ambiente compaiono nel pilastro “Competitività, prosperità e sicurezza” della proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Del bilancio complessivo di 1,9 trilioni di euro, 590 miliardi sono destinati a questo pilastro, che comprende una vasta gamma di priorità, tra cui la transizione verso un’economia pulita, la decarbonizzazione, la transizione digitale e la difesa.
Secondo la proposta del nuovo QFP, ciò che in precedenza era considerato parte del Green Deal è ora incluso nel nuovo Fondo europeo per la competitività (ECF) da 409 miliardi di euro. Complessivamente, 26 miliardi di euro sono destinati alla “transizione pulita e alla decarbonizzazione industriale”, mentre 20 miliardi di euro sono destinati alla “salute, alle biotecnologie, all’agricoltura e alla bioeconomia”.
Nel frattempo, circa un quarto degli 81,5 miliardi di euro del Fondo per collegare l’Europa (CEF) è dedicato specificamente alla mobilità militare: i 17,7 miliardi di euro proposti nel nuovo bilancio dell’UE rappresentano un aumento di dieci volte rispetto all’attuale bilancio del CEF Trasporti per la mobilità militare (1,7 miliardi di euro). Come osserva la Commissione, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, “gli ultimi fondi sono stati stanziati all’inizio del 2024, senza lasciare risorse per i quattro anni rimanenti dell’attuale QFP”.
“Con questo investimento è possibile ottenere sia una forte mobilità militare che risultati ambientali positivi”, spiega l’eurodeputato dei Verdi van Lanschot, commentando la proposta della Commissione. Tuttavia, “la chiave sta nel modo in cui vengono spesi i soldi”, aggiunge. Concentrarsi sull’espansione della rete stradale o sui combustibili fossili “rischierebbe di compromettere il Green Deal e gli obiettivi ambientali”.
I Verdi sostengono che il Green Deal deve diventare un elemento essenziale per colmare le lacune nella preparazione della difesa dell’UE, per superare il falso compromesso tra sostenibilità e difesa. Ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russi, o anche dal GNL statunitense, e investire maggiormente nell’energia solare, eolica e nucleare europea “ci renderebbe meno vulnerabili e più resilienti”, conclude l’eurodeputato van Lanschot. I progetti a doppio uso, però, devono essere “pianificati con attenzione per evitare danni agli habitat naturali sensibili”.
Il controverso ponte sullo Stretto
Tuttavia, il modo in cui gli Stati membri stanno procedendo potrebbe seriamente andare nella direzione opposta. La richiesta di chiarimenti da parte dell’UE in merito al ponte sullo Stretto di Messina è stata inviata solo un mese dopo l’approvazione del progetto da parte del governo italiano. L’intero progetto dovrebbe essere completato entro il 2032.
Il ponte sullo Stretto, tuttavia, sta incontrando una forte resistenza da parte delle comunità locali. Un gruppo particolarmente attivo è No Ponte (No Bridge). Il punto principale dell’opposizione locale riguarda l’impatto ambientale del ponte e lo sfruttamento da parte del governo italiano della doppia natura del progetto per aggirare le normative ambientali. Per accelerare l’approvazione del progetto, ad aprile Roma ha approvato il cosiddetto “IROPI Report”, secondo cui, per “Ragioni Imperative di Interesse Pubblico Prevalente”, il ponte è essenziale nonostante il suo impatto ambientale.
Il rapporto afferma che il progetto è collegato al “Piano d’azione per la mobilità militare della Commissione europea (2024)” e sostiene che il ponte sullo Stretto “consoliderebbe ulteriormente il ruolo strategico dell’Italia come hub di transito per le operazioni congiunte della NATO e dell’UE”. Tuttavia, non vi è alcun riferimento a questo ponte in alcun documento della NATO, né esiste un piano d’azione per la mobilità militare della Commissione europea.
“Anche prima dell’attuale dibattito, le forze armate italiane avevano affermato che il progetto era insostenibile dal punto di vista militare perché sarebbe stato indifendibile”, spiega Antonio Mazzeo, attivista di No Bridge e ricercatore in materia di difesa. “Da un lato, il governo giustifica il rilancio del ponte da un punto di vista strategico e militare, nel quadro della NATO; dall’altro, c’è un vuoto in termini di analisi ingegneristica, valutazione dell’impatto militare, difendibilità e sostenibilità”. Come spiega Mazzeo, il governo si è concentrato sull’aspetto militare per garantire che l’UE includa il progetto nella rete TEN-T e per inserirne il costo nel bilancio della NATO. In entrambi i casi, Roma ha avuto torto.
Nonostante questo, ad agosto il governo italiano è andato oltre. La legge n. 73/2025 sulle infrastrutture pubbliche stabilisce che alcuni progetti possono essere esclusi dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) se etichettati come “progetti di difesa nazionale” e se la valutazione potrebbe comprometterne la realizzazione. Mazzeo non è d’accordo. “Per quanto riguarda la supremazia del valore militare su quello ambientale, ci sono state innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione che affermano che la rilevanza ambientale non è secondaria rispetto alla difesa”.
Dubbi sul tunnel tedesco-danese
In altri Paesi europei, l’opposizione locale non ha avuto lo stesso successo nel fermare i progetti di mobilità militare. Essendo il più grande progetto di costruzione nella storia danese, il tunnel di Fehmarn è uno dei progetti chiave del corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Il tunnel sommerso dovrebbe collegare Rødby, sull’isola danese meridionale di Lolland, con Puttgarden in Germania e dovrebbe essere completato nel 2029.
In Germania, uno dei critici più accesi del tunnel è stata l’Unione tedesca per la conservazione della natura e della biodiversità (NABU). “Questo esempio sottolinea la necessità di considerare più attentamente i risultati della valutazione dell’impatto ambientale durante i processi decisionali e le procedure di autorizzazione”, ha dichiarato Anne Böhnke-Henrichs, vice capa del team NABU.
Sul versante danese di Fehmarn, il progetto ha incontrato poca resistenza pubblica organizzata. In un sondaggio condotto nel 2020, il 77% dei danesi intervistati non era a conoscenza del progetto di collegamento di Fehmarn. “Il risultato non ci sorprende”, ha commentato Karin Neumann, portavoce del gruppo ambientalista tedesco Beltretter, citando gli anni di impegno e i fondi investiti “nella creazione di una visione di un tunnel rispettoso dell’ambiente” per la popolazione danese “al fine di ottenere la sua accettazione”.
L’appaltatore Sund & Bælt afferma che il progetto sarà “un importante contributo alla futura rete di trasporto sostenibile dell’Europa”, anche per la mobilità militare lungo il corridoio TEN-T. Tuttavia, un’analisi condotta dalla società di consulenza Kraka Economics ha smentito l’impatto ambientale di questo progetto a duplice uso. “La neutralità climatica potrebbe essere raggiunta solo dopo 181 anni dalla sua costruzione”.
“Questo articolo è stato realizzato nell’ambito delle Reti tematiche di PULSE, un’iniziativa europea che sostiene le collaborazioni giornalistiche transnazionali”.
Futura D’Aprile
Federico Baccini
Emma Louise Stenholm
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

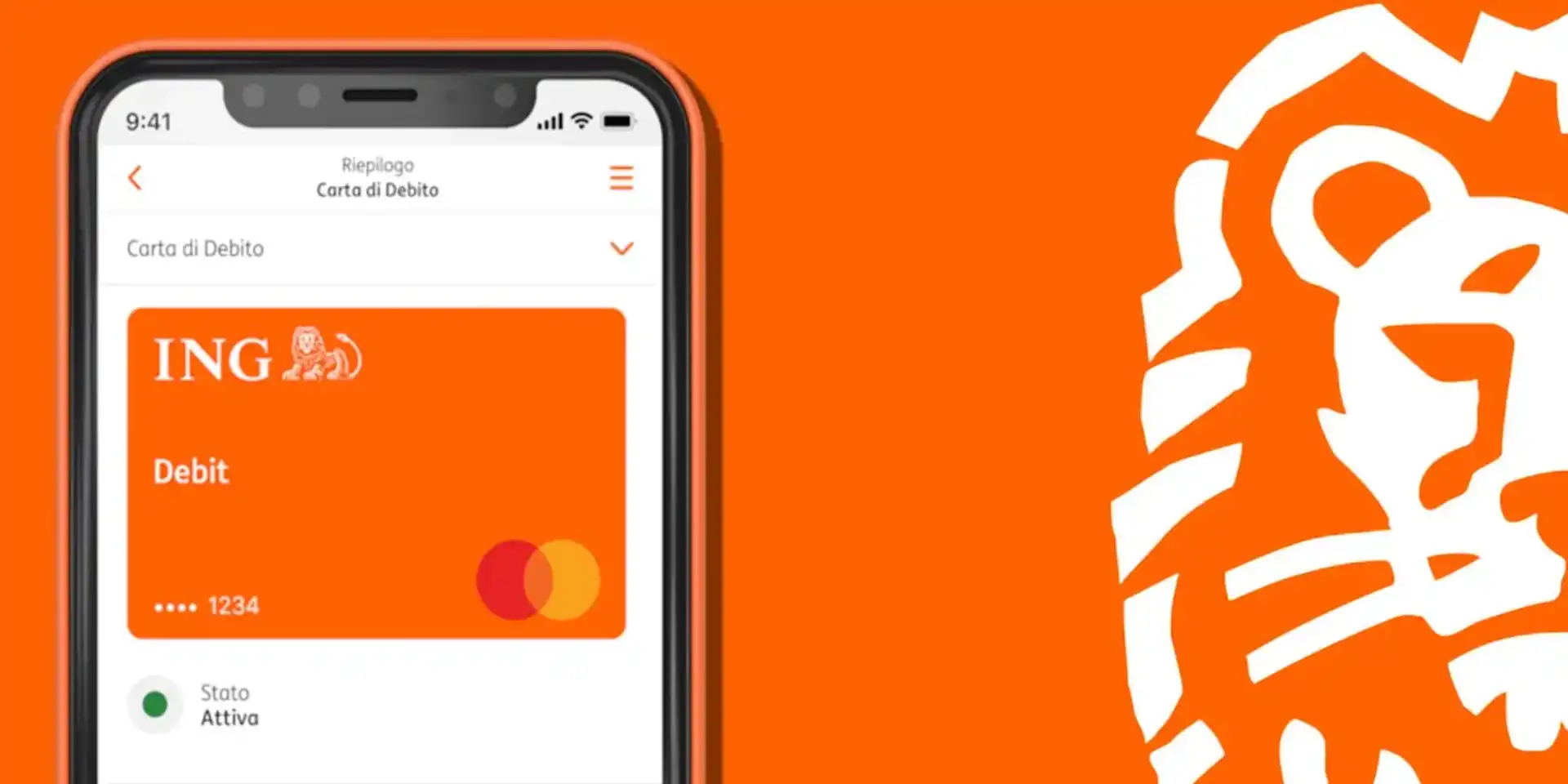














































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)