Intermediazione finanziaria in Italia: dal CdM ok ad adeguamento a regole UE

lentepubblica.it
Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok uno schema di decreto legislativo che aggiorna il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ovvero il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così da allinearlo alle più recenti normative dell’Unione Europea.
L’obiettivo è chiaro: rendere più efficienti e trasparenti i mercati dei capitali, valorizzando la cooperazione tra autorità di vigilanza e rafforzando la disciplina della gestione delle crisi dei depositari centrali.
Il provvedimento, proposto dal Ministro per gli Affari Europei (nonché PNRR e coesione) e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, si inserisce in un contesto europeo in profonda trasformazione, dove la regolazione finanziaria assume un ruolo chiave per la stabilità e la competitività del sistema.
Contesto e motivazioni dell’intervento
La finanza moderna si muove in uno scenario dove i mercati regolamentati, le negoziazioni transfrontaliere e le strutture di deposito e compensazione operano sempre più in un contesto globale. In tale ambito, l’Italia, come molti altri Paesi UE, è chiamata a rendere coerente il proprio ordinamento con le regole comunitarie. Il nostro TUF ha rappresentato per decenni la pietra angolare della normativa sull’intermediazione finanziaria nazionale, disciplinando sia l’attività degli intermediari che la tutela degli investitori.
Tuttavia, con l’evoluzione tecnica e normativa – dall’ampliamento dei mercati digitali alla crescente importanza della sostenibilità ambientale nei prodotti d’investimento – è diventato necessario un aggiornamento che non fosse solo formale ma sostanziale.
Con questo decreto, l’Italia si propone di adottare una linea d’azione che favorisca mercati più ordinati, riduca rischi sistemici e promuova condizioni di parità tra operatori in uno spazio europeo integrato.
Le principali novità previste: cosa cambia
Il decreto legislativo di adeguamento prevede un insieme di interventi che riguardano sia contenuti operativi sia aspetti di vigilanza, trasparenza e crisi. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
-
L’allineamento al Regolamento (UE) 2023/2631, che introduce disposizioni sulle “obbligazioni verdi europee” (green bonds) e sull’informativa volontaria relativa agli strumenti di debito commercializzati come sostenibili. Questo implica che l’Italia dovrà prevedere nel TUF o in norme collegate disposizioni che disciplinino in modo chiaro la trasparenza e la rendicontazione degli strumenti finanziari etichettati come “ecosostenibili”.
-
L’adeguamento al Regolamento (UE) 2023/2845, che modifica il regolamento UE n. 909/2014 in materia di depositari centrali dei titoli, servizi accessori bancari, prestazione di servizi transfrontalieri e cooperazione di vigilanza. Ciò comporterà una revisione della disciplina nazionale sugli intermediari e, in particolare, sui soggetti che detengono o gestiscono titoli per conto di terzi.
-
L’introduzione di misure in base al Regolamento (UE) 2024/791 (come indicato nella bozza di decreto) — progetto che riguarda la trasparenza dei dati, l’eliminazione di ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso di ordini (“payment for order flow”). Questo significa un potenziale ripensamento, a livello nazionale, delle strutture che gestiscono l’ordine di esecuzione e la remunerazione delle piattaforme finanziarie.
-
Il recepimento del Regolamento (UE) 2024/2987, che modifica regolamenti in materia di infrastrutture di mercato – tra gli altri il n. 648/2012 (finanziamento del mercato dei derivati), 575/2013 (requisiti prudenziali) e 2017/1131 (conoscenza dell’investitore) — con l’obiettivo di attenuare l’esposizione eccessiva nei confronti delle controparti centrali dei paesi terzi e di migliorare l’efficienza dei mercati di compensazione nella UE.
-
Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2864, che introduce l’obbligo per gli Stati membri di assicurare l’accessibilità delle informazioni pubbliche mediante il nuovo “punto di accesso unico europeo” (ESAP – European Single Access Point). Dal 10 gennaio 2030, per esempio, le entità regolamentate dovranno trasmettere le informazioni contemporaneamente all’ESAP in formato leggibile e accompagnate da metadati standardizzati.
-
Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/790, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (la cosiddetta MiFID II) in materia di mercati degli strumenti finanziari. L’ampliamento riguarda vari aspetti, tra cui la trasparenza pre- e post-negoziazione, la governance degli strumenti finanziari, la tutela dell’investitore e l’armonizzazione delle sedi d’esecuzione.
In sostanza, l’intervento normativo non si limita a “fare copia e incolla” delle norme europee ma introduce disposizioni integrative e correttive al TUF (e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128) per garantire una migliore coerenza e una più agevole applicazione nel contesto nazionale.
Impatto sugli operatori e sugli investitori
L’adeguamento avrà effetti su una vasta platea: intermediari finanziari, depositari centrali, piattaforme di trading, emittenti di strumenti finanziari sostenibili, ma anche – indirettamente – su investitori professionali e retail. Alcuni punti chiave:
-
Maggiore trasparenza: grazie all’accesso unico europeo e all’obbligo di pubblicazione in formati strutturati, gli investitori potranno disporre di informazioni più tempestive e comparabili tra Paesi.
-
Rafforzamento della governance degli strumenti “green”: gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità dovranno fornire rendicontazioni più dettagliate e conformi agli standard UE, contribuendo alla credibilità del mercato degli investimenti ESG.
-
Vigilanza e cooperazione più stretta: con le regole UE in materia di depositari centrali e compensazione, le autorità potranno intervenire in modo più uniforme nei casi di servizi transfrontalieri o crisi sistemiche.
-
Costi e adeguamenti operativi: gli intermediari dovranno aggiornare sistemi, processi e controlli interni per rispondere ai nuovi obblighi — un’onere tecnico ma anche un’opportunità per migliorare l’efficienza.
-
Cambiamenti nelle sedi di negoziazione e nell’esecuzione degli ordini: particolari regole, ad esempio il divieto di ricevere certi tipi di remunerazione dal flusso ordini (payment for order flow), potrebbero modificare modelli di business per broker e piattaforme.
The post Intermediazione finanziaria in Italia: dal CdM ok ad adeguamento a regole UE appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































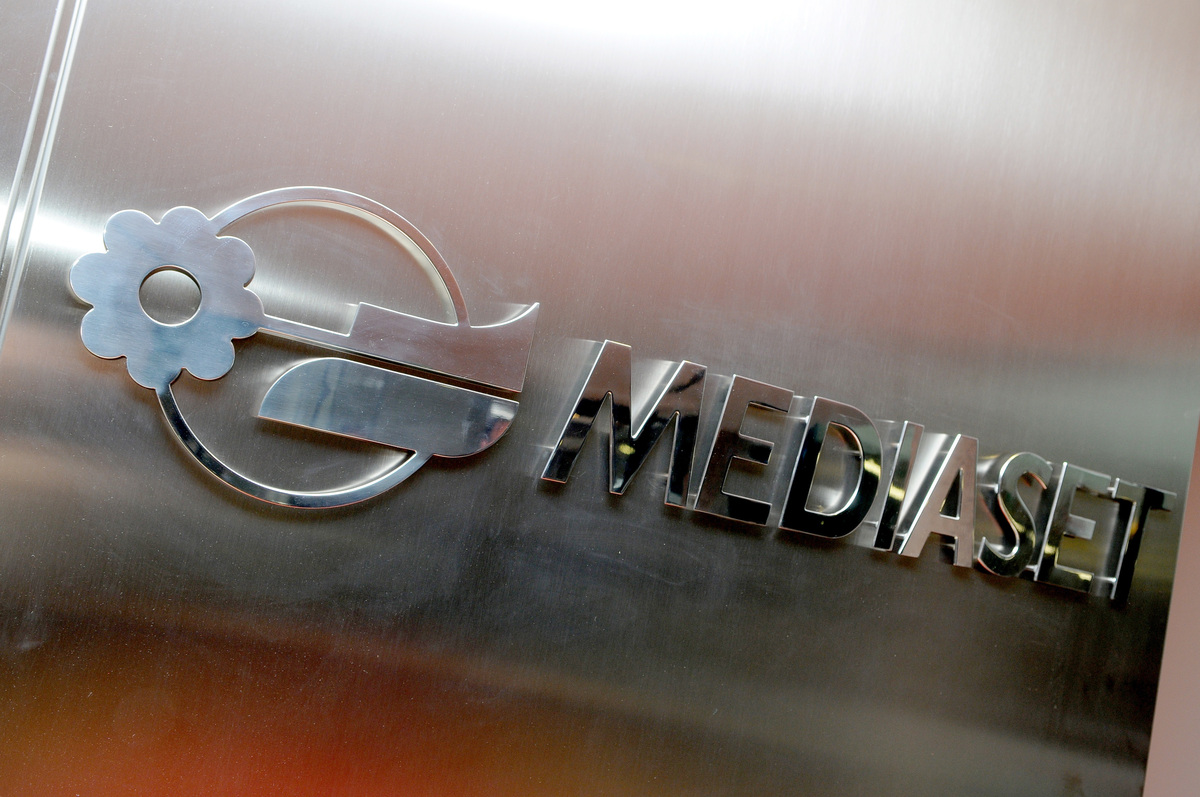























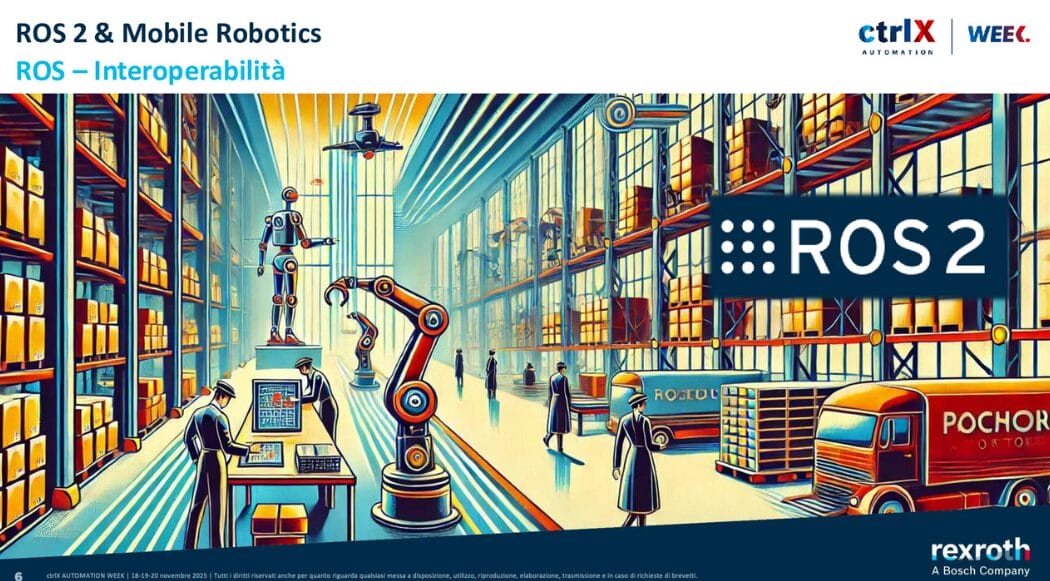















































































































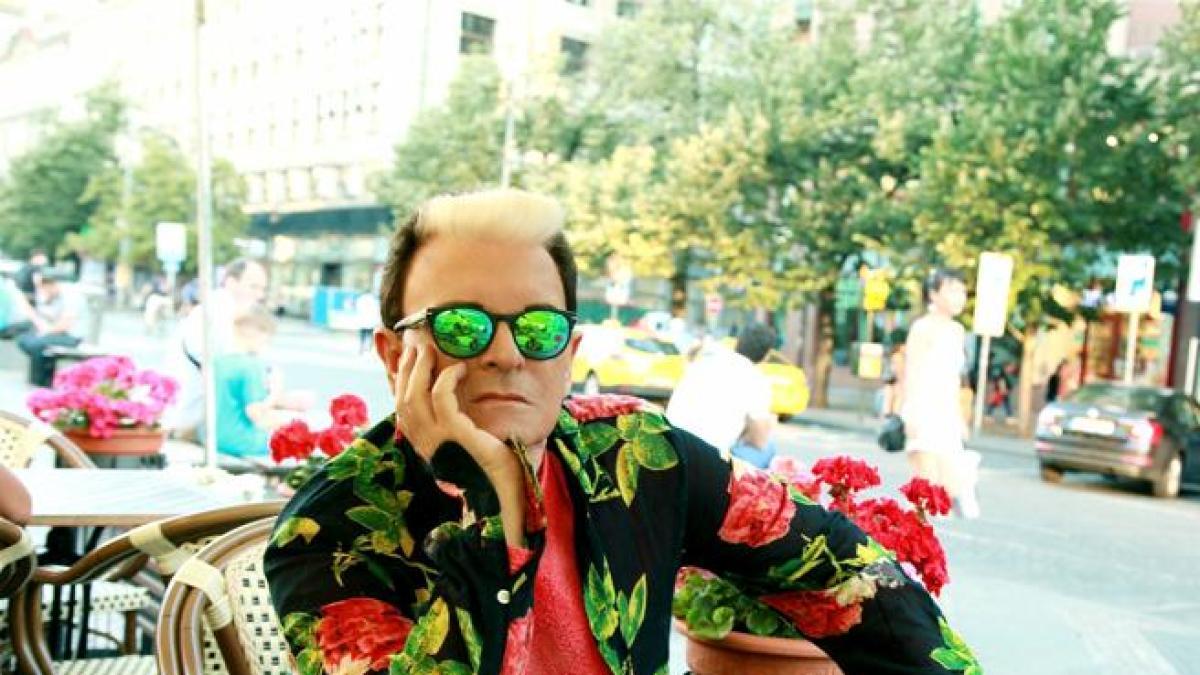

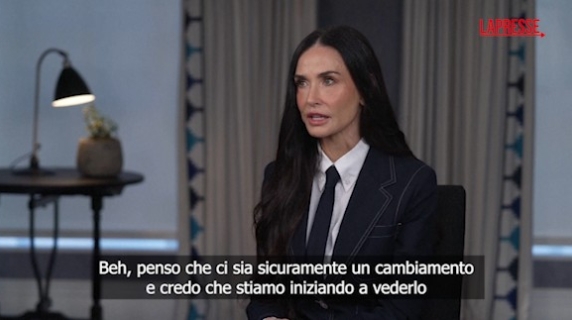
















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)




























































