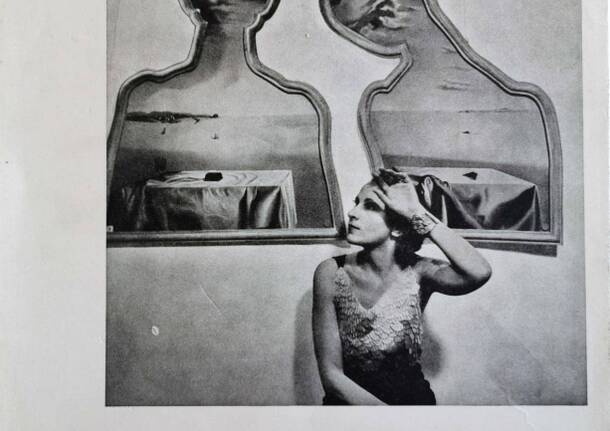La PA che guida il cambiamento: nuovi modelli organizzativi per tempi complessi

lentepubblica.it
La Pubblica Amministrazione è chiamata ad affrontare sfide inedite: la transizione digitale, la sostenibilità ambientale, la gestione delle emergenze e la crescente complessità sociale.
Per rispondere a questi bisogni non bastano riforme legislative o investimenti tecnologici: è necessario ripensare in profondità i modelli organizzativi, passando da strutture verticali e gerarchiche a logiche collaborative, agili e orientate a progetti. Questo contributo analizza le tendenze emergenti, le esperienze già avviate in Italia e in Europa e i fattori culturali che determinano il successo del cambiamento, con un focus sul caso del Comune di Parma.
Un contesto in trasformazione rapida
Le amministrazioni pubbliche operano oggi in un ambiente in cui stabilità e prevedibilità sono eccezioni. La pandemia da Covid-19 ha mostrato con evidenza i limiti di modelli organizzativi troppo rigidi, incapaci di mobilitare rapidamente risorse e competenze. Analogamente, la transizione ecologica ed energetica richiede interventi che intrecciano politiche urbane, mobilità, welfare e innovazione tecnologica: nessun settore può agire in solitudine.
L’urgenza di questi cambiamenti ha reso evidente che la tradizionale architettura a silos, con catene di comando lunghe e processi sequenziali, produce lentezza, duplicazioni e una scarsa capacità di adattamento. In un tempo in cui i cittadini si aspettano risposte rapide e personalizzate, la PA deve assumere il ruolo di attore proattivo, capace di guidare il cambiamento invece che subirlo.
Dal modello gerarchico a quello collaborativo
Il modello gerarchico tradizionale, pur garantendo chiarezza nei ruoli e responsabilità definite, è nato in un’epoca in cui la priorità era l’uniformità e il controllo. Oggi questi principi non sono più sufficienti. Le amministrazioni che hanno avviato percorsi di rinnovamento stanno sperimentando modelli ibridi: meno centrati sulla catena di comando e più orientati alla costruzione di reti di collaborazione interne ed esterne.
Il passaggio non significa eliminare la gerarchia, ma integrarla con strumenti che facilitano cooperazione, circolazione delle informazioni e capacità di risposta rapida. Team multidisciplinari, lavoro per progetti e processi decisionali inclusivi rappresentano nuove modalità operative che si stanno affermando in diversi contesti.
Organizzazione per progetti e logica dei risultati
Uno degli elementi più innovativi è l’introduzione di strutture organizzative basate su progetti. Invece di affidarsi esclusivamente a uffici per materia, alcune amministrazioni creano task force temporanee che riuniscono competenze diverse per affrontare obiettivi specifici, come la digitalizzazione dei servizi, la realizzazione di un piano di sostenibilità urbana o la gestione di emergenze territoriali.
Questi team hanno mandato chiaro, risorse definite e cicli di lavoro scanditi da fasi intermedie di valutazione. In molti casi adottano metodologie ispirate all’agile management, che prevedono feedback rapidi, sperimentazione progressiva e capacità di correggere la rotta. Il vantaggio è duplice: da un lato aumenta l’efficienza, dall’altro cresce la motivazione dei dipendenti, che si sentono parte attiva del cambiamento.
Innovazione organizzativa: esperienze già avviate
Diversi esempi italiani ed europei mostrano la praticabilità di questo approccio. Città che hanno introdotto sportelli polifunzionali hanno semplificato radicalmente la relazione con i cittadini, unificando procedure e riducendo i tempi di attesa. Altre amministrazioni hanno istituito unità di “innovation lab”, veri e propri laboratori in cui funzionari e stakeholder sperimentano soluzioni digitali, dalla gestione documentale automatizzata alla progettazione partecipata di nuovi servizi.
Esperienze internazionali, come i modelli scandinavi di “public innovation hubs” [1], evidenziano come la co-creazione con cittadini e imprese possa diventare parte integrante dell’organizzazione amministrativa. Questi laboratori non sostituiscono le strutture tradizionali, ma le affiancano, introducendo cultura del progetto e sperimentazione controllata.
Il caso del Comune di Parma
Un esempio concreto di trasformazione è quello del Comune di Parma, che negli ultimi anni ha avviato un percorso di profonda riorganizzazione dei propri servizi di front-office e, parallelamente, di digitalizzazione interna.
La creazione di sportelli polifunzionali per il DUC (Direzionale Uffici Comunali) ha una storia consolidata e ha reso possibile concentrare in un unico punto di accesso pratiche prima frammentate in diversi uffici. Il cittadino non è più costretto a muoversi da un settore all’altro, ma trova un servizio integrato, capace di risolvere richieste diverse grazie alla formazione trasversale degli operatori. Questo modello ha ridotto drasticamente i tempi di attesa, migliorato la qualità percepita del servizio e rafforzato la fiducia nella macchina amministrativa.
Contestualmente, il Comune ha investito nella trasformazione digitale, con l’adozione di piattaforme collaborative per la gestione documentale, l’integrazione con i sistemi nazionali (SPID, pagoPA, ANPR) e la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati. La combinazione tra riorganizzazione fisica degli sportelli e digitalizzazione dei processi ha reso più fluido l’ecosistema dei servizi, con un beneficio sia per i cittadini sia per i dipendenti.
L’innovazione digitale di Parma non riguarda solo l’ambito dell’erogazione dei servizi ma anche la progettazione dello sviluppo della città. Il Comune di Parma è fra le 100 città europee selezionate dalla Commissione UE per sviluppare progetti che mirino ad ottenere la neutralità climatica (Carbon Neutrality) entro il 2030, pertanto, nell’ambito di questo importante ed ambizioso obiettivo si è ritenuto necessario realizzare un Gemello Digitale della città, ovvero un modello 2D e 3D del territorio che lo rappresenti attraverso le sue principali componenti, come ad esempio gli edifici, le vie di comunicazione, le reti tecnologiche ed infrastrutturali in modo che funga da base e fulcro di fruizione per la modellazione ed elaborazione di scenari in risposta alle esigenze di valutazioni politiche e tecniche che via via si rendano necessarie.
Ne consegue che, per ottenere valutazioni il più possibile affidabili e realistiche, tale Gemello Digitale deve necessariamente possedere come caratteristiche imprescindibili una ricostruzione completa, dettagliata e precisa del territorio unita alla possibilità di integrarsi con le numerose ed eterogenee fonti dati di cui dispone il Sistema Informativo Territoriale (SIT) comunale ma non solo, e quindi, a titolo esemplificativo, la sensoristica IoT, le centraline qualità dell’aria, i consumi e fabbisogni energetici, ecc.
E’ stato possibile ottenere quanto sopra esposto mediante l’utilizzo di strumenti e sistemi tecnologici specifici quali il Mobile Mapping System (MMS) e GPS inerziali, che consentono restituzioni fotografiche a 360 gradi, assieme a rilievi spaziali 3D dei luoghi, attraverso laser scanning (LiDAR) per la produzione nuvole di punti georeferenziate, grazie ai quali è stato possibile alimentare sistemi web GIS per la pubblicazione e la navigazione interattiva dei dati cartografici, raster (immagini) e 3D del territorio.
Per il progetto del “Gemello Digitale”, Parma è tra i vincitori del Premio “PA Aumentata” a FORUM PA 2025 per l’ambito Sostenibilità Ambientale.
Introdurre queste innovazioni è possibile solo se si trasforma il modo di lavorare delle strutture amministrative. Dal modello burocratico centrato sul compito si deve passare alla logica cooperativa del risultato per la creazione di Valore Pubblico per la comunità locale.
Il caso di Parma dimostra come l’innovazione organizzativa e quella tecnologica, se coordinate, producano un effetto moltiplicatore: non basta digitalizzare ciò che esiste, bisogna ridisegnare il modo in cui l’ente si relaziona con la comunità.
Il ruolo della tecnologia: abilitatrice, non sostitutiva
Molti osservatori tendono a identificare il cambiamento organizzativo con la trasformazione digitale. In realtà la tecnologia è solo uno strumento. Digitalizzare un processo inefficiente significa semplicemente renderlo inefficiente in forma elettronica. Il vero salto avviene quando la revisione organizzativa precede l’adozione della tecnologia.
L’uso di piattaforme collaborative, sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati, strumenti di automazione dei flussi documentali è efficace solo se inserito in un disegno organizzativo orientato a semplificazione e trasparenza. La tecnologia diventa allora un moltiplicatore della capacità amministrativa, non un fine in sé.
Una trasformazione culturale
Il cambiamento verso modelli collaborativi non è soltanto organizzativo o tecnologico: è innanzitutto culturale. La leadership, in questo nuovo contesto, non coincide più con il controllo ma con la capacità di facilitare, creare fiducia e dare senso agli obiettivi. I dipendenti non sono meri esecutori, ma portatori di competenze e creatività da valorizzare.
Ciò richiede un investimento continuo in formazione, non solo tecnica ma anche manageriale e comunicativa. Le competenze di gestione dei conflitti, di lavoro in team e di problem solving diventano decisive quanto quelle informatiche. L’errore, spesso stigmatizzato nelle logiche tradizionali, deve invece essere interpretato come occasione di apprendimento e miglioramento.
Condizioni per il successo
Analizzando le esperienze più avanzate emergono alcune condizioni comuni di successo. La prima è la chiarezza degli obiettivi: senza una visione condivisa, i modelli collaborativi rischiano di diventare solo retorica. La seconda è la coerenza politica: l’innovazione organizzativa ha bisogno di sostegno stabile e non può essere affidata all’iniziativa di singoli dirigenti illuminati. La terza è la capacità di misurare i risultati, non soltanto in termini di output (numero di pratiche evase), ma anche di outcome, cioè impatti concreti su cittadini, imprese e comunità.
Conclusione
La Pubblica Amministrazione che saprà evolversi da macchina burocratica a piattaforma collaborativa sarà più pronta ad affrontare la complessità contemporanea. Non si tratta di un percorso semplice né rapido, ma di un processo che unisce riorganizzazione, cultura e visione strategica.
Il caso di Parma mostra che quando innovazione organizzativa e digitale procedono insieme, i risultati sono tangibili: servizi più accessibili, processi più fluidi, cittadini più soddisfatti. Le esperienze già avviate in Italia e in Europa dimostrano che la trasformazione è possibile.
In un mondo caratterizzato da crisi ricorrenti e cambiamenti repentini, la PA non può limitarsi a reagire. Deve assumere il ruolo di guida, offrendo un modello di governance che coniughi competenza tecnica, collaborazione diffusa e capacità di innovare. È questa la vera sfida per i prossimi anni: costruire una pubblica amministrazione che non solo amministra, ma che governa il cambiamento.
Note
[1] https://cic.com/blog/what-is-an-innovation-hub/
The post La PA che guida il cambiamento: nuovi modelli organizzativi per tempi complessi appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































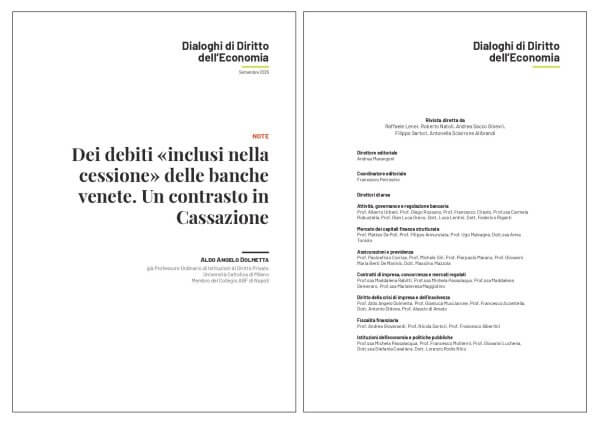
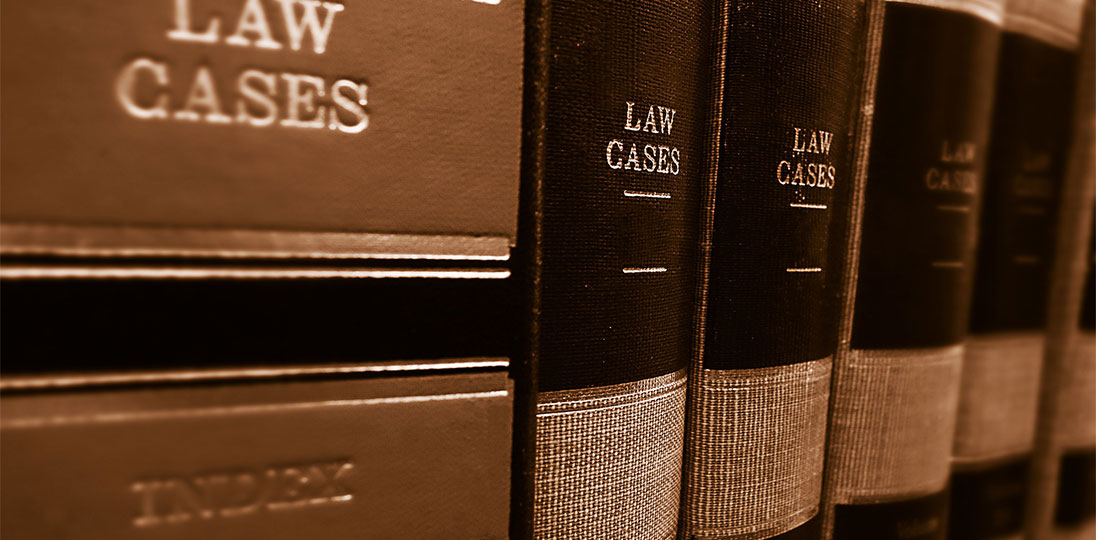



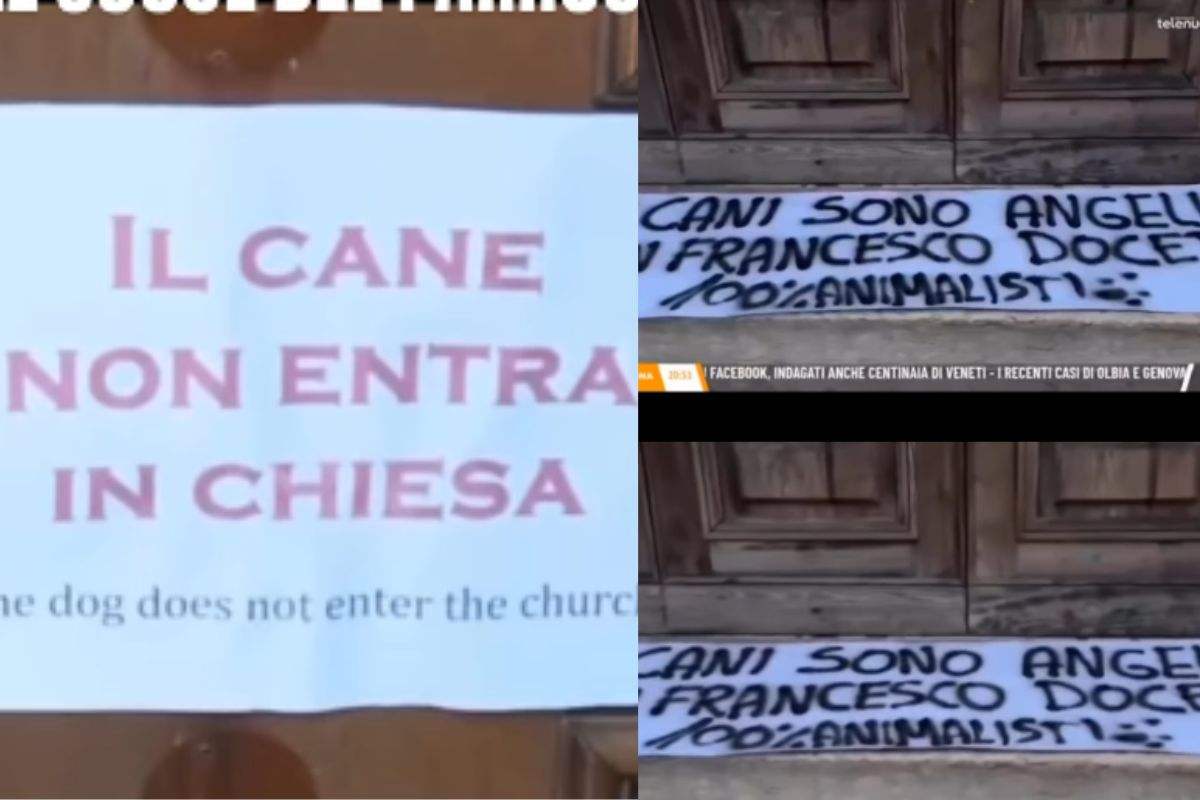

































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
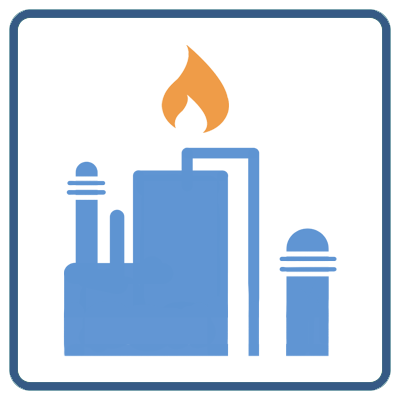


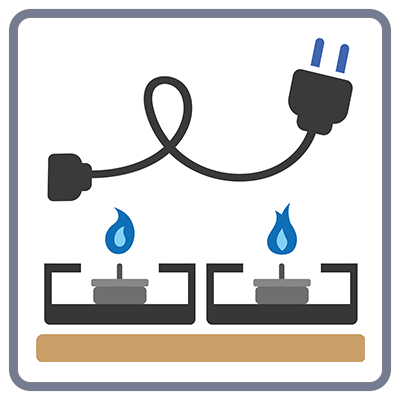


























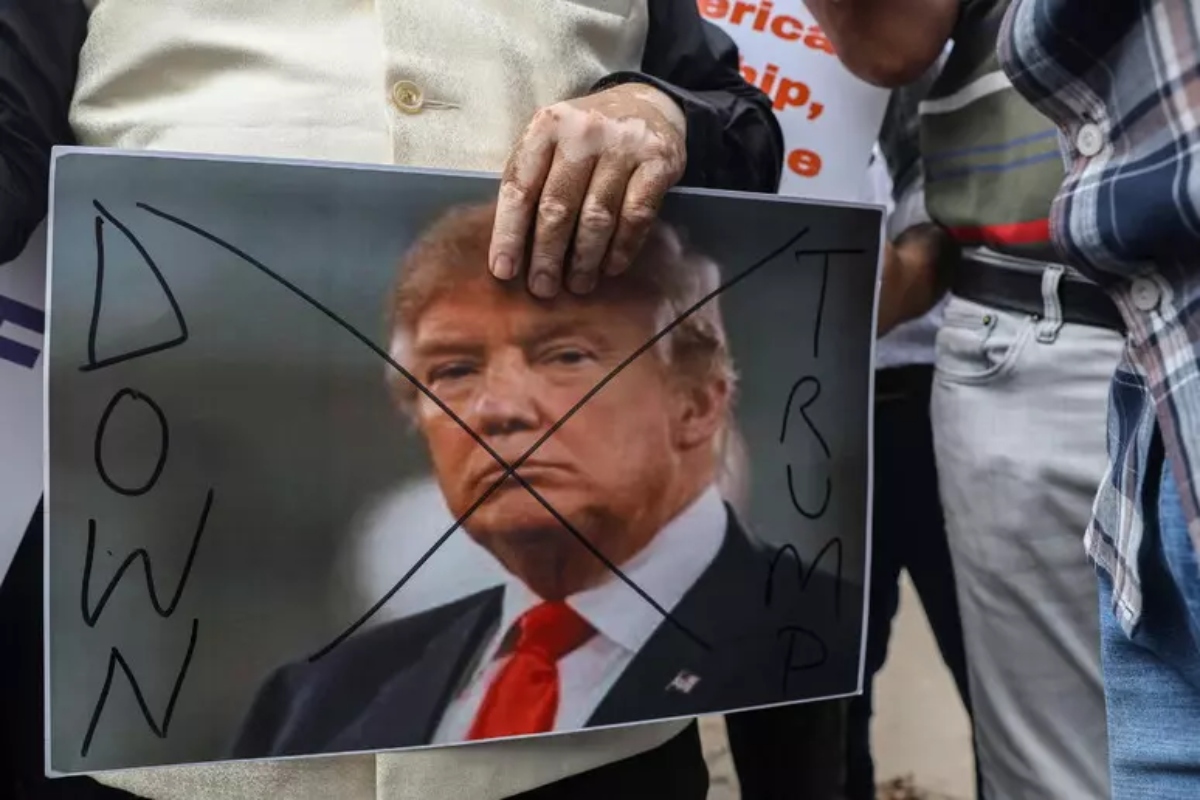





















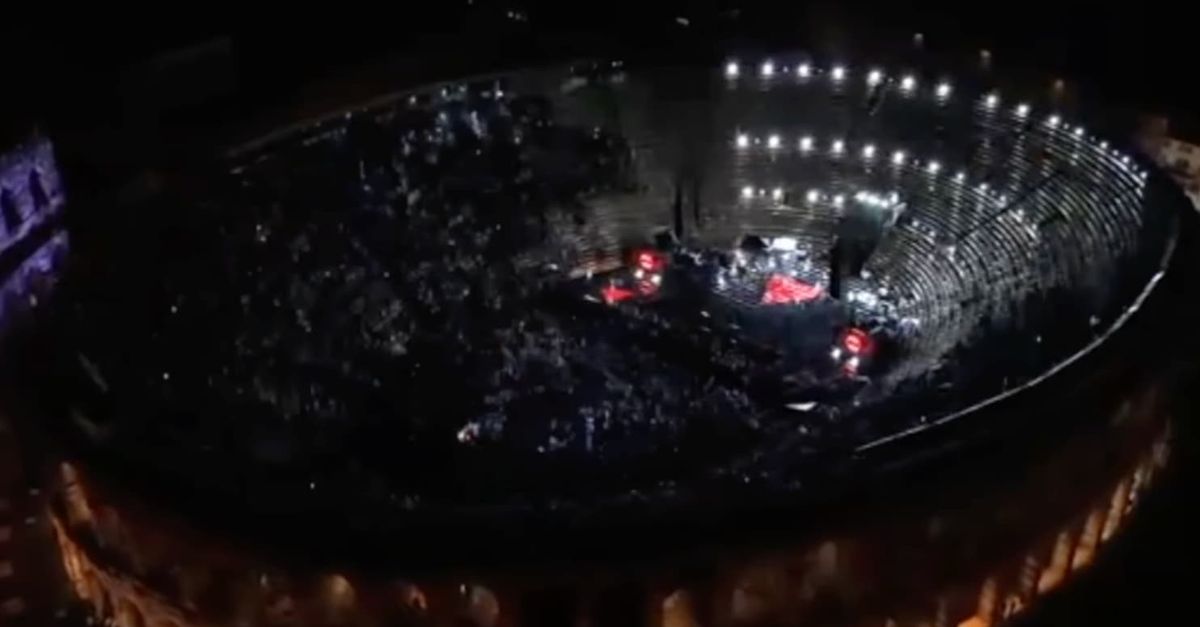






































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)