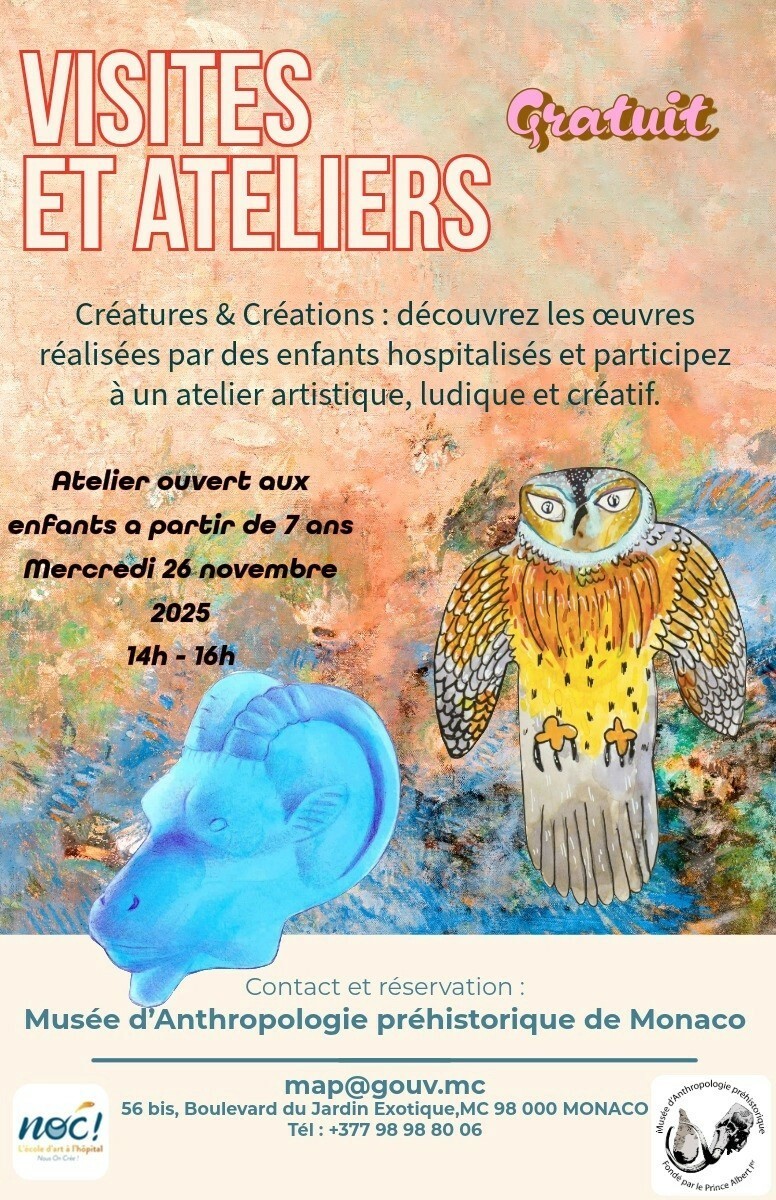L’economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari


Sono circa duecento milioni, quasi il quaranta per cento della forza lavoro urbana. Un esercito silenzioso che tiene in piedi la seconda economia mondiale senza un contratto stabile, senza garanzie pensionistiche, spesso senza accesso a sanità e istruzione. La Cina li chiama lavoratori flessibili, in Occidente diremmo gig workers. Sono operai a giornata, autisti di Uber, fattorini che consegnano pasti e pacchi, freelance di marketing online. Una categoria molto eterogenea che, però, vive una condizione comune: lavorare nell’incertezza.
Secondo l’Economist, questa forza lavoro è la grande sliding door del futuro cinese. Se riuscirà a stabilizzarsi, potrà sostenere i consumi, ridare fiducia a un’economia segnata dal rallentamento della domanda interna e dall’erosione del settore immobiliare. Se invece dovesse restare ai margini, potrebbe diventare una fonte di instabilità sociale e politica.
A differenza delle economie occidentali, dove la gig economy si concentra nei servizi, in Cina la precarietà ha conquistato anche la manifattura. Oggi, in alcuni grandi complessi industriali, fino all’ottanta per cento degli addetti lavora a chiamata, pagato a giornata o a settimana. Una trasformazione radicale: dal proletariato inquadrato nei turni di fabbrica al precariato digitale che si sposta di impianto in impianto grazie a piattaforme di reclutamento online. Si tratta inevitabilmente di lavoratori a bassa specializzazione, che possono saltare da un posto di lavoro all’altro.
La tecnologia è il vero motore di questa rivoluzione, dice l’Economist. Le “superapp” cinesi collegano clienti e lavoratori in pochi clic, semplificando passaggi che un tempo dipendevano da caporali o intermediari improvvisati. Circa ottantaquattro milioni di persone trovano oggi occupazione tramite piattaforme digitali. Per chi sa muoversi con abilità tra un’app e l’altra, i guadagni possono superare quelli di un impiego tradizionale: un sondaggio del 2022 mostrava che i rider dedicati guadagnavano in media quasi un quinto in più dei migranti impiegati nelle fabbriche.
La flessibilità ha un fascino indiscutibile. Molti giovani rifiutano la monotonia delle catene di montaggio su cui le generazioni precedenti hanno costruito la loro vita. Preferiscono poter cambiare lavoro con un clic, scegliere i propri orari, concedersi pause quando lo desiderano. È anche un elemento culturale: la figura dei “Dei di Sanhe” – giovani lavoratori che alternano brevi turni a periodi di svago in città come Shenzhen – è entrata nell’immaginario popolare come simbolo di un nuovo rapporto con il lavoro.
Ma questa libertà ha un prezzo alto. Senza contratti, milioni di lavoratori non versano contributi pensionistici né hanno diritto a protezioni sociali. L’assenza di un hukou urbano – il sistema di registrazione della residenza – impedisce loro di accedere a scuola e sanità nelle città dove vivono. Molti non riescono a comprare casa, a sposarsi, a mettere su famiglia. Nei centri manifatturieri è sempre più frequente trovare giovani che dormono nei parchi o sotto i cavalcavia, in attesa di un nuovo ingaggio.
Gli economisti temono che questa precarietà diffusa porti a una progressiva “dequalificazione” della forza lavoro: le micro-mansioni ripetitive, rese possibili dall’automazione, non sviluppano competenze trasferibili né capitale umano.
Uno studio recente di Xueyang Ma, ricercatore dell’Università di Wuhan intervistato per un report della London School of Economics, traccia un ritratto della precarietà nella Cina occidentale. Dai sondaggi e dalle analisi sul territorio emergono storie di lavoratori con salari bassi, orari lunghi e irregolari, frequenti periodi di disoccupazione e quasi sempre senza copertura previdenziale. Le conseguenze investono sempre anche la sfera personale: matrimoni ritardati, tassi di divorzio elevati, bassa natalità.
In assenza di un welfare efficace, il sostegno arriva soprattutto dalle famiglie di origine. Gli adulti rimangono legati economicamente ai genitori, che forniscono aiuto sia finanziario sia assistenziale. Nonostante tutto, le aspettative restano minime: molti intervistati, nota Xueyang Ma, fanno di tutto per proteggersi da emozioni negative e dichiarano di non avere grandi speranze per il futuro.
Il precariato, osserva l’autore, non è un’anomalia, ma un prodotto centrale della modernizzazione cinese: il passaggio a un’economia di mercato più dinamica ma anche più incerta.
Il fenomeno non è confinato alla sola Cina. India, Malesia e altri Paesi asiatici vedono crescere la gig economy, mentre nei Paesi occidentali i lavori occasionali diventano sempre più diffusi. Ma l’esperienza cinese, per portata e numeri, è il grande laboratorio globale. «Sarebbe inutile cercare di eliminare il lavoro saltuario sperando che venga sostituito da impieghi stabili», avverte l’Economist. La vera alternativa a questo precariato, spesso, è la disoccupazione.
Ecco perché la sfida è prima di tutto della politica. Pechino dovrebbe ridisegnare il contratto sociale per adattarlo a un mercato del lavoro sempre più frammentato. Questo significa rendere i contributi pensionistici più accessibili, ampliare le reti di welfare, regolamentare algoritmi e piattaforme. La Cina ha mosso i primi passi, imponendo regole agli operatori digitali e chiedendo alle grandi piattaforme di contribuire alla sicurezza sociale. Ma il percorso è lungo, e il rischio di avere un’intera generazione senza prospettive rimane alto.
La Cina ha già conosciuto trasformazioni radicali: dal collettivismo agricolo al boom industriale che ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà. Oggi, però, il banco di prova non è più la quantità di fabbriche costruite, ma la qualità delle vite che vi passano dentro e fuori.
Il destino del Paese – e di una grossa parte dell’economia globale – si gioca su questi duecento milioni di lavoratori precari. Se riusciranno a trasformare flessibilità in stabilità, la Cina potrà trovare nuova linfa nei consumi interni e nella coesione sociale. Altrimenti la promessa del miracolo cinese rischia di incrinarsi proprio dove poggia: nella vita quotidiana di chi lavora senza rete di protezione.
L'articolo L’economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

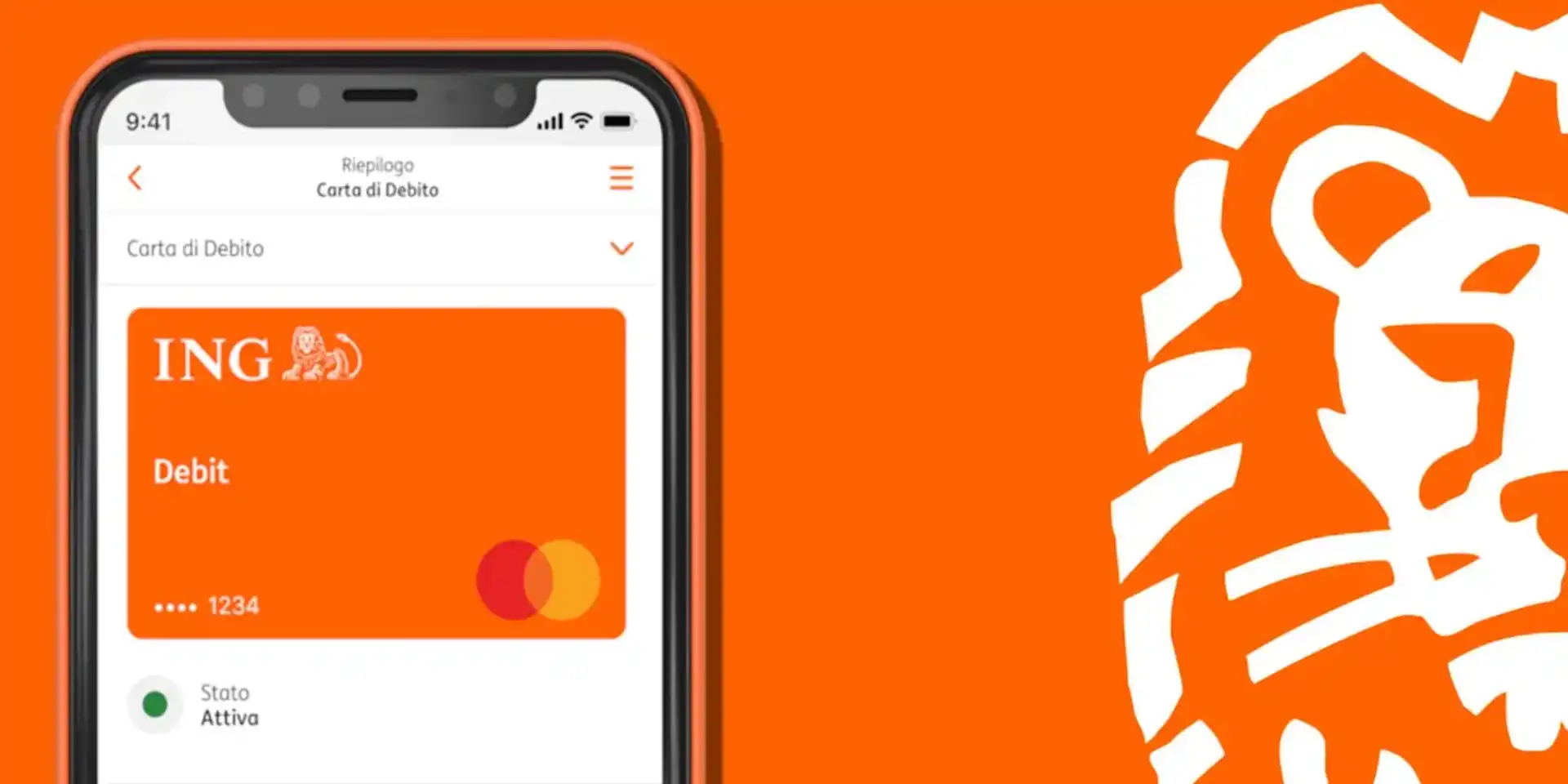














































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)