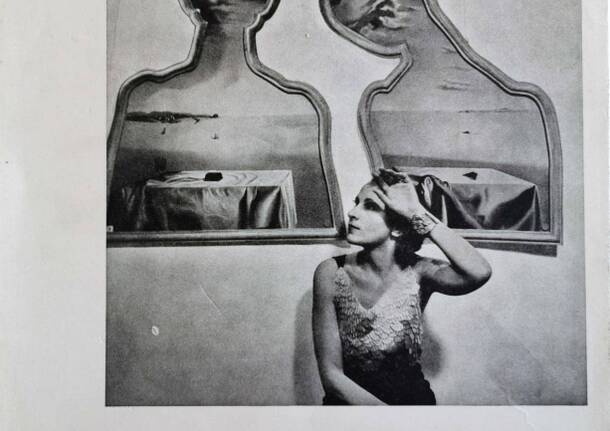L’Organizzazione mondiale della sanità nacque dal trauma dell’influenza spagnola


Ben prima del 1918 gli esperti di sanità pubblica avevano identificato la malattia contagiosa come uno dei più letali sottoprodotti della globalizzazione. In un saggio del 1895 intitolato The Microb as a Social Leveller (Il microbo come livellatore sociale), il commissario sanitario di New York, Cyrus Edson, osservava: «La malattia tiene insieme la specie umana al pari di una catena indistruttibile. Per di più, lo sviluppo industriale del mondo ha esteso questa catena fino a farle racchiudere in sé tutte le nazioni ». Per illustrare la questione, Edson ricordava la pandemia influenzale del 1889, che aveva imperversato in Russia e poi aveva «viaggiato lungo le vie del commercio dense di traffico fino in Germania, in Francia e in Inghilterra, per poi raggiungere infine gli Stati Uniti».
Edson non visse abbastanza a lungo per fare l’esperienza della pandemia influenzale del 1918, ma avrebbe potuto prevederla. Sebbene il bilancio delle vittime sia stato notoriamente difficile da stimare, l’«influenza spagnola» (che non ebbe origine in Spagna) investì sei continenti, raggiungendo isolati villaggi di montagna e isole remote. Il calcolo dei decessi è complicato dalla documentazione incompleta e dalla difficoltà di assegnare una causa di morte in popolazioni indebolite dalla fame del tempo di guerra e del periodo successivo.
Ma gli storici hanno stimato che siano deceduti tra i 24 e i 39 milioni di persone, con numeri di vittime sbalorditivamente elevati in Asia (19-33 milioni) e in Africa (1,9-2,3 milioni). Al confronto, si stima che 550.000 americani e 2,3 milioni di europei siano morti della malattia. Inoltre morirono più militari statunitensi di influenza spagnola rispetto a quanti ne siano stati uccisi in combattimento.
Anche il costo economico fu enorme. Gli economisti stimano che la pandemia del 1918 abbia ridotto la produzione manifatturiera del 18 per cento. Ferrovie e alberghi furono colpiti in modo particolarmente duro, insieme a negozi al dettaglio, miniere, ristoranti, bar e teatri: qualunque impresa, insomma, che dipendesse dalla possibilità di riunire una folla. L’influenza fu letale soprattutto per gli adulti nel pieno della vita, il che implicava una perdita incalcolabile per i familiari, tra cui migliaia di bambini che restavano senza genitori.
La rapida avanzata della malattia in tutto il mondo palesò la dimensione globale della guerra. Si diffondeva con i soldati, i marinai e i rifugiati che si accalcavano nelle caserme e negli accampamenti e attraversava gli oceani e le frontiere di stato su piroscafi e treni. Homer Folks, direttore del Dipartimento degli affari civili della Croce rossa americana, rifletteva su «Harper’s Magazine»: «I flussi costanti di prigionieri, soldati feriti, nuove reclute, profughi e lavoratori di ogni parte del mondo da e verso i luoghi di guerra rendono facilmente conto della velocità con cui l’influenza si è propagata a est e a ovest in tutto il mondo ». Le navi che trasportavano soldati e marinai nell’estate e nell’autunno del 1918 diffondevano il virus da Boston a Brest, da Plymouth a Freetown, da Manila a Guam, da Londra all’Australia e da Marsiglia all’Isola della Riunione.
Alla radice della trasmissione globale dell’influenza c’era la globalizzazione stessa. Persone e germi si spostavano così rapidamente che nel 1918 il tasso di mortalità raggiunse il picco simultaneamente a Parigi, Berlino, Zurigo e New York durante la settimana che terminava il 26 ottobre. Le autorità sanitarie pubbliche di New York credevano che l’influenza fosse entrata in città attraverso i suoi porti nell’agosto del 1918, a bordo di piroscafi che portavano il virus, soltanto in quel mese, da Kristiania (Norvegia), Liverpool (Regno Unito), Rotterdam (Olanda), Bordeaux (Francia) e Porto Said (Egitto). Entro la fine di ottobre 1918, il 48 per cento del personale di Ellis Island aveva contratto la malattia.
Nel Regno Unito i funzionari della sanità collegavano la «conquista » del mondo da parte della pandemia a un concorso letale di mobilità e conflitto globali. «Se in qualsiasi parte del mondo dovessero esserci vaste riunioni di uomini, sia a causa della guerra sia a causa di conflittualità economica … raggruppati en masse, ci sarebbero opportunità per altre modificazioni della materies morbi che la rendessero adatta a conquistare il mondo. Nessun cordone sanitario, nessuna quarantena farà da scudo contro questo pericolo».
I germi erano chiaramente indifferenti alle frontiere e prosperavano sull’indigenza e il conflitto. Per questi funzionari, ciò significava che l’unica arma efficace contro il diffondersi del virus era la cooperazione internazionale. «Rendersi conto che il benessere materiale degli abitanti di un paese straniero – magari anche ostile – è un nostro urgente interesse è assai gravoso. Eppure l’insegnamento di questa pandemia è che si tratta di una dura verità. Qualunque organizzazione sovranazionale per il controllo delle epidemie dovrà affrontarla.
All’indomani della pandemia, molti internazionalisti e funzionari della sanità pubblica presero sul serio questo consiglio, creando un sistema globale per lo scambio di informazioni e per la lotta contro le malattie contagiose. La nuova Organizzazione della sanità della Società delle Nazioni estese le iniziative sanitarie internazionali che risalivano all’epoca precedente la Prima guerra mondiale, come l’Ufficio internazionale di igiene pubblica (1905) e il Bureau sanitario panamericano (1902).
Organizzazioni filantropiche quali la Rockefeller Foundation investivano a loro volta massicciamente sulla sanità pubblica globale. Queste organizzazioni riflettevano l’idea che la mobilità di massa delle persone e delle merci in tutto il mondo implicasse anche la diffusione globale delle malattie, che richiedeva una risposta internazionale coordinata.
Tratto da “Contro il mondo” di Tara Zahra, Mondadori, 420 pagine, 28 euro

Copyright © 2023 by Tara Zahra
L'articolo L’Organizzazione mondiale della sanità nacque dal trauma dell’influenza spagnola proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































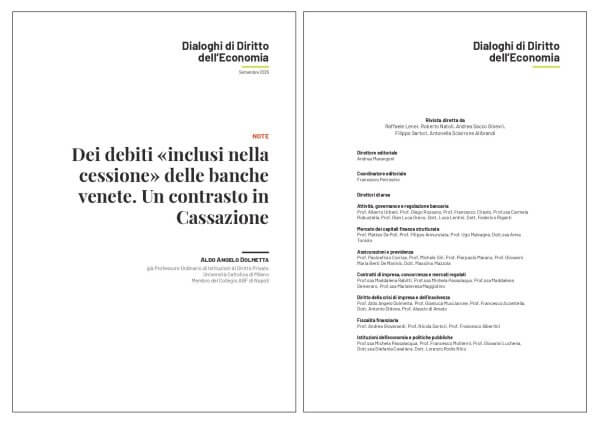
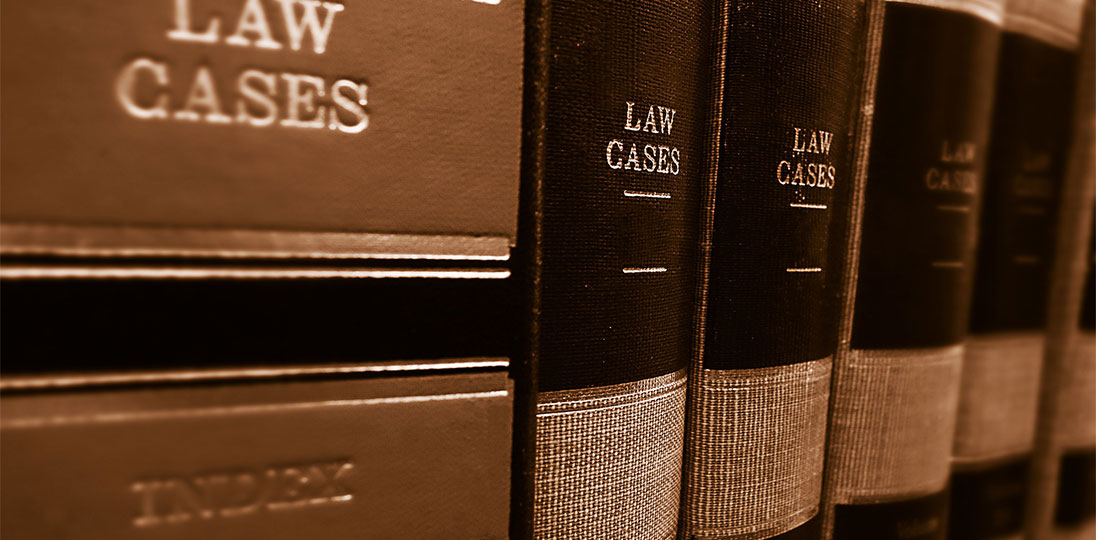



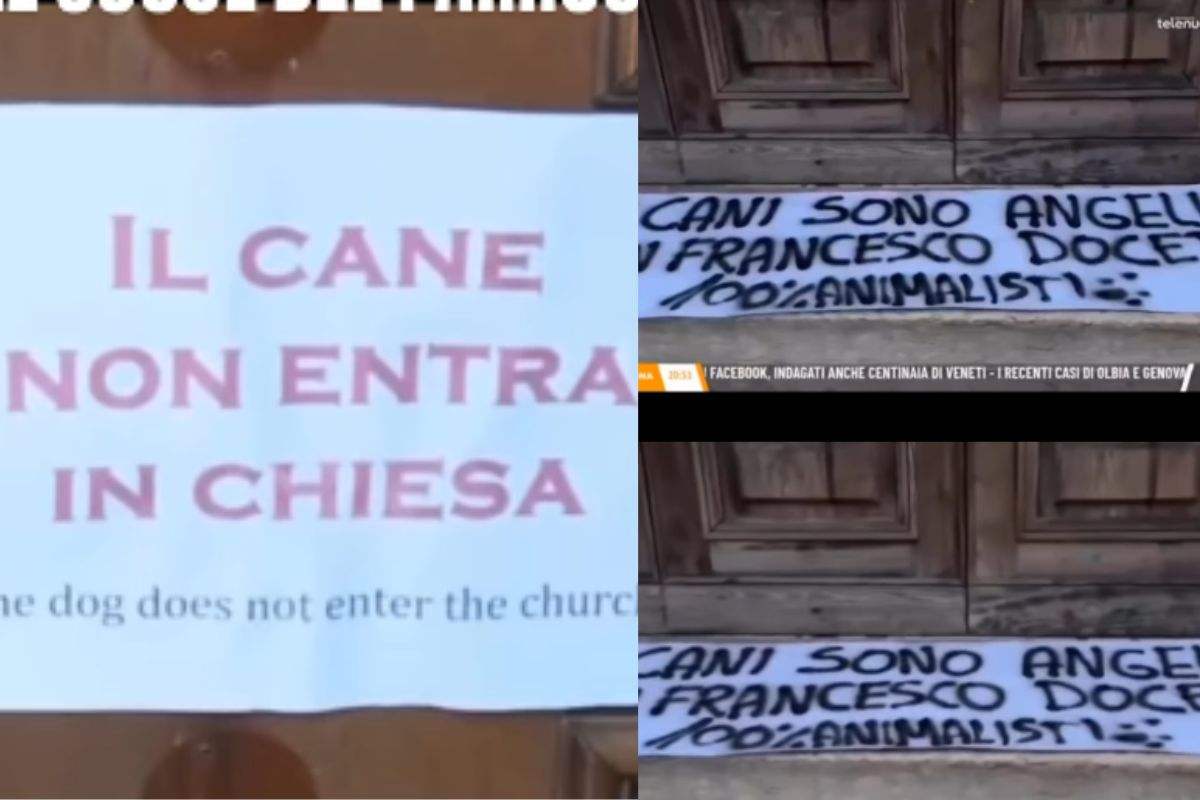

































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
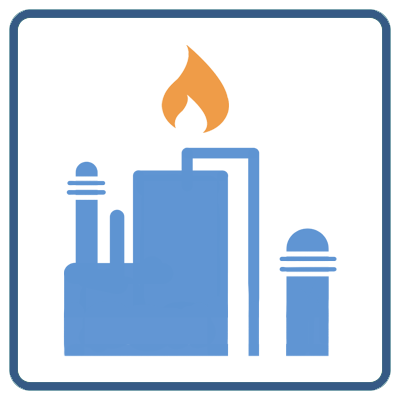


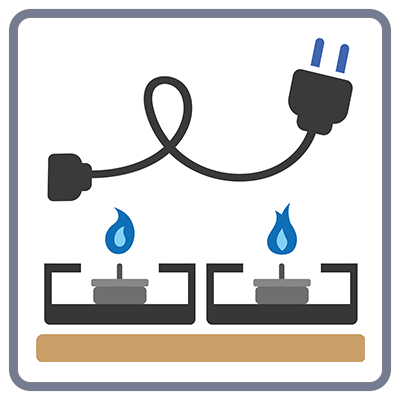


























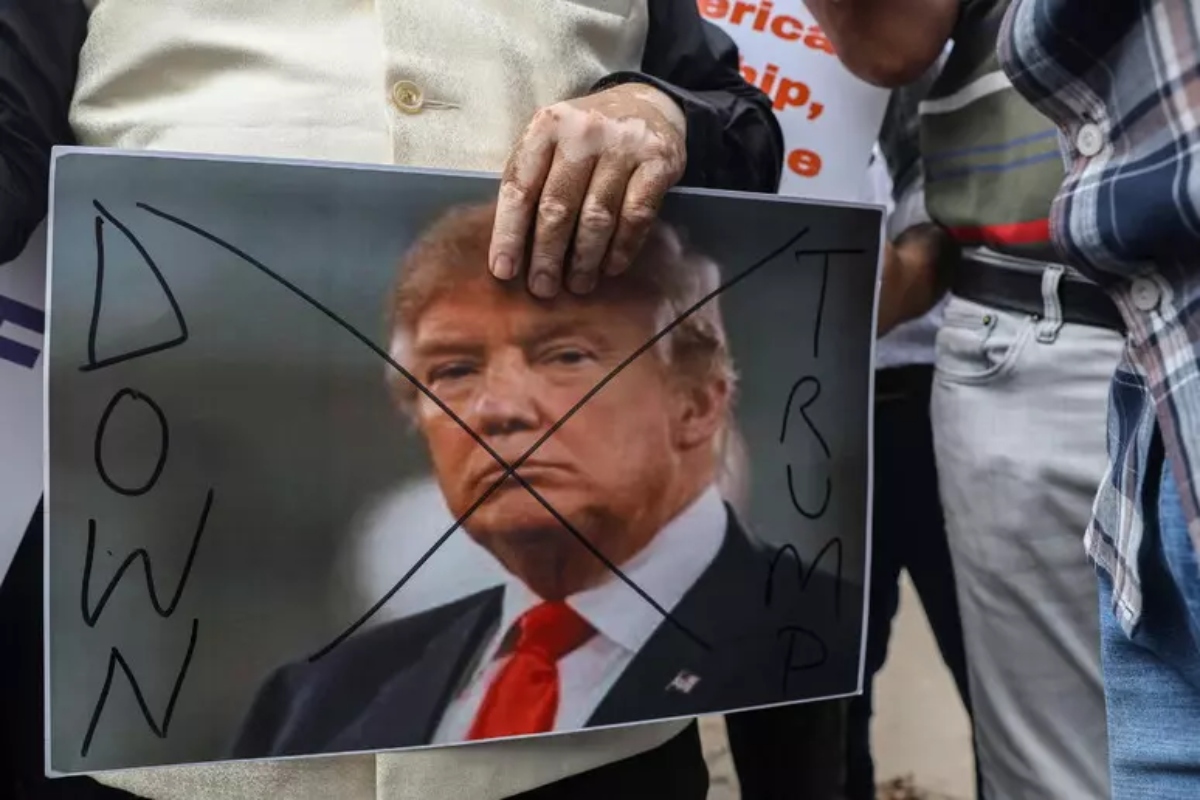





















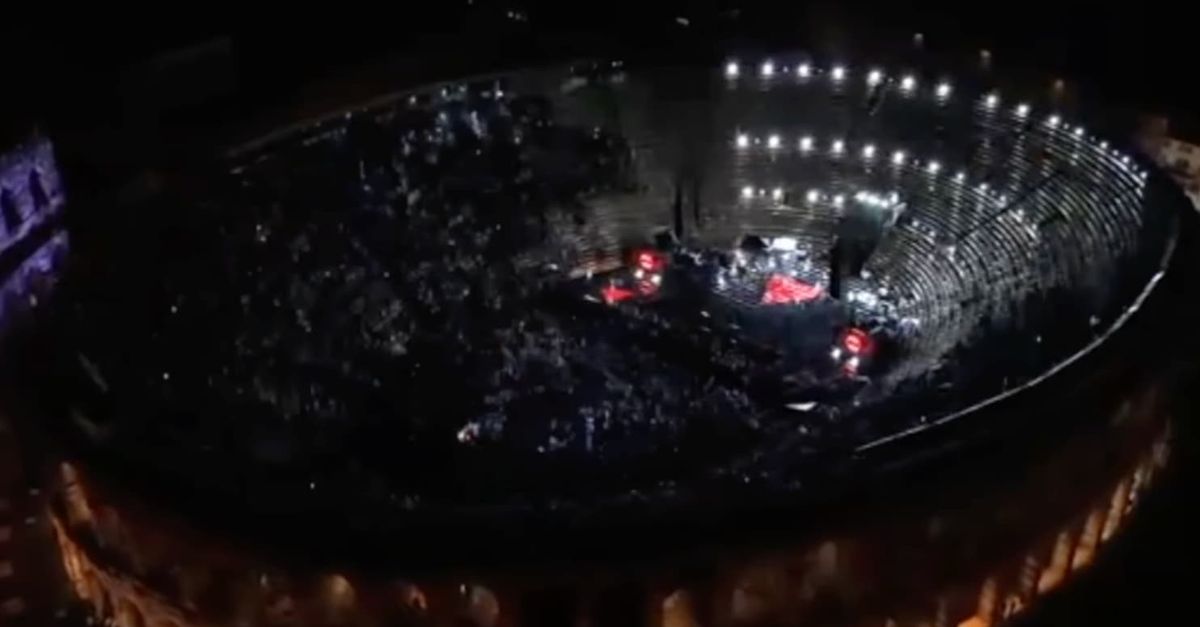






































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)