Riposizionare il collasso dell’Amoc nell’immaginario collettivo


Per la serie “cose che in Italia non potrebbero mai accadere”, in cima alla homepage del Guardian del 29 agosto spiccava un articolo sull’Amoc, un tema climatico (ma non solo) cruciale che nel nostro Paese viene approfondito solo dai media specializzati.
Amoc è l’acronimo di Atlantic meridional overturning circulation, che in italiano si traduce in Circolazione atlantica meridionale di capovolgimento. Si tratta di un sistema di correnti oceaniche essenziali per la regolazione del clima. Dall’Amoc, che esiste solo nel Nord Atlantico, dipende infatti la circolazione di calore dall’Equatore fino ai poli.
Questo fattore è strettamente connesso alla circolazione atmosferica, che impatta sulle precipitazioni e le temperature. Come insegnano le perturbazioni successive alle ondate di calore, tra l’oceano e l’atmosfera c’è un costante scambio di energia. Queste correnti, come spiega il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), sono alimentate «dallo sprofondamento di acqua densa fredda e salata nel Nord Atlantico subpolare, dovuto all’elevata perdita di calore per scambio con l’atmosfera polare fredda».
L’Amoc torna ciclicamente in cima al dibattito climatico perché, prima o poi, potrebbe collassare a causa del cambiamento climatico di origine antropica. Per “collasso” intendiamo l’arresto di queste correnti oceaniche per via della diminuzione della densità superficiale dell’oceano nell’area interessata, specialmente a causa dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e dell’aumento delle piogge in certe zone interessate dall’Amoc. Questi flussi d’acqua dolce portano a un rallentamento delle correnti che, nel peggiore degli scenari, rischia di sfociare in un’interruzione totale del sistema.

La scienza del clima lo considera un tipping point, ossia un punto di non ritorno che ci separa da conseguenze gravi e irreversibili: abbassamenti repentini della temperatura, innalzamento del livello dei mari, eventi meteorologici ancora più estremi e molto altro. Se il riscaldamento globale ha una certa gradualità nei suoi effetti, il collasso dell’Amoc innescherebbe conseguenze molto più rapide e con scarsi margini di adattamento.
L’Amoc è un argomento di nicchia perché il suo blocco, in teoria, avverrà tra moltissimi anni. Per natura, noi esseri umani non riusciamo mai ad avere una visione a lungo termine proiettata verso le generazioni future: è il brutto vizio alla base del cambiamento climatico. Tuttavia, l’articolo del Guardian citato all’inizio mostra che l’arresto di queste correnti oceaniche non può più essere considerato un evento a bassa probabilità.
Il quotidiano britannico ha riportato in esclusiva i risultati di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Environmental research letters, che ha per la prima volta analizzato l’andamento dell’Amoc usando modelli climatici capaci di guardare oltre il 2100. In uno scenario di aumento delle emissioni, il settanta per cento delle simulazioni emerse dalla ricerca ha mostrato che l’Amoc andrà incontro a un collasso. Con un «livello intermedio» di emissioni il rischio dovrebbe scendere, attestandosi al trentasette per cento. Anche nello scenario più ottimistico («basse emissioni e rispetto dell’accordo di Parigi»), la probabilità di un blocco dell’Amoc resterebbe allarmante: venticinque per cento.
Secondo Stefan Rahmstorf, professore del Potsdam institute for climate impact research che ha fatto parte del team di ricerca, «i risultati sono piuttosto scioccanti. Fino a poco tempo fa sostenevo che le probabilità di un collasso dell’Amoc a causa del riscaldamento globale fossero inferiori al dieci per cento. Ora, persino in uno scenario a basse emissioni, la stima sembra più vicina al venticinque per cento».
Rahmstorf ha poi sottolineato come queste cifre vadano lette in un’ottica di valutazione del rischio: «Anche una possibilità del dieci sarebbe già inaccettabile. Dai nostri dati emerge che il punto di non ritorno, oltre il quale il collasso diventa inevitabile, potrebbe arrivare entro i prossimi dieci-vent’anni. È un dato sconcertante, che conferma la necessità di agire con urgenza per ridurre drasticamente le emissioni», spiega al Guardian.
Le temperature dell’aria nell’Artico stanno aumentando a un ritmo sempre più rapido a causa del cambiamento climatico. Questo fenomeno provoca un raffreddamento più lento delle acque oceaniche, con conseguenze significative sul delicato equilibrio delle correnti marine.
L’acqua più calda, infatti, è meno densa e tende a sprofondare più lentamente. A questo si aggiunge un ulteriore effetto: la maggiore quantità di piogge che si accumula nelle acque superficiali – già ricche di sale – ne riduce ulteriormente la densità. Si crea così, come accennavamo all’inizio, un circolo vizioso che rallenta progressivamente le correnti.
In un certo senso, i risultati di questo studio sono in controtendenza rispetto agli scenari dell’Ipcc. Ma, come si legge in questo approfondimento su Duegradi, «la comunità scientifica nutre dei dubbi in merito alla capacità dei modelli usati per l’Ipcc nel simulare correttamente la dinamica di Amoc e, quindi, un suo eventuale tipping point».
La ricerca scientifica sull’Amoc ha una grande lacuna, che ancora non ci permette di avere certezze granitiche: i modelli utilizzati non includono il flusso d’acqua sciolta proveniente dalla calotta glaciale della Groenlandia. Per questo, spiega al Guardian la professoressa Aixue Hu del Global climate dynamics daboratory (non coinvolta nello studio), è impossibile prevedere quando avverrà il collasso dell’Amoc o quando verrà superato il punto di non ritorno. Gli esperti, però, sembrano quasi tutti d’accordo: è una questione di “quando”, non di “se”.
L'articolo Riposizionare il collasso dell’Amoc nell’immaginario collettivo proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






























































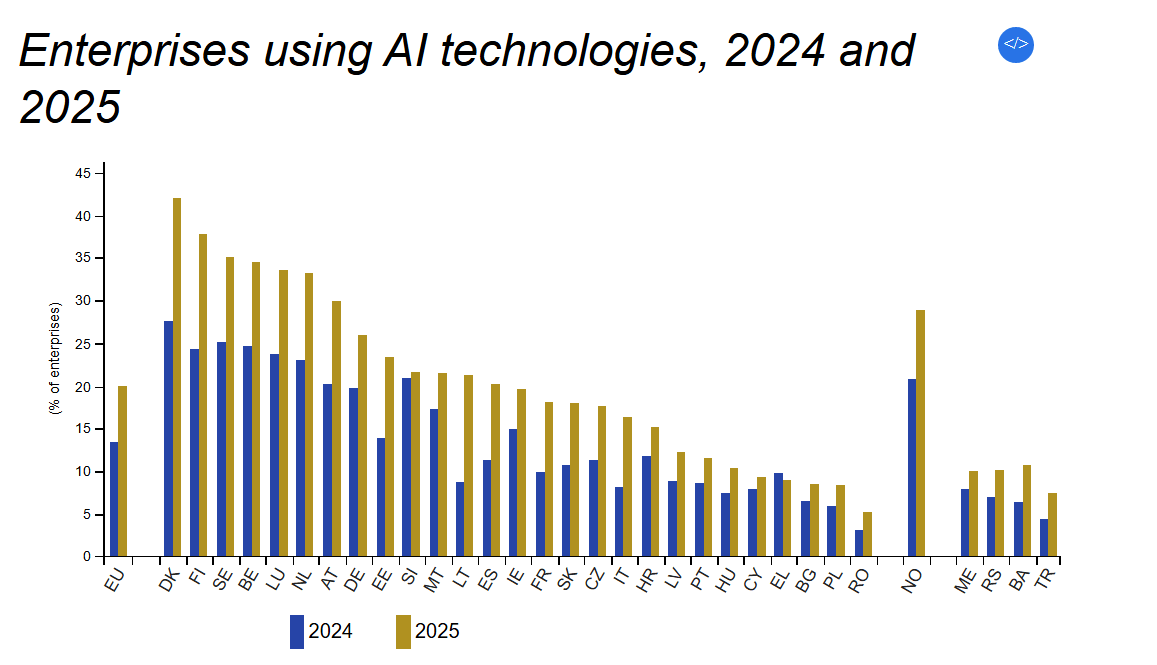
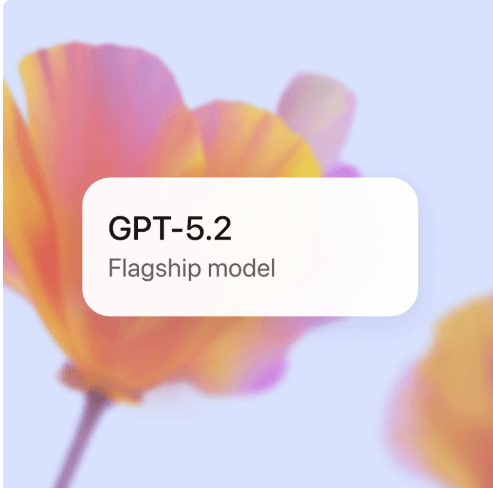






























































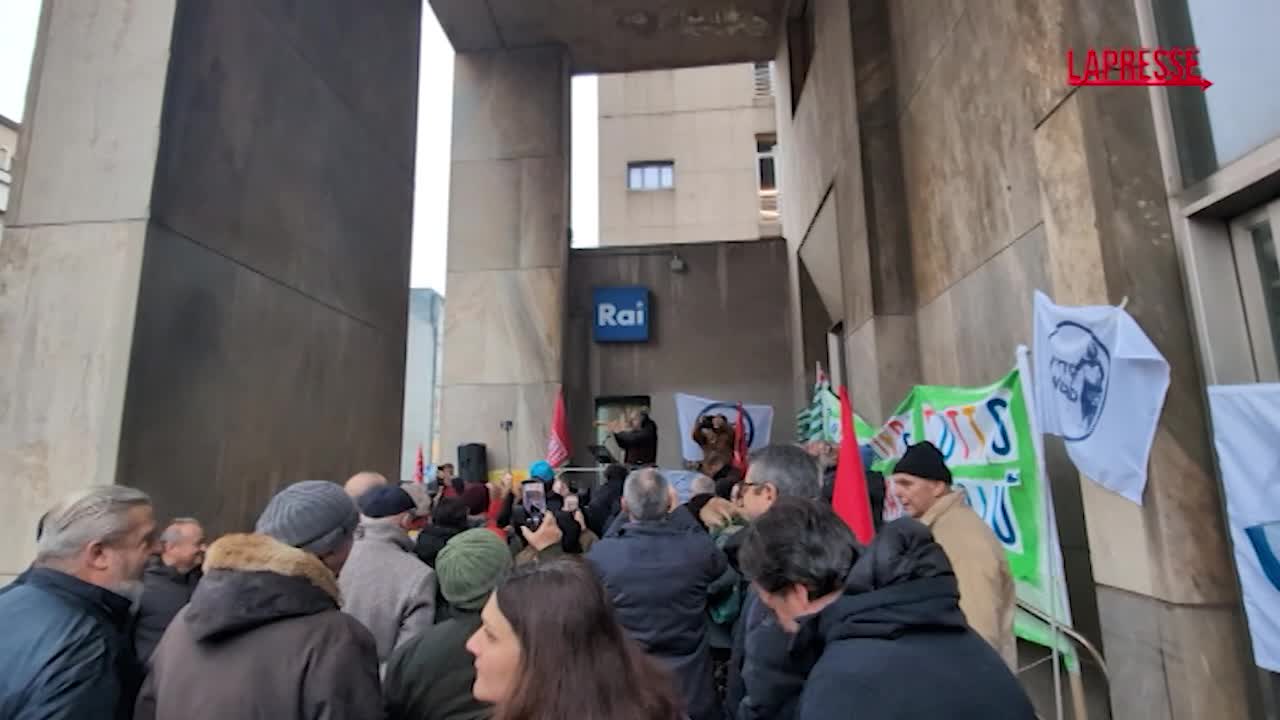






















































_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)
-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































