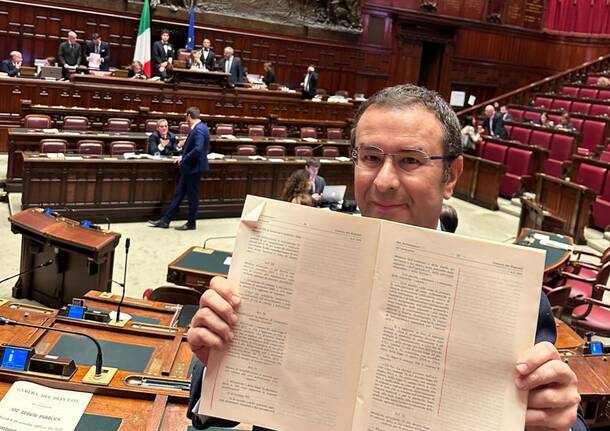Il sogno di Trump è l’incubo lynchiano dell’Occidente


Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine ordinabile qui.
Il miglior tributo che il destino potesse riservare a David Lynch, dopo la sua morte, è stato trasformare gli Stati Uniti in un suo film. Un sogno perturbante in cui la logica è un relitto del passato e le decisioni impulsive sono dettate dall’inconscio. Viviamo in tempi impazziti e, per una volta, sappiamo a chi dare la colpa: Donald Trump. L’incubo lynchiano dell’Occidente è in realtà il sogno del presidente degli Stati Uniti, un settantanovenne pregiudicato e spregiudicato, a cui gli americani hanno regalato un ultimo giro di giostra a spese di tutto il resto del mondo.
Dopo quattro anni di fantasia al potere e un tentativo di golpe in diretta televisiva, Trump è tornato nella stanza dei bottoni e li sta pigiando tutti nella speranza di rendere reversibile il declino dell’impero americano. Se nel primo mandato ha flirtato col caos, nel secondo lo sta adottando come metodo, e così ci siamo ritrovati in una sequenza di episodi che, presi singolarmente, sembrano sketch surreali. Uno su tutti: i giocatori della Juventus, in piedi nello Studio Ovale, dietro Trump, mentre il presidente allude a un intervento militare americano in Iran. Stupire è l’unica cosa che conta. Questi episodi di dadaismo politico raccontano la coerente follia di una linea temporale in cui la Storia ha sepolto il libro di Francis Fukuyama e cerca la sua rivincita sulla globalizzazione.
Il ritorno del trumpismo non è un banale déjà-vu, né la solita tragedia che poi diventa farsa. Piuttosto, assomiglia a un incidente stradale che non riusciamo a smettere di guardare perché ci blocca la strada.
Come siamo arrivati a questo punto? Agevoliamo un riassunto di questi pazzi tempi, non tanto per noi sfortunati contemporanei, ma per chi leggerà questo magazine nel 2050 e si chiederà se eravamo coscienti della follia di questo primo semestre del Trump II. La risposta breve è sì, parecchio, ma ci stiamo abituando in fretta.
Il primo shock è arrivato a fine febbraio, quando una normale photo opportunity nello Studio Ovale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è trasformata nella più meschina pubblica umiliazione di un alleato da parte del presidente degli Stati Uniti. Trump, spalleggiato dal suo vice J.D. Vance, più realista del re, ha attaccato Zelensky, accusandolo di ingratitudine e minacciando di tagliare gli aiuti americani all’Ucraina se non avesse accettato un accordo di pace modellato sulle richieste del Cremlino. Questo tentativo di piegare l’aggredito in nome della realpolitik si è rivelato una messinscena goffa che ha ricordato agli alleati europei quella frase attribuita a Churchill sugli americani che faranno sempre la cosa giusta dopo aver esaurito tutte le alternative. E così il populista, che durante la campagna elettorale aveva promesso di fermare la guerra in Ucraina in sole ventiquattr’ore, è riuscito nell’impresa opposta: ha minato la credibilità degli Stati Uniti, rafforzato Putin e sabotato una trattativa che solo una sofisticata diplomazia avrebbe potuto salvare.
Deposti i panni del negoziatore immobiliare, Trump ha scelto di dichiarare una guerra commerciale al resto del mondo con una messa in scena degna di un piazzista degli anni Ottanta. Nel Giardino delle Rose della Casa Bianca ha esibito un enorme cartellone diviso in due colonne: da un lato, le presunte tasse imposte ai prodotti statunitensi da Cina, Unione europea, Vietnam e altri Paesi; dall’altro, i controdazi introdotti dall’amministrazione americana come ritorsione. Nel giro di poche ore, però, si è scoperto che quei numeri erano profondamente fuorvianti: le percentuali mostrate derivavano da un calcolo scorretto, ottenuto dividendo il deficit commerciale bilaterale con ciascun Paese per il totale delle importazioni da quello stesso Stato. Un trucco da principianti, che ha reso Trump simile al lupo della favola di Esopo pronto a inventare qualsiasi scusa pur di divorare l’agnello, senza rimorsi.
Questo tempo eretico ha i suoi lati positivi: Trump è talmente coreografico nel suo disordine da permettere anche a noi europei di vedere il retrobottega del potere americano. Tradimenti, ripensamenti, decisioni impulsive: tutto è sotto i nostri occhi, in tempo reale. Soffrono i complottisti, esultano gli studenti di Scienze politiche.
Abbastanza grottesca, più che divertente, è stata la lite tra Elon Musk e Donald Trump. Il padrone di X (il fu Twitter) si era presentato alla Casa Bianca da conquistatore. Centodiciannove milioni di dollari versati al Partito Repubblicano in cambio di un ministero su misura: il Dipartimento per l’Efficienza del Governo, ritagliata attorno al suo ego e alle sue ambizioni. Musk sognava di guidare la macchina statale come una start-up, di piegare la politica alle esigenze delle sue tre aziende: Tesla, Starlink e SpaceX. Per un attimo, ci è riuscito: mai si era visto un finanziatore avvicinarsi tanto al potere senza neanche scottarsi. Infatti, poi si è bruciato.
Quello che doveva essere il sodalizio del secolo tecnopopulista è finito con un cortocircuito mediatico a colpi di meme e risentimento. Galeotto fu il Big Beautiful Bill, una maxi legge proposta da Trump che, tra detrazioni e cavilli, taglia gli incentivi fiscali alle energie verdi. Compresi, ovviamente, quelli per le auto elettriche di Elon Musk. Il fondatore di Tesla l’ha presa sul personale: ha riesumato vecchi tweet di Trump contro il deficit e fatto circolare allusioni venefiche sul caso Epstein.
I maliziosi dicono che cercasse solo un pretesto per sganciarsi con onore dal Doge, visti i deludenti risultati e le sue aziende in discesa libera, anche per via del suo coinvolgimento politico. Ma per una volta, Trump ha fatto ciò che si aspetta da un presidente: ha ricordato che il potere pesa più del denaro. Musk, fiutando l’odore di appalti federali svaniti, ha smorzato i toni, chiesto tregua.
Poi, da imprenditore visionario, ha capito che se il sistema non può essere hackerato, va riscritto da zero. Il 4 luglio ha annunciato la nascita ufficiale dell’America Party: un terzo polo tecno-populista per “restituire la libertà” agli americani. Quindi Trump non solo non si è liberato di un alleato scomodo, ma ha creato involontariamente la sua nemesi.
Nel frattempo, Los Angeles è tornata agli anni Sessanta. Quartieri bloccati, fumo, vetrine in frantumi, sirene continue. Tutto è cominciato con una serie di retate dell’Agenzia federale per l’immigrazione (Ice), sostenute e incitate dalla Casa Bianca, nei sobborghi e nei mercati: agenti in mimetica, arresti pubblici, furgoni neri. Lo spirito anti-tirannico dei californiani ha fatto il resto: prima cortei spontanei, poi scontri, infine guerriglia urbana, come nei cinque giorni di Watts del 1965. Trump ha scelto, come spesso accade, la via peggiore, inviando prima la Guardia Nazionale, sottraendola al governatore Gavin Newsom, e poi i Marines. La città è diventata un campo di battaglia: coprifuoco, razzi lacrimogeni e i soliti post in caps lock: «INSURREZIONE!». Sembrava lo spin-off di “Civil War”, il thriller distopico in cui Texas e California si ribellano a un presidente autoritario. Tra qualche mese, potremmo definirlo profetico.
Ad approfittare di questo semestre di caos trumpiano è stato Benjamin Netanyahu. Per restare aggrappato al potere e sottrarsi ai processi per corruzione – e alle colpe politiche per il massacro del 7 ottobre – il premier israeliano ha costretto il presidente più isolazionista del mondo a fare l’impensabile: bombardare l’Iran. Per dodici giorni, Trump ha mostrato a corrente alternata le sue due nature: quella dell’uomo d’affari che vuole chiudere un accordo e quella del politico che non può permettersi di sembrare debole. Ha tentato la via diplomatica, con negoziati condotti dietro le quinte, ma ha finito per cedere al fatto compiuto. Netanyahu era deciso, e Trump, più che convincerlo a fermarsi, ha preferito salire sopra il suo carro per non rimanere indietro. Prima ha offerto sostegno d’intelligence, poi ha autorizzato i raid su tre siti nucleari iraniani. Le bombe americane sono cadute, ma l’uranio era già stato spostato. Il programma atomico è stato rallentato di qualche mese, ma forse resta intatto. Più che un buco nella montagna, si è rivelato un buco nell’acqua.
Trump ha mostrato un’ansia da prestazione geopolitica. Ha scelto di esserci, come sempre, purché si parlasse di lui. Anche a costo di affiancarsi a un’operazione senza risultati concreti, di correre verso una guerra che diceva di voler evitare. Per rimediare, ha provato a ritagliarsi il ruolo di pacificatore annunciando la tregua dopo «La guerra dei dodici giorni», salvo poi essere smentito da attacchi e contrattacchi di Israele e Iran. Lì abbiamo visto qualcosa di inedito: non più il noncurante sarcasmo da comizio, ma la rabbia di chi sa di aver sbagliato strategia. «Non sanno che cazzo stanno facendo», ha detto prima di salire sull’aereo presidenziale. Non è il solo a pensarlo.
Trump ha infranto l’unica promessa che davvero non doveva tradire con i militanti del suo movimento, il Make America Great Again (Maga). Quella che teneva insieme tutto: protezionismo e isolazionismo, niente guerre, niente missioni civilizzatrici, solo confini chiusi e interessi nazionali. Com’era prevedibile, la base non l’ha presa bene. Il primo a fiutare il malcontento è stato Tucker Carlson. L’ex giornalista di Fox News e menestrello dell’ultradestra americana ha parlato di «errore strategico imperdonabile». Ha accusato Trump di aver consegnato il Paese proprio a quel deep state che diceva di voler abbattere: il Pentagono, la CIA, i generali pronti a bombardare, i droni che partono da soli. Altro che America First: qui, dice Carlson, siamo tornati alle ricette dei neocon, quelli che Trump doveva rottamare. Da Maga a Maga Magò è un attimo.
Altre perle imperdibili del trumpismo sono state fagocitate dalla cronaca, ma meritano una menzione speciale: la proposta di allargare il G7 anche a Russia e Cina, quella di annettere il Canada come il cinquantunesimo Stato americano, comprare la Groenlandia, rendere la Striscia di Gaza un resort e rinominare il golfo del Messico in Golfo d’America. Tutto sommato, quest’ultima sembra la meno bislacca.
Non sappiamo come finirà questo incubo dell’Occidente. Se le elezioni di midterm toglieranno elettricità al luna park trumpiano o ci aspetteranno altri tre anni e mezzo di questi tempi impazziti. Al momento ci sentiamo come nella scena iniziale (e finale) di “Strade perdute”, capolavoro di Lynch del 1997, in cui la strada poco illuminata davanti a noi si ripete all’infinito, mentre i fari dell’auto bucano appena l’oscurità e la colonna sonora martella come un presagio. È la vertigine dell’incertezza, dove ogni curva può nascondere un’altra allucinazione, un altro colpo di scena. Così Trump, smanioso di passare alla Storia in qualsiasi modo, guida l’America a tutta velocità senza sapere dove sta andando. Il suo sogno, il nostro incubo.
L'articolo Il sogno di Trump è l’incubo lynchiano dell’Occidente proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0









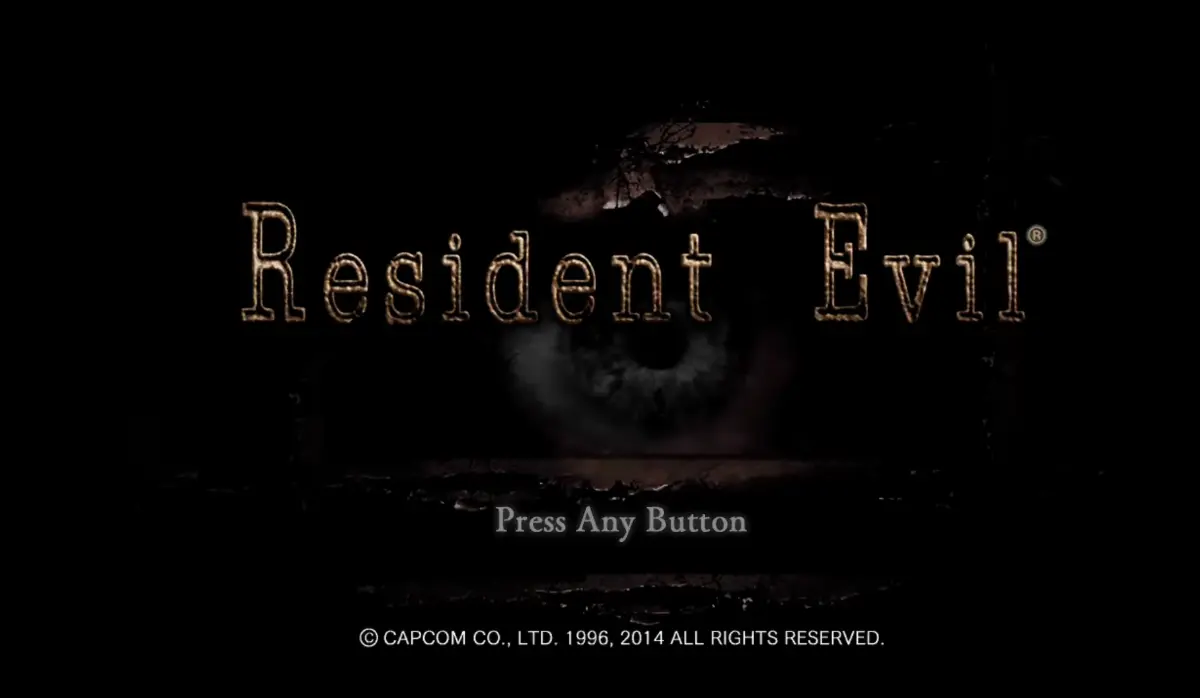
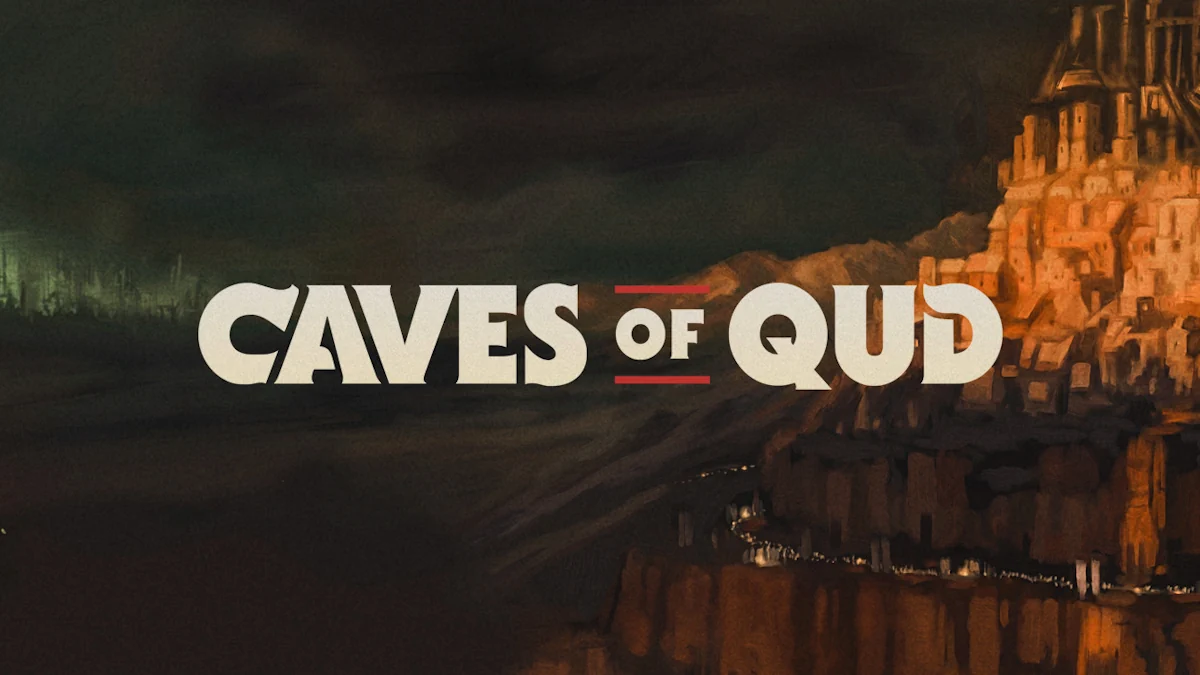










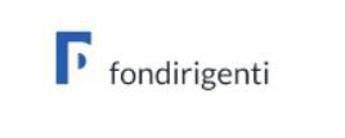
















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)

























































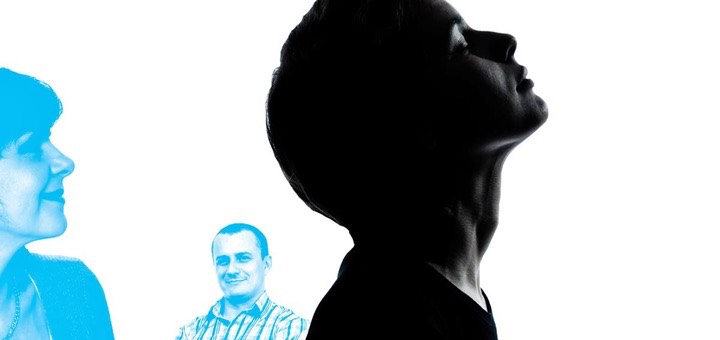






























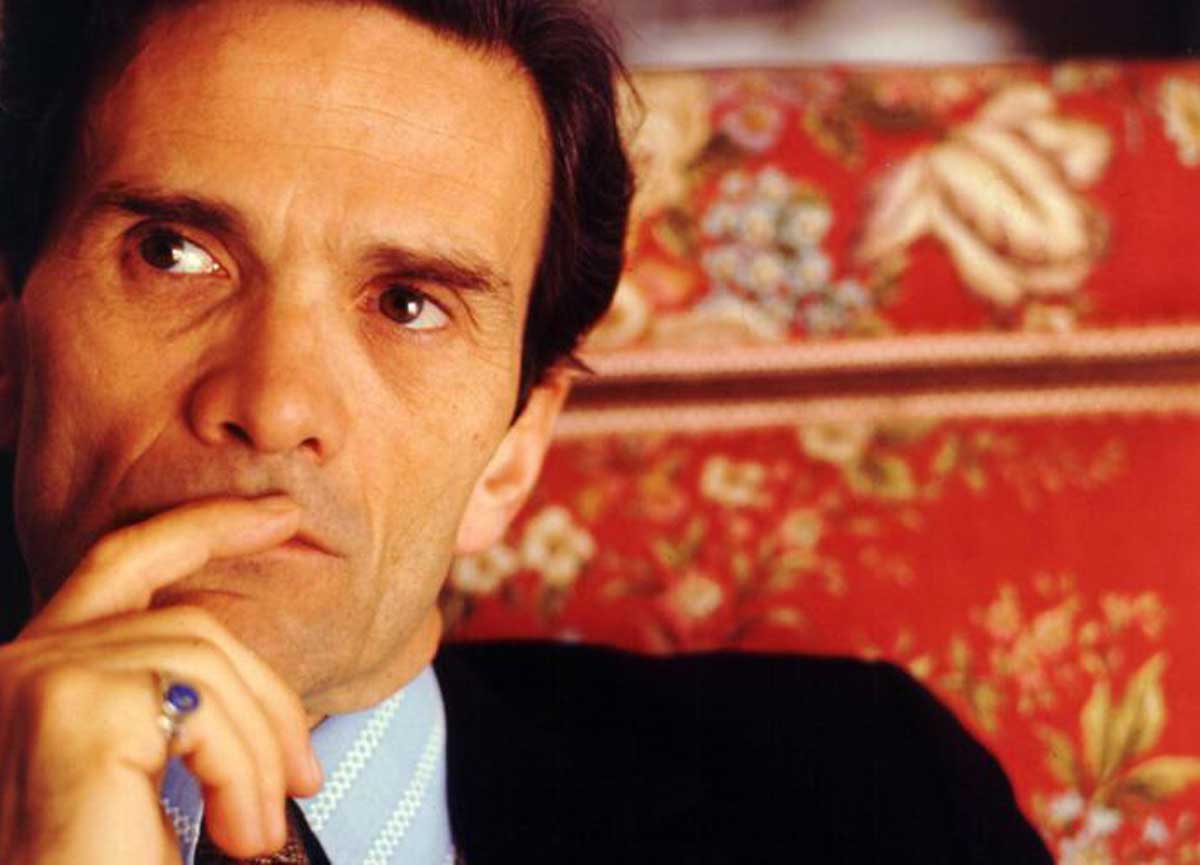

























































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)