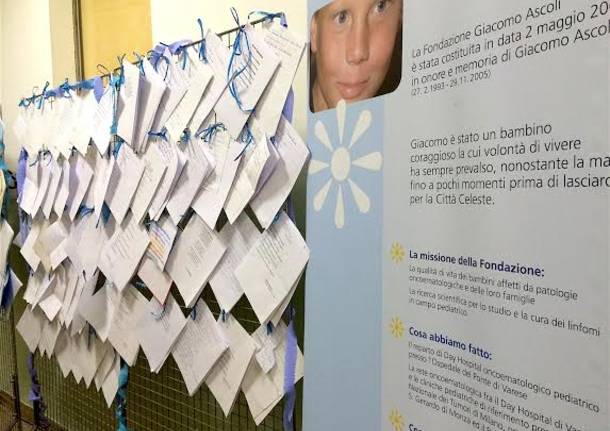Super tempesta solare: cosa è successo nel 2024?
Una supertempesta geomagnetica è un fenomeno estremo di meteorologia spaziale che si verifica quando il Sole emette enormi quantità di energia sotto forma di radiazioni e particelle cariche, note come "vento solare". Quando queste particelle raggiungono la Terra, possono sconvolgere il suo campo magnetico generando tempeste geomagnetiche. Le supertempeste sono rare: si presentano in media una volta ogni 20-25 anni.. Tempesta di Gannon. Il 10 e 11 maggio 2024 la Terra è stata investita dalla supertempesta più intensa degli ultimi due decenni, conosciuta come "Tempesta di Gannon (in memoria di Jennifer Gannon, fisica specializzata in Space Weather)" o "Tempesta della Festa della Mamma".
Uno studio guidato dal Atsuki Shinbori dell'Institute for Space-Earth Environmental Research dell'Università di Nagoya ha registrato per la prima volta misurazioni dirette e dettagliate su come la supertempesta abbia influenzato la "plasmasfera", una regione della magnetosfera terrestre, composta da plasma freddo (ioni ed elettroni) che circonda la Terra e si estende oltre l'alta atmosfera, seguendo le linee del campo magnetico. È uno degli scudi naturali che circondano la Terra.
I risultati, pubblicati sulla rivista Earth, Planets and Space, mostrano come la plasmasfera e la ionosfera — lo strato dell'atmosfera ricco di particelle cariche — abbiano reagito durante la violenta tempeste solare. Queste informazioni sono cruciali per prevedere possibili malfunzionamenti a satelliti, GPS e reti di comunicazione durante eventi estremi di meteo spaziale.. nel posto giusto al momento giusto. Il satellite Arase, lanciato dalla JAXA (l'Agenzia Spaziale Giapponese) nel 2016, attraversa regolarmente la plasmasfera misurando onde di plasma e campi magnetici. Durante la supertempesta del maggio 2024, si è trovato nella posizione ideale per osservare da vicino la drastica compressione e il lento recupero della plasmasfera, registrando dati mai ottenuti prima.
Per la prima volta, infatti, gli scienziati hanno potuto osservare in modo continuo e diretto la plasmasfera che si restringeva fino a un'altitudine eccezionalmente bassa per una supertempesta.
«Grazie ad Arase e ai ricevitori GPS a terra» — spiega Shinbori — «abbiamo monitorato contemporaneamente plasmasfera e ionosfera. Questo ci ha permesso di capire quanto la plasmasfera si sia ridotta e perché il suo recupero sia stato così lento». In condizioni normali la plasmasfera si estende fino a circa 44.000 km sopra la superficie terrestre. Durante la tempesta, il suo confine esterno è crollato a soli 9.600 km, una compressione pari a un quinto delle sue dimensioni abituali.. Un Sole iperattivo all'origine della supertempesta. La tempesta è stata causata da una serie di grandi eruzioni solari (espulsioni di massa coronale) che hanno scagliato nello spazio miliardi di tonnellate di particelle cariche. In sole nove ore la plasmasfera è stata compressa in maniera eccezionale e ha impiegato oltre quattro giorni per riprendersi: il periodo di recupero più lungo mai osservato da quando Arase monitora questo strato, dal 2017.
«Abbiamo scoperto» — riferisce Shinbori — «che la tempesta ha inizialmente riscaldato intensamente l'atmosfera vicino ai poli, per poi causare un drastico calo di particelle cariche nella ionosfera. Questo ha rallentato la ricostruzione della plasmasfera, con effetti potenzialmente gravi su GPS, satelliti e comunicazioni».. Aurore spettacolari a latitudini insolite. Durante la fase più forte della tempesta, il campo magnetico terrestre è stato talmente compresso da permettere alle particelle solari di spingersi molto più vicino all'equatore. Il risultato è stato un aumento eccezionale delle aurore boreali, visibili in regioni dove solitamente non compaiono.
Di norma, le aurore si osservano vicino ai poli, dove il campo magnetico terrestre convoglia le particelle solari nell'atmosfera. Ma la potenza della supertempesta ha spinto la "zona aurorale" fino a Giappone, Messico ed Europa meridionale, luoghi in cui questi fenomeni sono rarissimi.. LA "tempesta negativa". Circa un'ora dopo l'inizio della supertempesta, grandi quantità di particelle cariche nell'alta atmosfera sono state trasportate verso i poli. Quando l'attività solare ha iniziato a diminuire, la plasmasfera ha iniziato a ricostituirsi grazie alle particelle provenienti dalla ionosfera. Normalmente servono uno o due giorni perché la plasmasfera torni alle dimensioni abituali.
In questo caso il recupero è durato quattro giorni, a causa di un fenomeno chiamato "tempesta negativa": un'improvvisa diminuzione delle particelle nella ionosfera dovuta a modifiche chimiche causate dal forte riscaldamento atmosferico. Durante una tempesta negativa diminuisce la quantità di ioni di ossigeno che contribuiscono a trasportare le particelle di idrogeno necessarie a riempire la plasmasfera. In pratica, gli ioni di ossigeno modificano i campi elettrici e magnetici locali che aiutano i protoni (H⁺) a salire nella plasmasfera. Si tratta di fenomeni invisibili, rilevabili solo tramite strumenti satellitari.
«La tempesta negativa» — sottolinea Shinbori — «ha rallentato la ripresa alterando la chimica dell'atmosfera e riducendo l'afflusso di particelle. Un collegamento così chiaro tra tempesta negativa e ritardo nel recupero non era mai stato osservato prima».. Come reagisce la Terra. Durante la supertempesta di maggio, diversi satelliti hanno subito problemi elettrici, interruzioni nei dati, disturbi ai segnali GPS e interferenze nelle comunicazioni radio. Comprendere quanto tempo impiega la plasmasfera a riprendersi dopo eventi così violenti è essenziale per migliorare le previsioni del meteo spaziale e per proteggere le tecnologie da cui dipendono comunicazioni, navigazione e osservazione della Terra..
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0








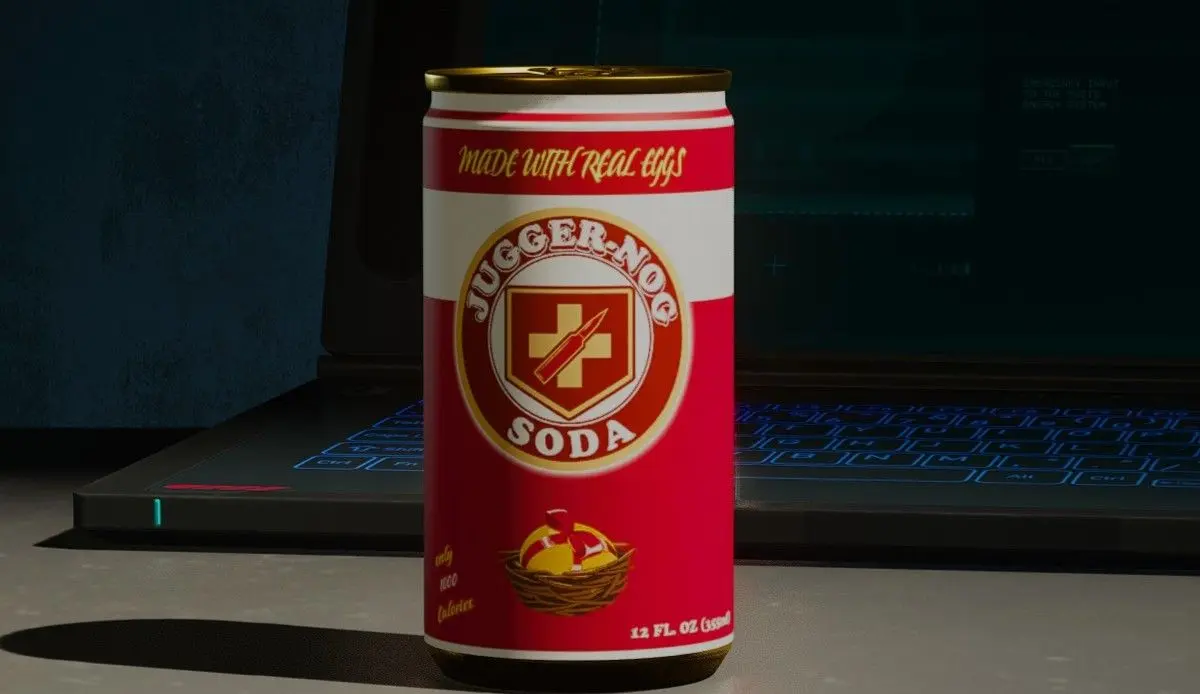


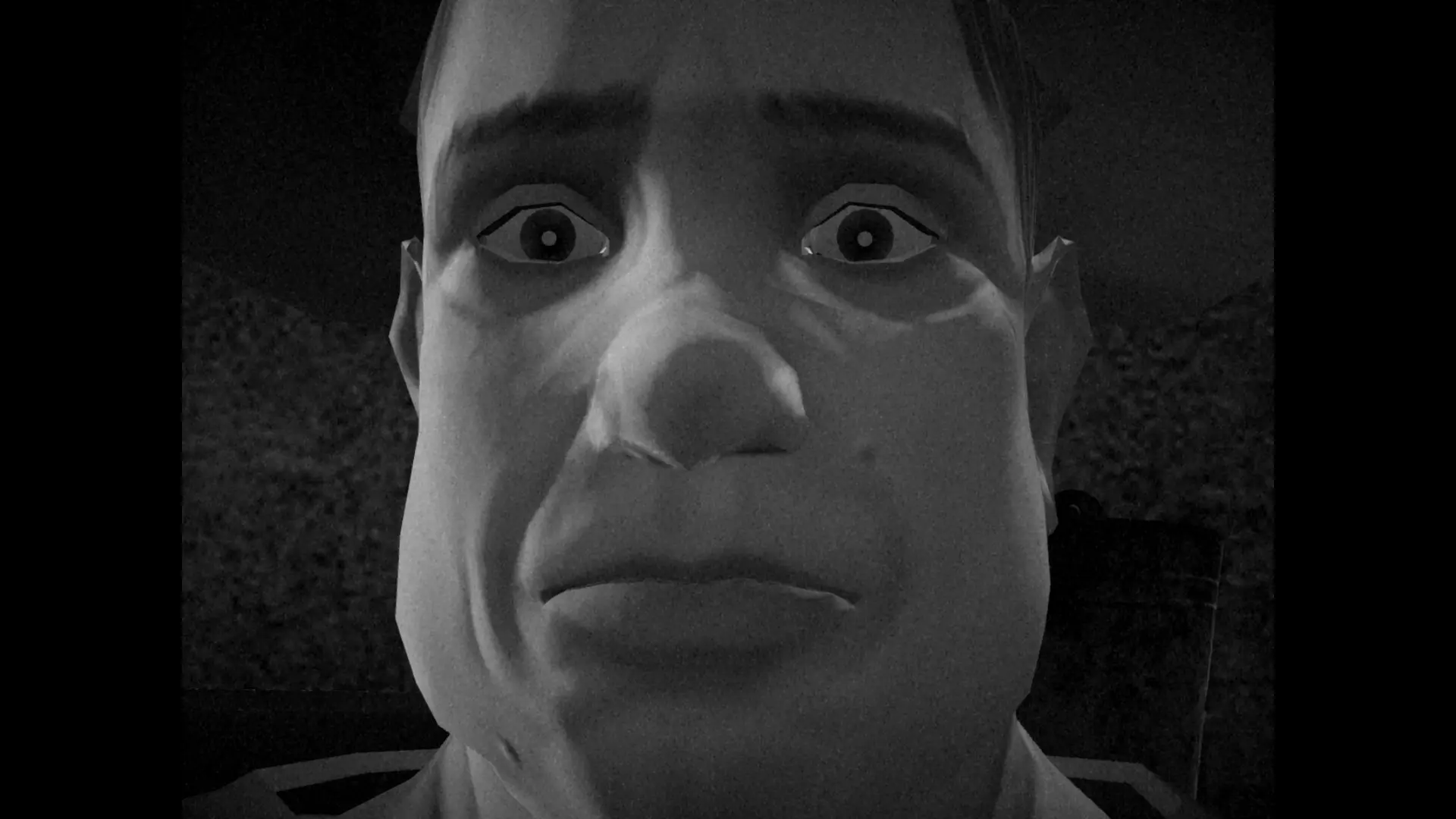






































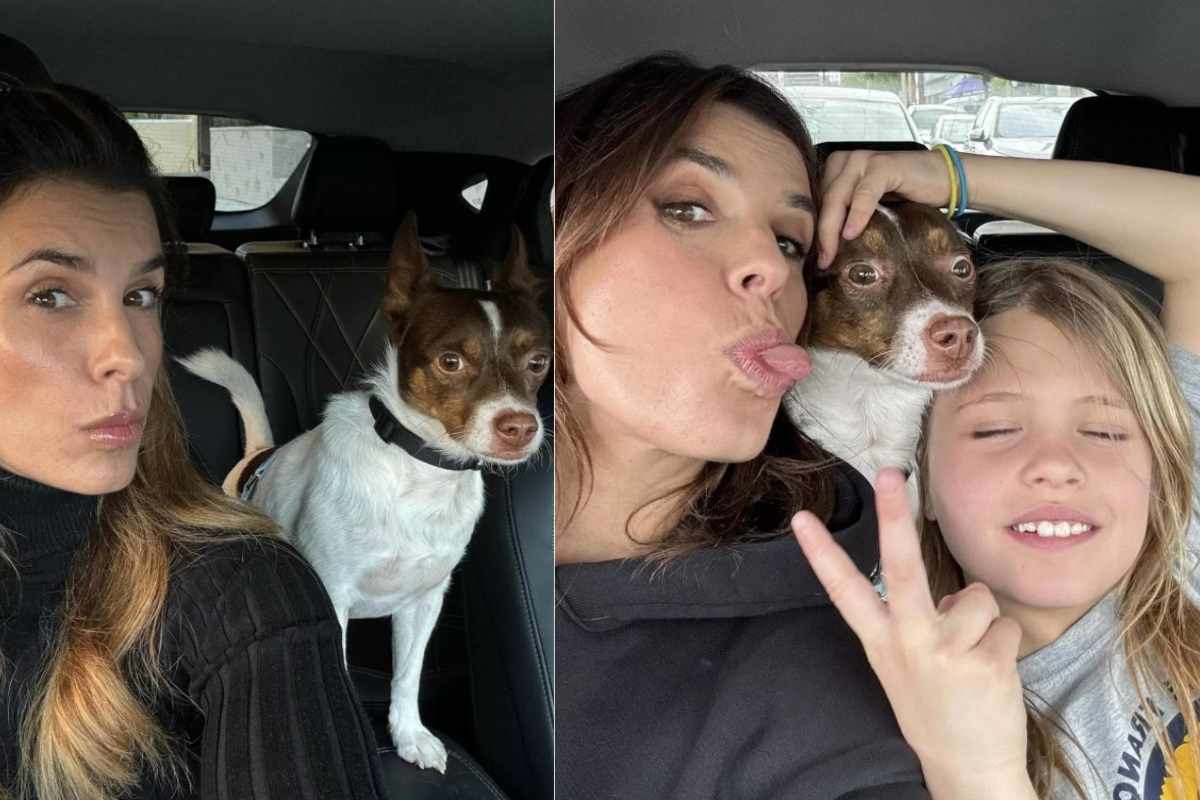













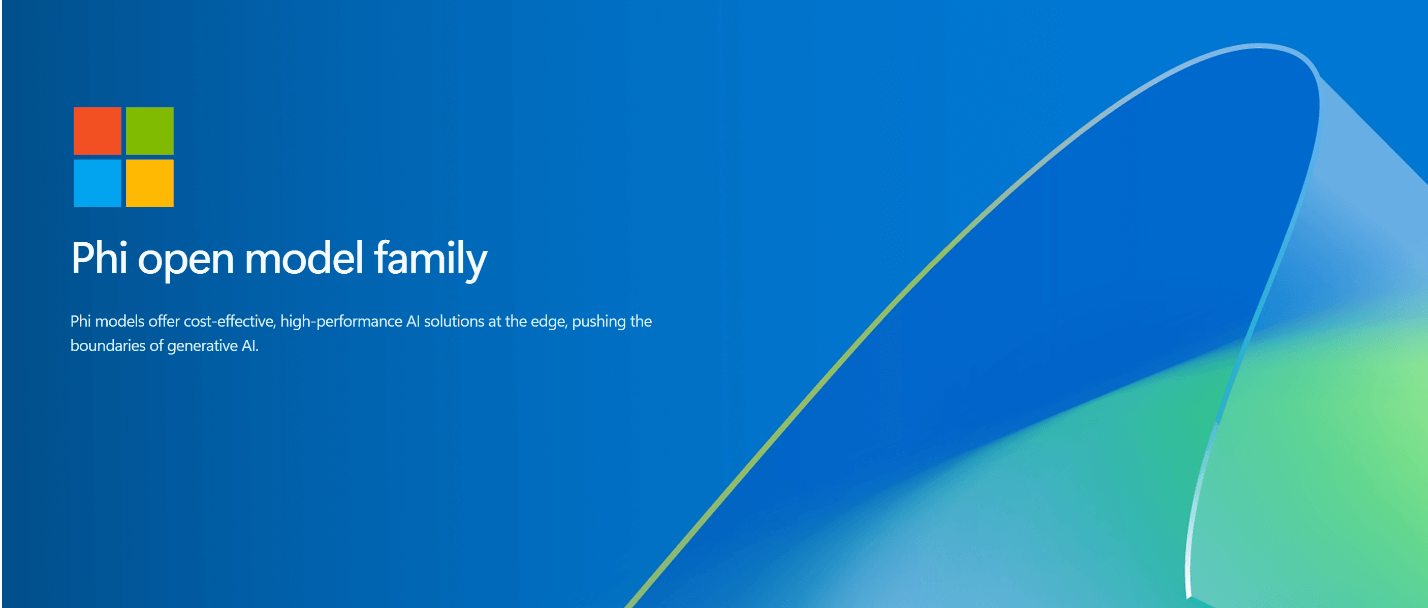


















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-assicura-2-percento-tua-liquidita-zero-spese-conto.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-con-cappello-in-strada.jpg)


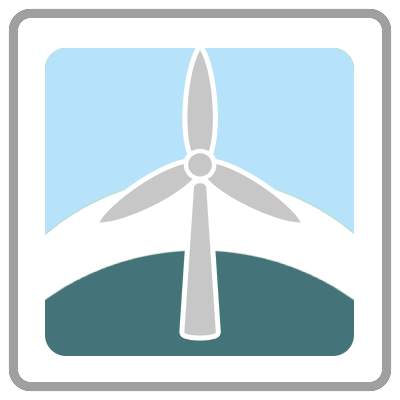
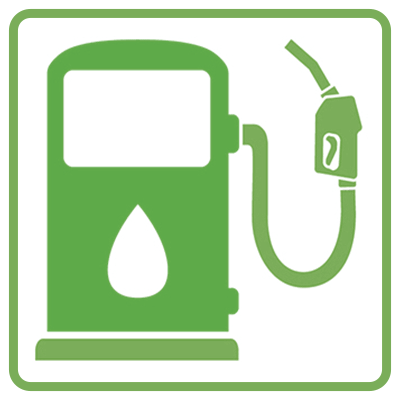
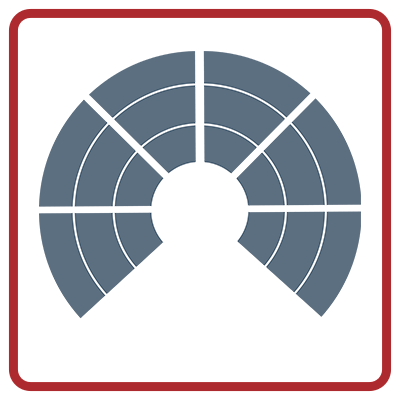























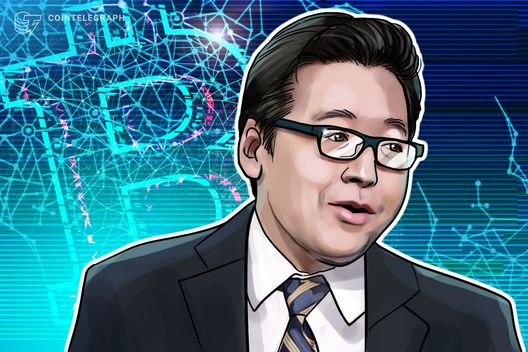








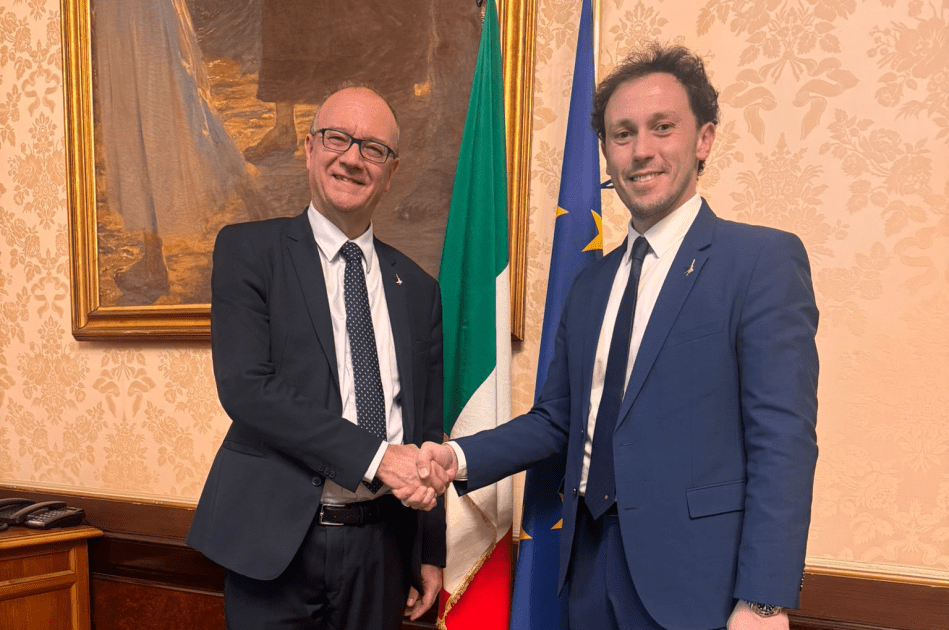


-1742815201071.jpg--ronde_e_video_contro_gli_stranieri__sequestrati_i_profili_social_di_un_uomo_di_torino.jpg?1742815201113#)








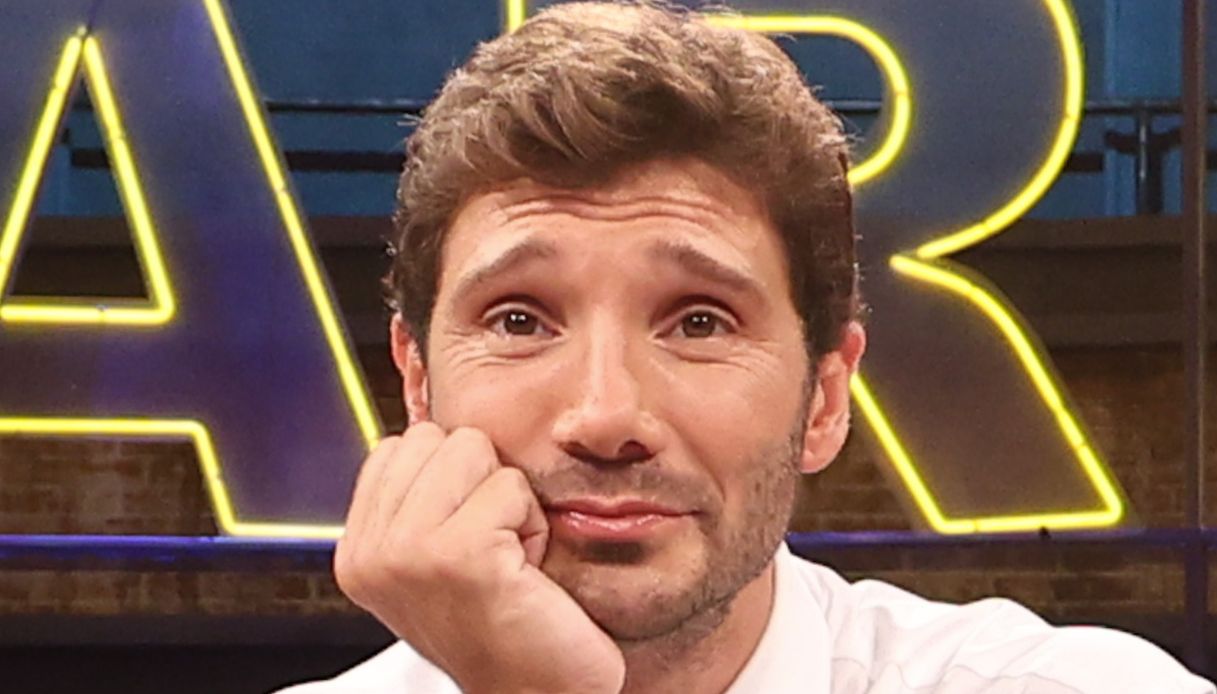




























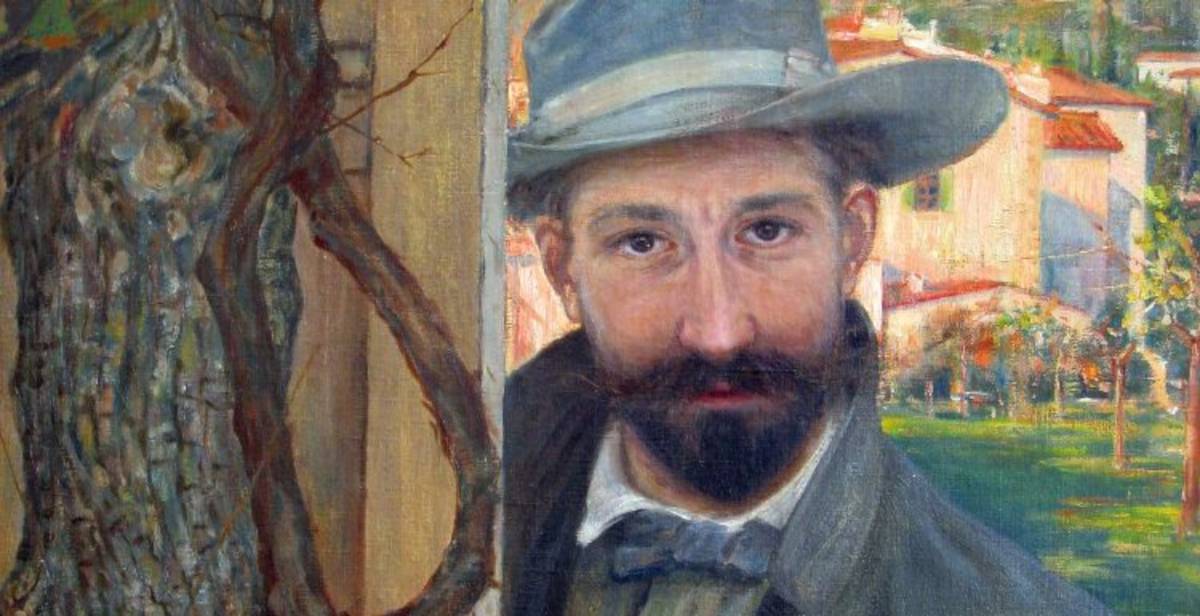
























-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)