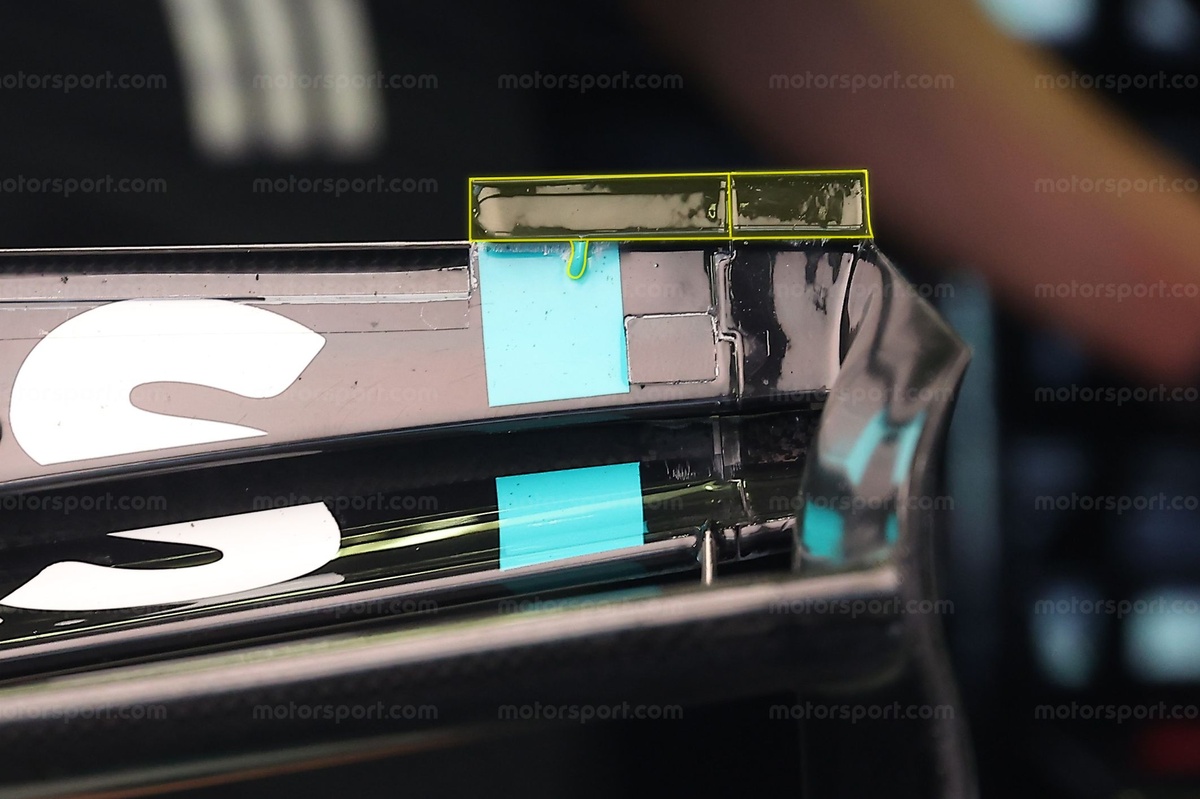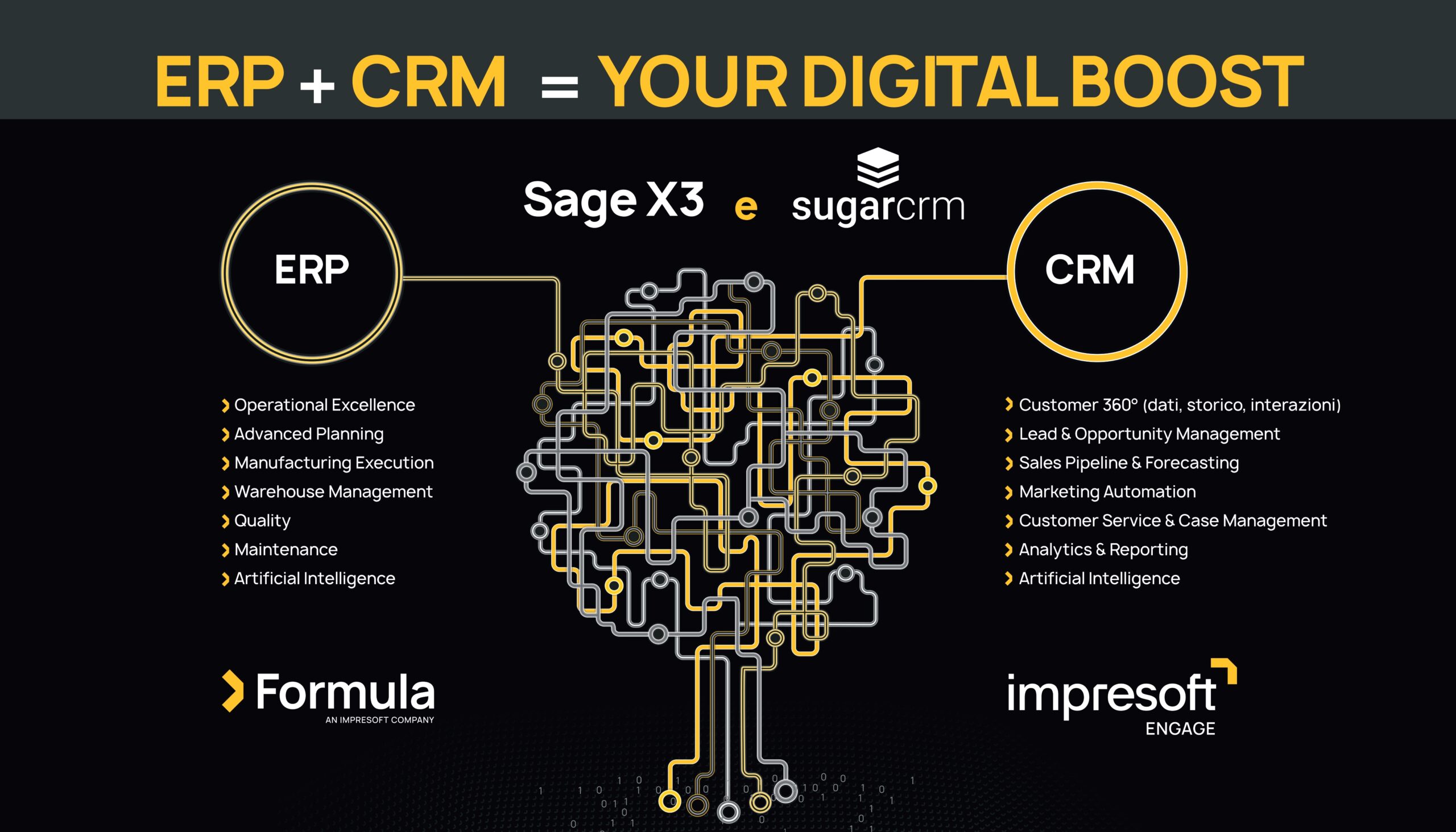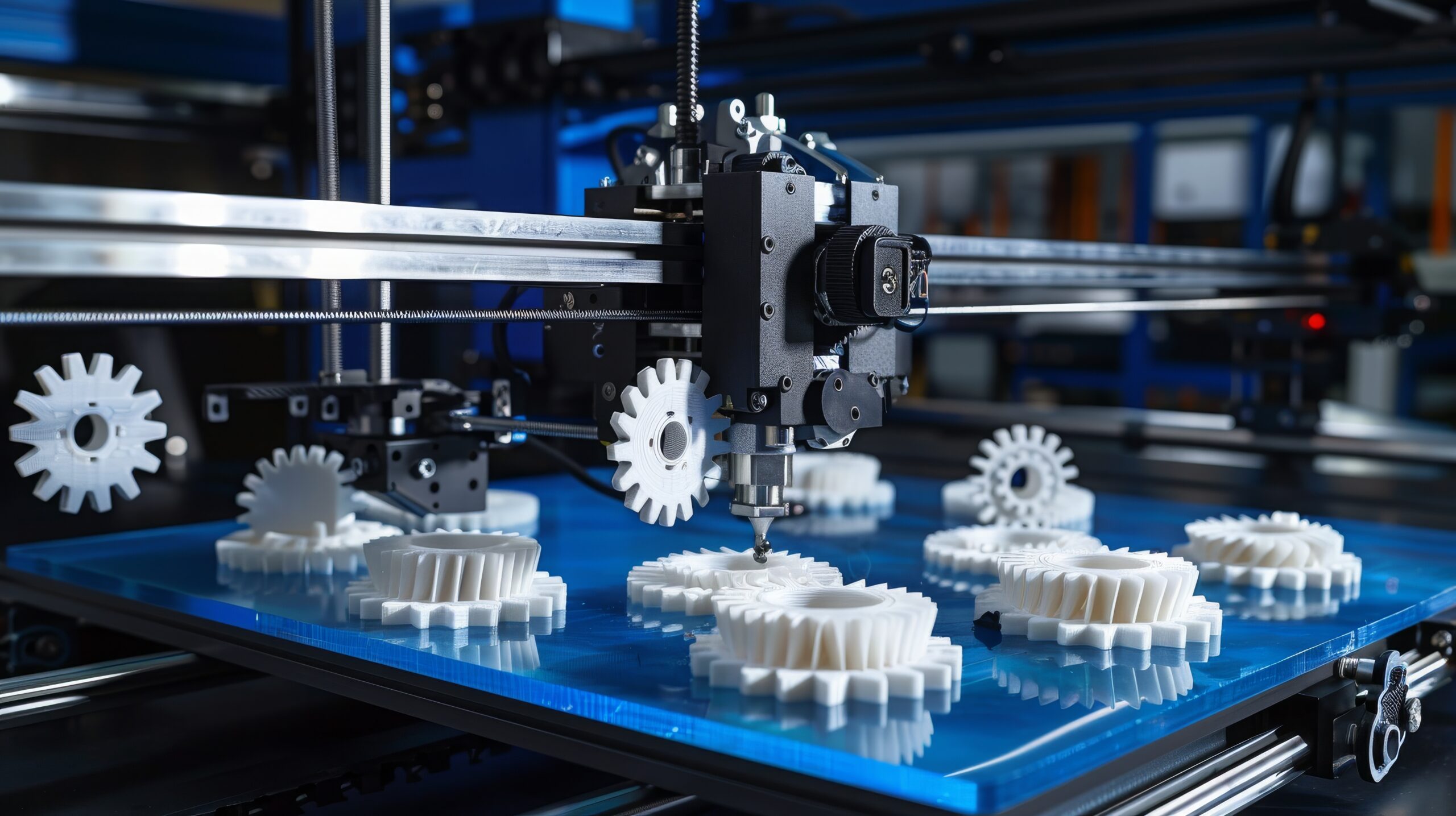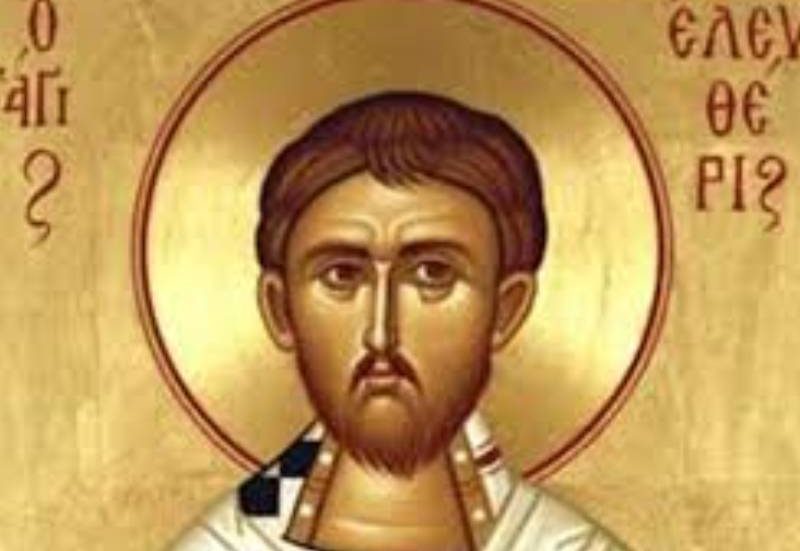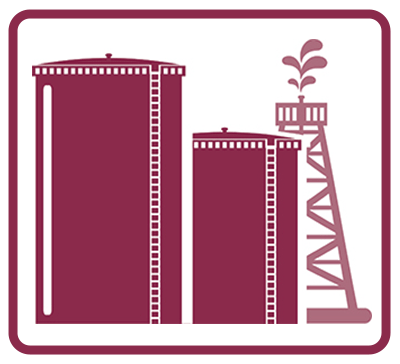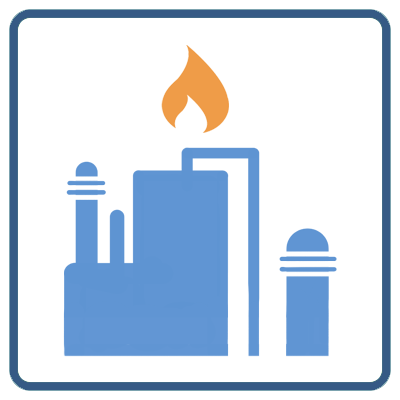La serie tv su Enzo Tortora ci interroga su un Paese che non impara dai suoi errori


Sono due i difetti di “Portobello”, la serie tv di Marco Bellocchio sulla vicenda dimenticata di Enzo Tortora. Il primo è che a Milano, negli Anni 80, i bidoni dei rifiuti neri “a tulipano” (che si vedono nel quinto episodio) ancora non c’erano. Il secondo è che potranno vederla solo gli abbonati di Hbo Max, il canale di streaming appena arrivato in Italia, con tutte le carte in regola: che peccato.
La serie di Bellocchio è splendida, ma anche un pugno nello stomaco, è intrattenimento ma anche ciò che il servizio pubblico dovrebbe fare e sempre meno fa. Infine, è recitata benissimo da un cast tutto italiano. Più volte nelle sei ore delle sei puntate disponibili dal 20 febbraio verrà spontanea (ne siamo convinti) una domanda. «Come è stato possibile?». È una di quelle vicende umane che solo la lente del tempo sa restituire nella loro essenza, storicizzate, ripulite dalle prese di posizione a prescindere.
Come è stato possibile il «più grave errore giudiziario della storia italiana del Novecento», frase che Bellocchio sceglie di far dire nell’immediatezza della condanna a Raffaele della Valle, l’allora avvocato di Tortora insieme ad Alberto Dall’Ora.
Bisogna calarsi nell’Italia del 1983 per provare a dare risposta: le lacerazioni lasciate dall’assassinio Moro, i colpi di coda del terrorismo, i primi scricchiolii della partitocrazia, le commistioni Stato-mafia (dall’omicidio Dalla Chiesa al rapimento Cirillo), gli appettiti scatenati dal post-terremoto dell’Irpinia che rompono gli equilibri all’interno della camorra, con la perdita di potere di Raffaele Cutolo da un anno in regime di isolamento all’Asinara.
In questo Paese frastornato, Enzo Tortora è all’apice del successo: Portobello, il suo programma, ha punte da 28 milioni di spettatori. Da anni ogni venerdì gli italiani aspettano il momento fatidico in cui l’ospite della puntata proverà a far parlare il pappagallo, ma Portobello non è solo questo e Tortora non è il classico divo della tv. È un uomo colto, raffinato, all’apparenza distaccato eppure popolare, che porta in scena un’Italia reale, a volte semplice a volte bizzarra. Si dice spesso che molti dei format di successo da lì a venire abbiano saccheggiato le tante rubriche di cui “Portobello” era fatto, da “Chi l’ha visto?” a “Uomini e donne”, da “C’è posta per te” a “Carràmba!”. Non è del tutto vero, l’Italia di “Portobello” non aveva ancora perso l’innocenza.
Eppure, la tragica vicenda di Tortora si compie senza che il dubbio si insinui nell’opinione pubblica. Una tragedia, sì, dal suo significato originario: “canto del capro”. Un sacrificio rituale. Viene arrestato il 13 giugno 1983, prelevato dalla sua stanza d’albergo a Roma con l’accusa di appartenere alla camorra e di essere un trafficante di droga.
A incastrarlo è Giovanni Pandico (grandiosa l’interpretazione di Lino Musella), un cutoliano pentito – anzi, un dissociato, come si facevano chiamare – che per sottrarsi alla guerra tra clan decide di collaborare e fa il nome del presentatore. Bellocchio spiega che è proprio l’immagine di un Enzo Tortora stravolto e stupito che esce in manette per essere tradotto a Regina Coeli, accolto da una schiera di fotografi, telecamere, cronisti, con tutta evidenza avvertiti in anticipo, ad averlo ispirato e convinto a raccontare questa storia.
Deve esserci, però, anche la volontà di continuare a indagare sul tradimento, sull’abbandono, sulla caduta e sulle ferite ancora aperte della storia nazionale, se è vero che “Portobello” arriva dopo “Esterno Notte”, dedicata al rapimento Moro e inserita dal New York Times tra le dieci migliori serie del 2025. A interpretare Tortora è Fabrizio Gifuni, che era stato anche Aldo Moro: lo fa senza eccedere nel caricaturale, restituendo la giusta sofferenza a un uomo travolto da accuse assurde a cui prova a rispondere con la forza della ragione, ma anche con voce rotta dall’indignazione. Al teatro televisivo, così, si sostituisce il teatro del processo (l’aula di giustizia), con la discesa agli inferi di Tortora e l’entrata in scena di una combriccola di matti.
Non solo Pandico detto appunto ‘o pazzo, un psicopatico e schizzofrenico certificato, al quale magistrati e giudici decidono di credere al di là ogni ragionevole dubbio, perché ammettere l’innocenza vorrebbe dire cancellare l’intera inchiesta, accettare di avere torto, come confessa a un certo punto Diego Marmo, il pm che sostenne l’accusa con durezza (interpretato da un Fausto Russo Alesi in stato di grazia), definendo Tortora «un cinico mercante di morte». Sono undici i pentiti che accusano Tortora: c’è il pittore mitomane Giuseppe Margutti, c’è il killer Pasquale Barra detto ‘o animale, esecutore materiale di 67 omicidi, c’è il millantatore Gianni Melluso che si spaccia per grande criminale e che finisce sui rotocalchi come una star, con il suo matrimonio celebrato in cella a processo in corso.
Enzo Tortora viene condannato a dieci anni di carcere il 17 settembre 1985, solo il lavoro certosino dei giudici di secondo grado guidati da Michele Morello porterà all’assoluzione con formula piena un anno dopo. Tortora tornerà in tv proprio il 20 febbraio di 39 anni fa (con la famosa frase «Dunque, dove eravamo rimasti») e morirà 15 mesi dopo a soli 59 anni.

“Portobello” non è un legal thriller e neppure un crime, a un certo punto prende l’andamento di “Un giorno in pretura” per quanto restituisce di realistico ed è di certo una seduta di gruppo sulle rimozioni di un Paese che non impara dai propri errori. «Tortora era antipatico a una potente classe intellettuale – prova a dare una spiegazione lo stesso Bellocchio nelle note di regia – che vedeva con disprezzo e grande invidia questa sua enorme popolarità, di un liberale che non veniva dal popolo e che era un borghese molto presuntuoso. Il fatto poi che non avesse padrini, non era protetto né dalla Dc né dal Pci, le due grandi chiese di allora, non appartenesse a logge massoniche, era laico e perciò anche la Chiesa diffidava di lui, insomma non godeva di nessuna protezione, lo danneggiò. Lo condannò».
Certo, ma la domanda resta: come è stato possibile? Opinione pubblica, giudici, stampa, tutti disposti a credere alle testimonianze di un gruppo di delinquenti di lungo corso, senza un riscontro fattuale, con la sola isolata battaglia di Marco Pannella (Tortora fu europarlamentare e anche presidente del Partito radicale) e le quotidiane cronache dal processo di Radio Radicale.
Data la concomitanza con i referendum sulla separazione delle carriere, non è difficile prevedere che la serie tv finirà per essere vittima della battaglia politica. Regista, attori, Hbo Max, mettono già le mani avanti («nessun endorsement, solo coincidenza»), ma non sarà facile sottrarsi: i sostenitori del Sì potranno calcare la mano sulla cecità e l’impunità di quei magistrati, quelli del No far notare che furono altri giudici dello stesso tribunale (senza carriere separate), con le stesse frequentazioni, a smontare le accuse e provare l’innocenza. Senza dimenticare che il processo penale da allora è molto cambiato, già passato attraverso due riforme (Vassalli e Cartabia).
Resta a Gifuni e a Paolo Pierobon (Dall’Orta nella serie) suggerire una soluzione, seppure nella finzione cinematografica. «Mi raccomando, l’amor proprio dei giudici è sconfinato» dice quest’ultimo a Tortora-Gifuni, che sul finire s’interroga: «E non può un giudice sbagliare e poi ammetterlo?». Non saranno una serie tv e neppure un referendum a porre rimedio alle umane incompletezze.
L'articolo La serie tv su Enzo Tortora ci interroga su un Paese che non impara dai suoi errori proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0