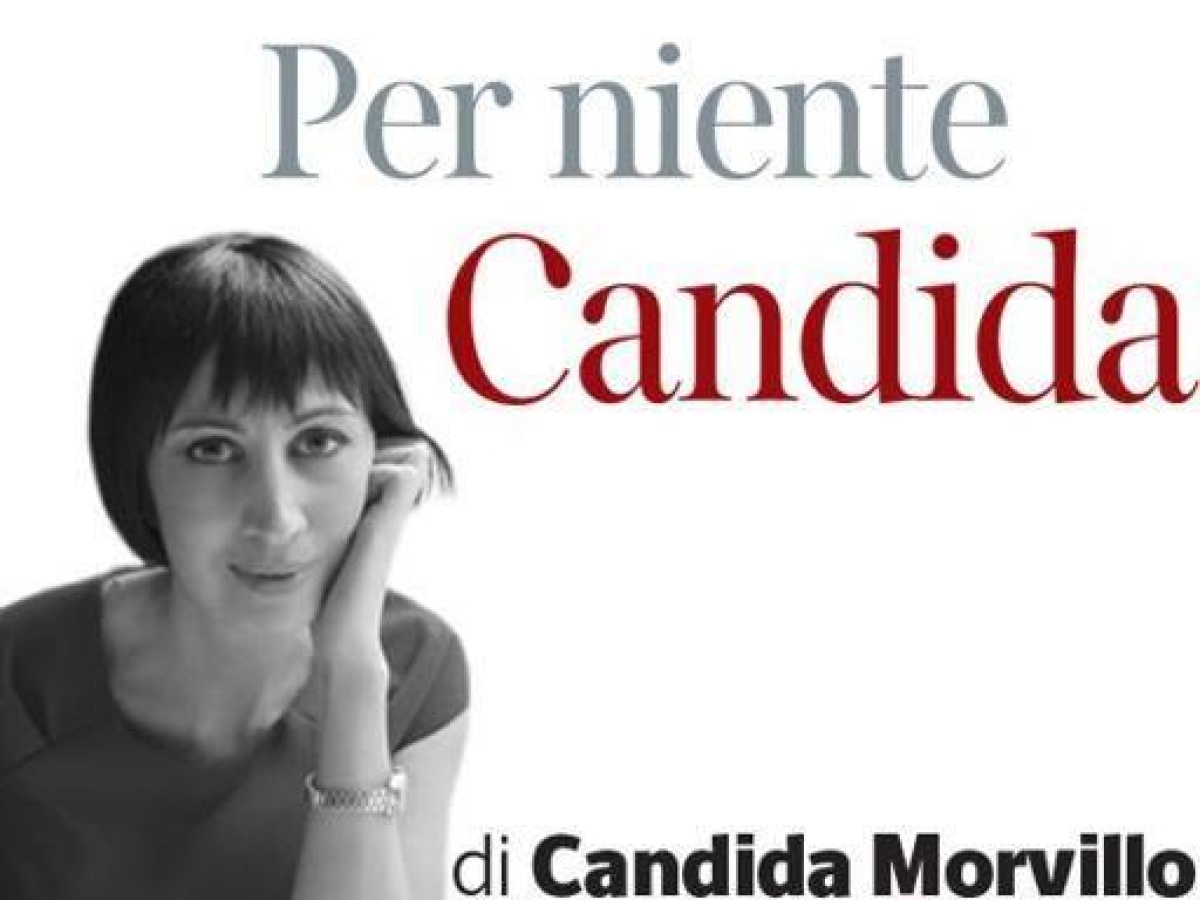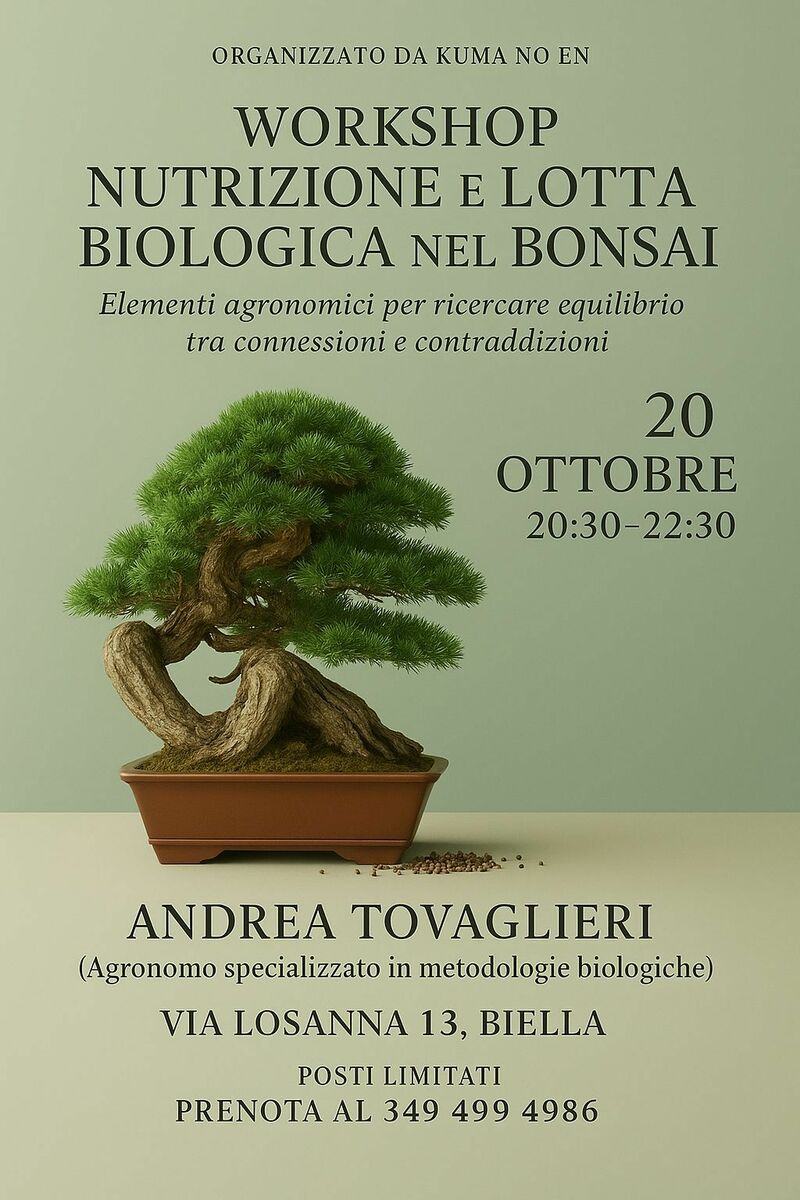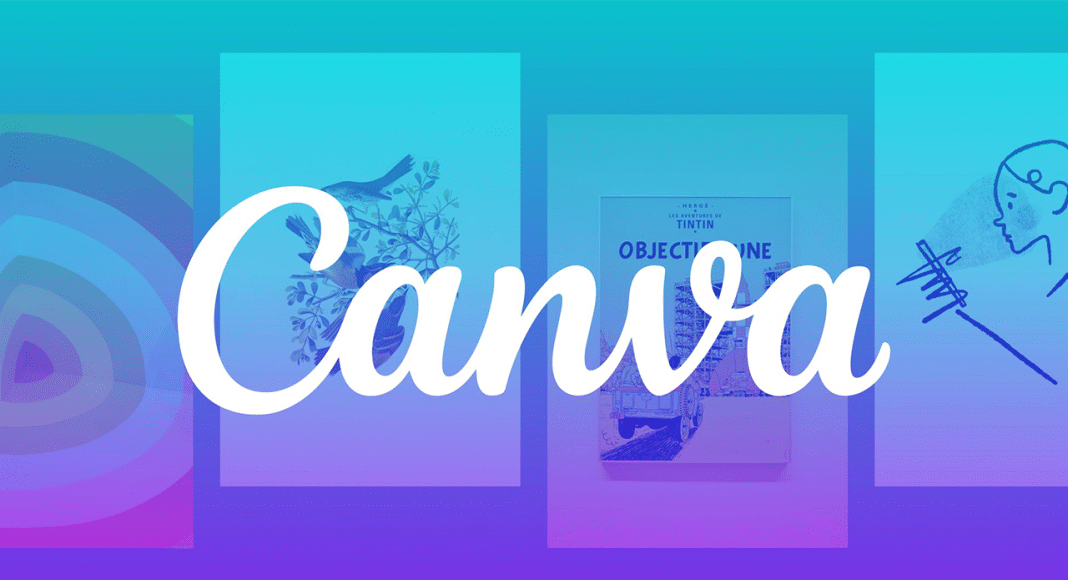Il vero significato di “cortigiana”, e l’uso strumentale che ne fa Meloni


I teologi bizantini, con il Turco alle porte di Costantinopoli, discutevano sul sesso degli angeli; qui da noi, con il mondo in fiamme, la democrazia a rischio, l’economia in crisi, ci si accalora sul significato di “cortigiana” (in un certo senso, sempre di sesso di tratta). La cortigiana sarebbe una prostituta, come, «dopo una rapida ricerca su Internet», ha voluto intendere Giorgia Meloni per replicare al segretario della Cgil Maurizio Landini che in televisione a DiMartedì le aveva rimproverato di non avere mosso un dito sulla tragedia di Gaza, limitandosi a fare «la cortigiana di Trump».
Non intendiamo entrare nel merito politico dell’accusa mossa alla premier, non è questo il problema; il problema è squisitamente linguistico e investe la consumata abilità di Giorgia Meloni nello strumentalizzare le parole piegandole a vantaggio della propria onnipervasiva propaganda. Nel trappolone sono caduti un po’ tutti, rimescolando gli schieramenti: progressisti e femministe, che su Gaza condividono la posizioni di Landini, in nome del politically correct e dell’antisessismo prendono le distanze dal loro sindacalista; politici e opinionisti dello schieramento opposto, che al politically correct sono sempre stati poco sensibili, improvvisamente se ne fanno paladini; e c’è pure qualche inossidabile fautore di questi stessi princìpi che, in nome della solidarietà con il compagno Landini, è disposto a metterli per un attimo tra parentesi.
Un bel cortocircuito. Eppure basterebbe conoscere la distinzione tra valore denotativo e valore connotativo di una parola. O, ancora più semplicemente, anziché ricercare rapidamente in rete basterebbe considerare il dizionario. Tutti i vocabolari, come primo significato del sostantivo “cortigiano”, danno la definizione “uomo di corte”, e come secondo significato (esteso) “adulatore, piaggiatore”: il primo ha valore denotativo, il secondo è connotativo. Nel caso della forma femminile, una connotazione ulteriormente spregiativa è però andata delineandosi fin da tempi molto lontani: il Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia riporta tra gli esempi più antichi un passo dell’ecclesiastico e novelliere cinquecentesco Matteo Bandello («Ella era molto bella e giovane. Il perché, essendo in abito di cortegiana ed usando atti di putta, cominciò a servire quelli che erano in nave, […] di quelli servigi che communemente gli uomini da le donne ricercano»).
In quest’ultimo caso il senso è chiaro, ed è anche stato consacrato in un titolo celebre, “Splendori e miserie delle cortigiane” di Honoré de Balzac. Ma un’accezione secondaria è tale da cancellare quella primaria? Di più, è tale da farla incorrere nell’interdetto? E se si vuole designare una persona di genere femminile che sta a corte in mezzo a cortigiani maschi, e magari come loro indulge a comportamenti servili e adulatori nei confronti del sovrano, come diavolo toccherà chiamarla?
Continuando a tenere aperto il dizionario, si può osservare che tutti i dizionari registrano aggettivi e sostantivi nella forma maschile (una bieca prevaricazione maschilista, a cui soltanto il vocabolario Treccani aveva provato a opporsi, qualche anno fa, nell’era pre-trumpiana del MeToo arrembante, lemmatizzando la forma femminile – tentativo subito rientrato, perché la preferenza accordata al maschile è in realtà spiegabile con la circostanza che gran parte dei nomi designano attività in origine di competenza maschile, e non tutti al femminile si formano sostituendo semplicemente la desinenza “o” con la “a”). Degli aggettivi e dei nomi comuni, di norma, la forma femminile è indicata tra parentesi: per esempio, per cuoco (-a), elettore (-trice), principe (-essa) e così via.
Quando invece a un sostantivo è riservata una voce a sé stante, come nel caso di “cortigiana”, questo suggerisce che la parola in questione è l’esito di una storia lessicale differente, di fatto è un’altra parola. Che convive con la sua gemella eterozigote, non la fagocita ma vi si sovrappone ingenerando anche, magari, un potenziale fraintendimento. Il senso che le va riconosciuto dipende quindi (ed è in genere agevolmente ricavabile) dal contesto: chi sta parlando, dove e quando sta parlando, di chi e di che cosa sta parlando. Nel caso di Landini – che a buon diritto lo ha rivendicato, rifiutando di scusarsi per un’offesa che non aveva arrecato – il senso era inequivocabile.
Ma invece di guardare al contesto, invece di considerare il vocabolario, molti hanno preferito rivolgersi all’auctoritas linguistica di Paola Cortellesi. È stato rispolverato, e imperversa in questi giorni sui social come pietra tombale sull’argomento (e sull’incauto sindacalista), un vecchio monologo in cui l’attrice, alla cerimonia del premio David di Donatello del 2008, gioca con alcuni termini della lingua italiana che al maschile hanno il loro “legittimo” significato, mentre al femminile ne assumono uno diverso e sistematicamente offensivo per le donne. Il primo è proprio cortigiano, cioè «un uomo che vive a corte». Ma una cortigiana? «Una mignotta», ammicca l’attrice. Che prosegue. «Un massaggiatore: un chinesiterapista. Una massaggiatrice? Una mignotta. Un uomo di strada: un uomo del popolo. Una donna di strada? Una mignotta. Un uomo disponibile: un uomo premuroso. Una donna disponibile? Una mignotta. Un passeggiatore: un uomo che cammina. Una passeggiatrice? Una mignotta. Un uomo allegro: un buontempone. Una donna allegra? Una mignotta. Un uomo di mondo: un gran signore. Una donna di mondo? Una gran mignotta…».
Divertente. Paola Cortellesi è brava e simpatica e sa fare bene il suo mestiere di attrice brillante (in questo caso, attingendo a un elenco stilato da un funambolo delle parole quale Stefano Bartezzaghi). Però non ha né vuole avere la pretesa di fissare le regole della lingua, e del resto alcuni degli incidenti semantici che cita sono un po’ forzati: per esempio, la parola “passeggiatrice” si usa e ha un significato consolidatamente univoco, ma “passeggiatore” quante volte l’avrete sentito? E “uomo di strada”? Certo, ci sono le “donne di strada”, con quel senso lì, come ci sono i “ragazzi di strada” e i pasoliniani “ragazzi di vita”, ma “uomo di strada” non risulta, con il senso di “uomo del popolo” si dice piuttosto “uomo della strada”.
E infine, per dirla tutta, quante volte negli ultimi tempi abbiamo sentito usare qualcuno dei sinomini/perifrasi/eufemismi cortellesiani per evocare il “mestiere più antico del mondo”, se non con trasparente intenzione ironica verso il luogo comune (come nella locuzione messa qui tra virgolette)? Dagli Appennini agli Appalachi, viviamo in un universo comunicativo trucibaldo che ha sdoganato senza ritegno gli epiteti più volgari e ingiuriosi: crediamo seriamente che, se uno volesse dare della prostituta a una donna, andrebbe a riesumare una parola dal suono letterario e ormai obsoleta? Personalmente (magari mi sbaglio) l’ultima occorrenza che ricordo, in questo senso, è in una canzone di Fabrizio De Andrè: «A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti…». Si intitola “Il testamento”, è del 1966.
L'articolo Il vero significato di “cortigiana”, e l’uso strumentale che ne fa Meloni proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































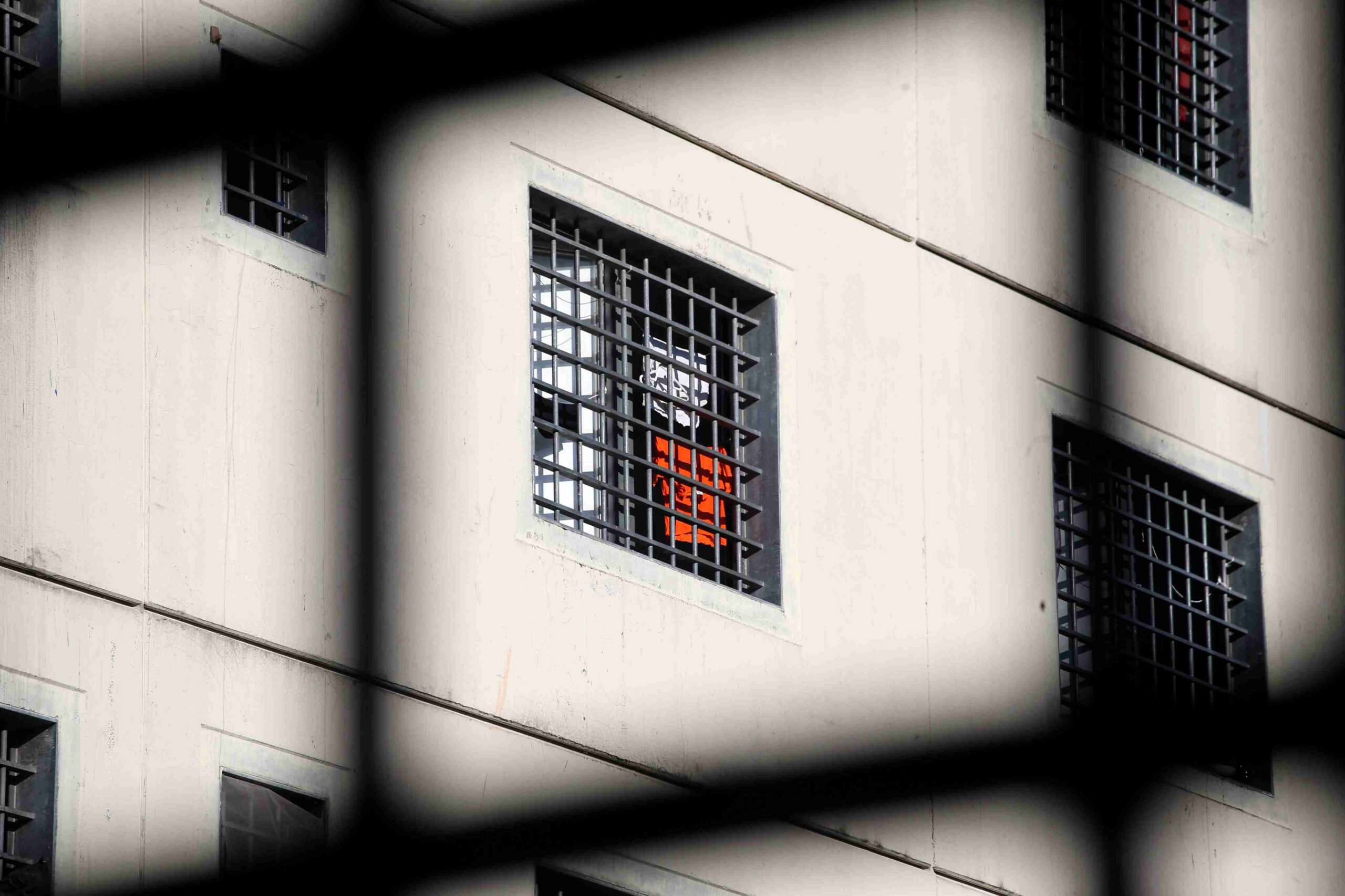





































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184282.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184289.jpg)
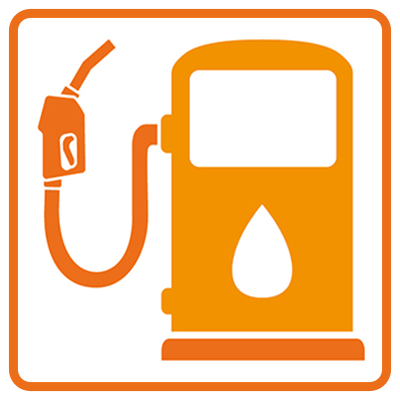










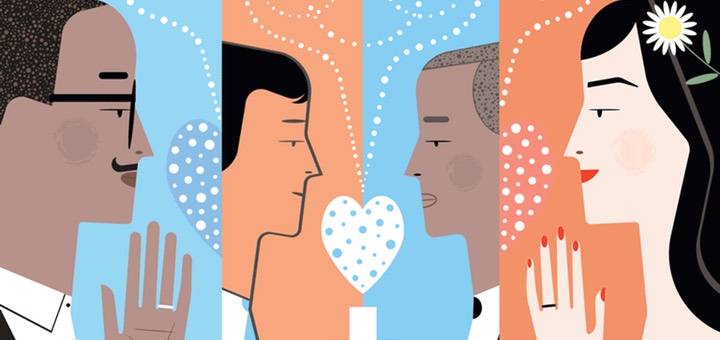




































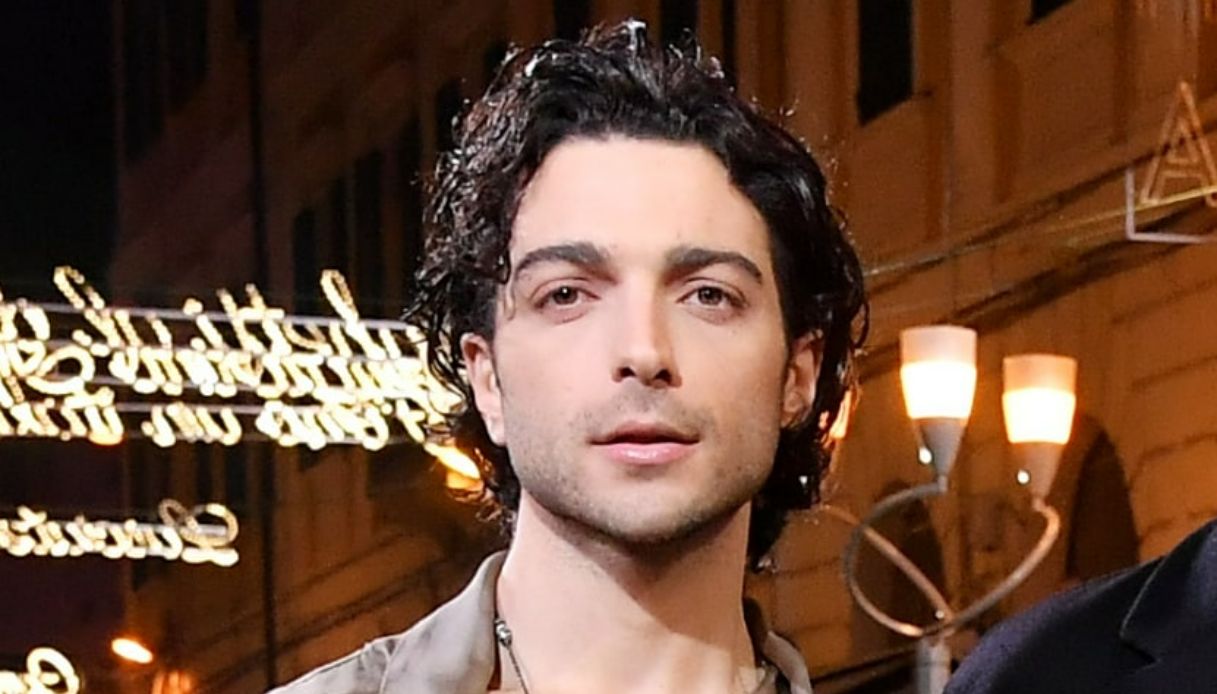





















































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)