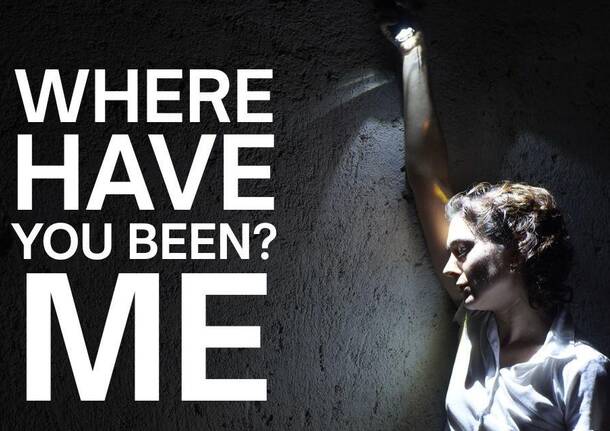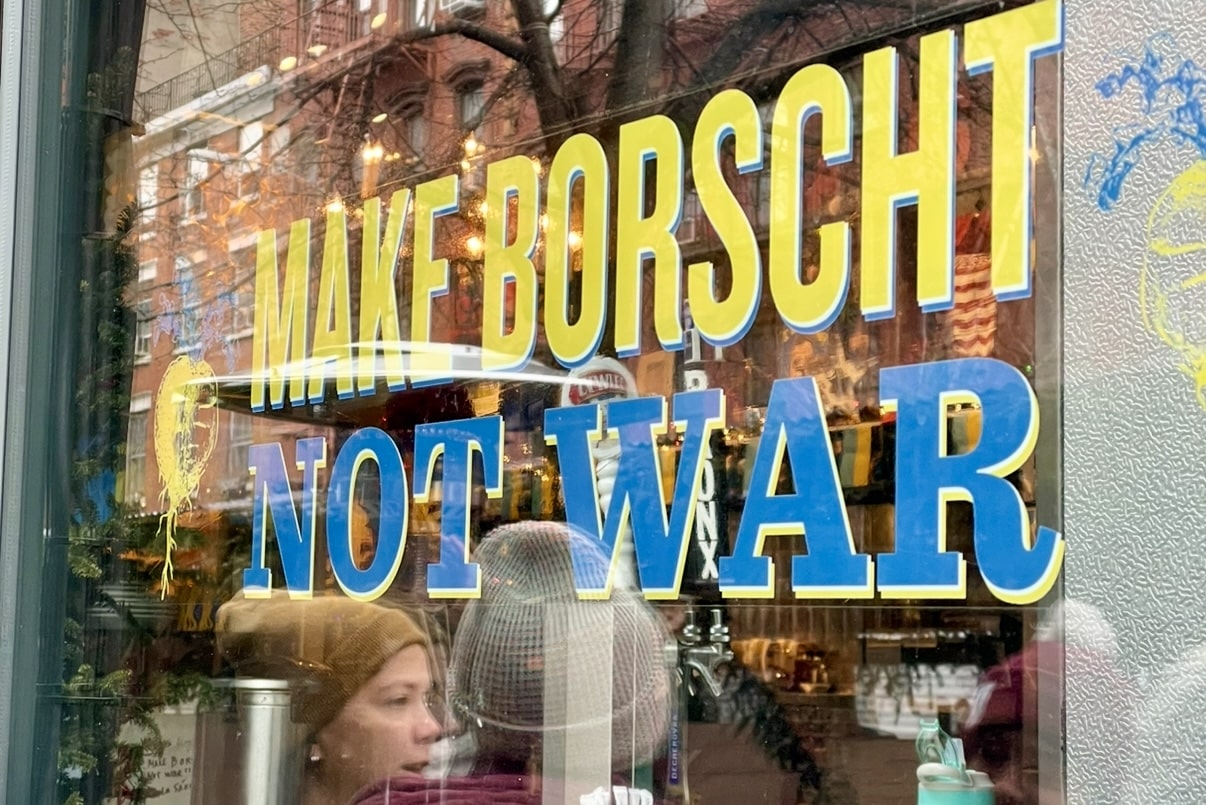La cooperazione multilaterale sul clima sta bene, le Cop un po’ meno


La fotografia perfetta della Cop30 sul clima è Sergei Kononuchenko, tra i delegati di punta della Russia, che accusa la Colombia di comportarsi come un bambino «che vuole mettere le mani su tutti i dolci, ingozzandosi fino alla nausea». Un grave atto di prepotenza, sostenuto esplicitamente o implicitamente dall’intero blocco dei Paesi Brics (tolto il Brasile), che riflette il potere delle economie fossili e le difficoltà di ribaltare uno status quo ancora solidissimo, nonostante la crescita delle energie rinnovabili e di tutte le cleantech per la decarbonizzazione del nostro sistema produttivo.
L’attacco della Russia ha scavalcato le ambizioni e l’autorevolezza dei padroni di casa brasiliani, contribuendo ad affondare ogni speranza di approvare una roadmap per l’abbandono delle fonti fossili. Tra i principali sostenitori della proposta c’era proprio la Colombia, che nel frattempo si è accordata con i Paesi Bassi per organizzare la prima Conferenza internazionale sulla giusta transizione dai combustibili fossili (Santa Marta, 28-29 aprile 2026): la cooperazione multilaterale sul clima è viva e lotta in mezzo a noi, ma dovrà farlo lontano dai polverosi contesti diplomatici delle Cop.
Appoggiata da più di ottanta Paesi, Italia esclusa, la roadmap per l’uscita dalle fonti fossili avrebbe rappresentato l’iniezione di fiducia ideale per rilanciare un vertice immerso in una grave crisi di identità, di credibilità, di concretezza, di proattività. Il cambiamento climatico, complice il contesto geopolitico, è scivolato in fondo all’agenda di governi e media: il modo migliore per (provare a) invertire la tendenza sarebbe stato chiudere il negoziato con nuovi obiettivi concreti, basati su numeri e date, facili da ricordare, da comunicare e da stampare nell’immaginario collettivo. Poco importa la natura non vincolante degli accordi: le Cop non devono salvare il mondo da sole, ma tracciare la via politica, diplomatica e culturale per il cambiamento.
Ondivaga è l’aggettivo ideale per descrivere la Cop30 terminata sabato 22 novembre ai tempi supplementari. All’inizio ha dominato il pragmatismo: la Cop della verità, la Cop dell’attuazione, quella che dovrà mettere nero su bianco tante promesse vuote fatte negli anni passati. Poi è subentrata la rassegnazione: la mitigazione ai margini del dibattito, gli indicatori del Global goal on adaptation al centro della scena. Martedì scorso è arrivata la scarica di adrenalina dovuta alla nascita della coalizione a sostegno della roadmap per l’uscita dai combustibili fossili. Il tema della riduzione delle emissioni, un po’ a sorpresa, è stato scongelato dalla panchina e messo in campo nel momento chiave della partita. Infine, come spesso accade, ecco l’amaro in bocca; il mantra del “no deal is better than a bad deal”, l’Unione europea che prova a rimettere insieme i cocci e il deprimente testo finale.
Il paradosso è evidente e controintuitivo: il documento principale dell’evento sul clima più rilevante dell’anno (al suo trentesimo anniversario, alle porte dell’Amazzonia brasiliana) non ha menzionato la prima causa del problema alla base dell’evento stesso, ossia i combustibili fossili. Il compromesso risiede nel passaggio in cui si ribadisce – anche attraverso uno strumento chiamato Belém mission to 1.5 – l’importanza di allineare i Paesi all’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050 e di riportare l’aumento della temperatura media globale entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
È una soglia ormai impossibile da rispettare: entro fine secolo, con gli attuali piani climatici, rischiamo di superare i 3°C di riscaldamento globale. L’unica speranza, come si legge nell’ultimo World energy outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), è rientrare nel grado e mezzo dopo aver superato la linea rossa, ma non possiamo più permetterci di perdere tempo. Dalla Cop30 è quindi emerso un messaggio politico di sostegno all’accordo di Parigi, ancora vivo ma sempre più fragile.
Alcune letture vedono nel testo finale della Cop30 un segnale di continuità rispetto alla Cop28 di Dubai (2023), terminata con la dicitura del «transitioning away from fossil fuel», che indica un progressivo allontanamento. Due anni fa, l’obiettivo era inserire nel documento il termine «phase-out», ossia un abbandono graduale del gas, del petrolio e del carbone. Il «transitioning away» era stato accolto con delusione e scetticismo, sia dalla società civile che dalla stampa. Ma a Dubai eravamo felici senza saperlo, perché il testo della Cop28 si era almeno degnato di citarli esplicitamente, i combustibili fossili.
Il passo indietro di Belém è un sintomo di preoccupante debolezza diplomatica da parte del Brasile, che non è riuscito a reggere le pressioni della Russia, dell’Arabia Saudita e della Cina. Dalla decisione di triplicare i finanziamenti per l’adattamento climatico al meccanismo per la transizione giusta: non è tutto da buttare, ma è un risultato troppo vago e debole, non in linea con la gravità di un’emergenza pervasiva e priva di margini di miglioramento. Là fuori il mondo soffoca, brucia e annaspa, mentre alla Cop30 ci si abbraccia per un accordo che parla di un problema ignorandone le cause.
È stata la conferenza sul clima con il più alto tasso di partecipazione delle comunità indigene, ma il numero dei lobbisti dell’industria fossile (1.602, +12 per cento rispetto alla Cop29) ha ancora una volta superato quello dei delegati dei Paesi più esposti alla crisi del clima: un assordante rumore di fondo che, di fatto, ha appiattito gli effetti delle proteste della società civile, esclusa dalle ultime tre edizioni in Egitto, Emirati Arabi e Azerbaigian.
«Non sto dicendo che stiamo vincendo la partita del clima, ma siamo ancora in gioco e stiamo combattendo», ha detto Simon Stiell, capo della Convenzione quadro dell’Onu sul cambiamento climatico (Unfccc), cercando di essere forzatamente ottimista. «Qui a Belém – prosegue – le Nazioni hanno scelto l’unità, la scienza e il buon senso economico. Quest’anno si è parlato molto del passo indietro di un Paese (gli Stati Uniti, ndr). Nonostante i venti contrari, centonovantaquattro Paesi hanno creduto nella solidarietà, solidi come una roccia a sostegno della cooperazione sul clima». Il “nonostante Trump”, però, non è una scusa che giustifica l’assenza delle fonti fossili dal testo della Cop30.
La posizione di Stiell è comprensibile, ma scollata dalla realtà. Le Cop non servono solamente a negoziare, ma anche a catalizzare l’attenzione su un problema che sta moltiplicando le disuguaglianze e le minacce del presente. Il vertice dell’Onu di Belém ha perso l’ennesima occasione di innovarsi in modo significativo (nessuno ha più parlato della riforma del processo delle Cop), senza fornire le risorse e le speranze sufficienti a coloro che sono in prima linea nella lotta alla crisi climatica: i Paesi in via di sviluppo e i contesti locali.
L'articolo La cooperazione multilaterale sul clima sta bene, le Cop un po’ meno proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

























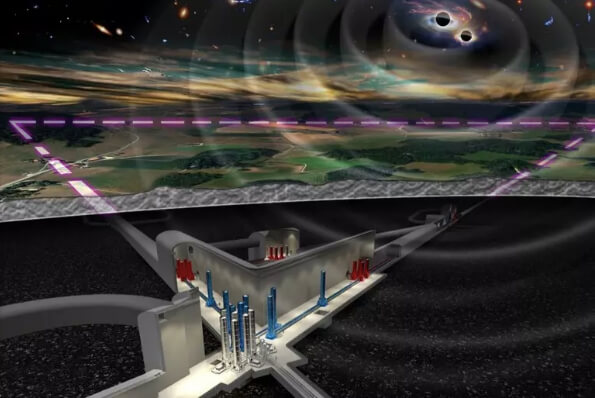































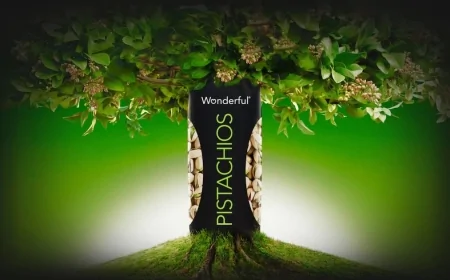










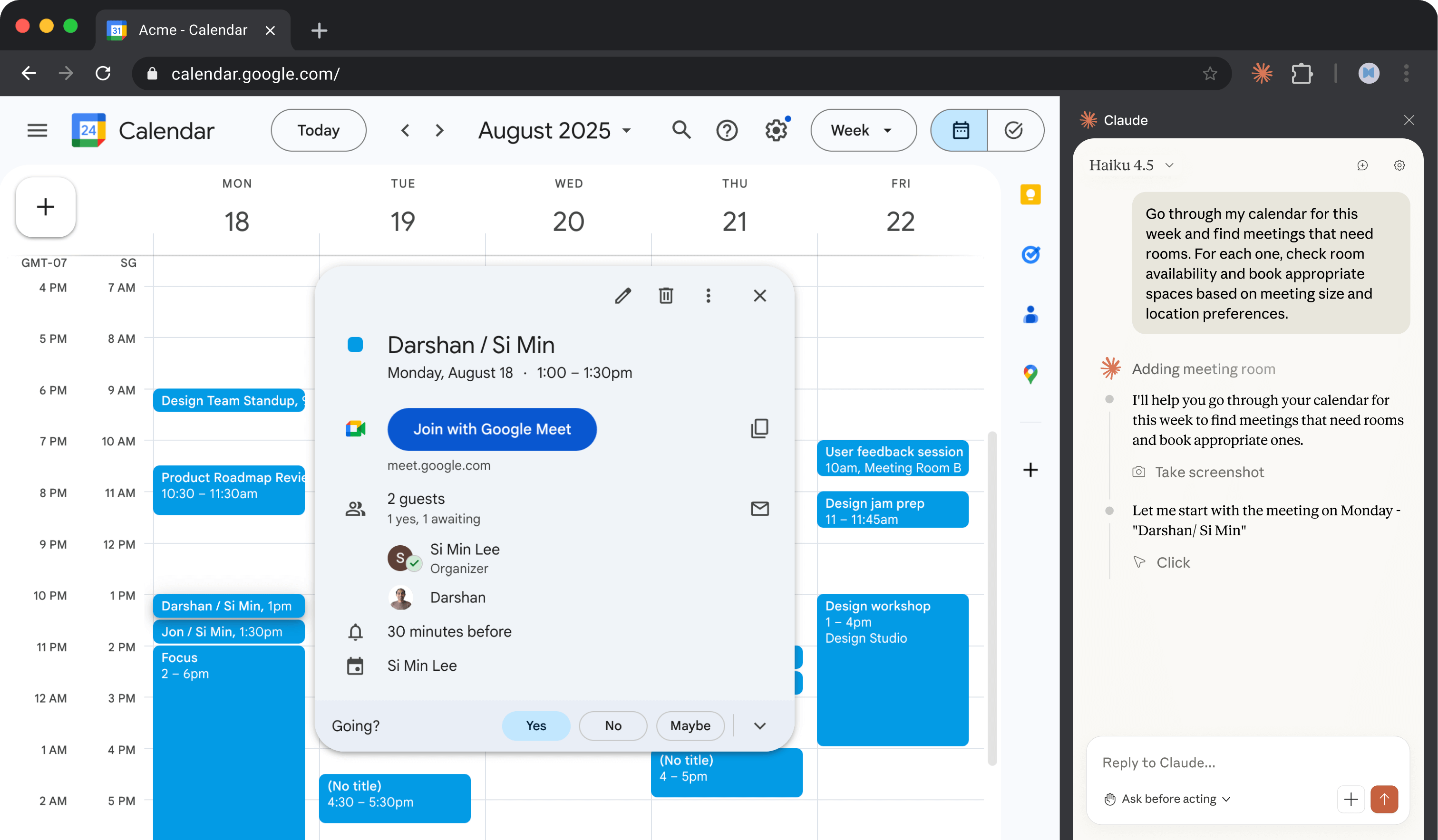
















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-felice-guarda-laptop-personale.jpg)


















































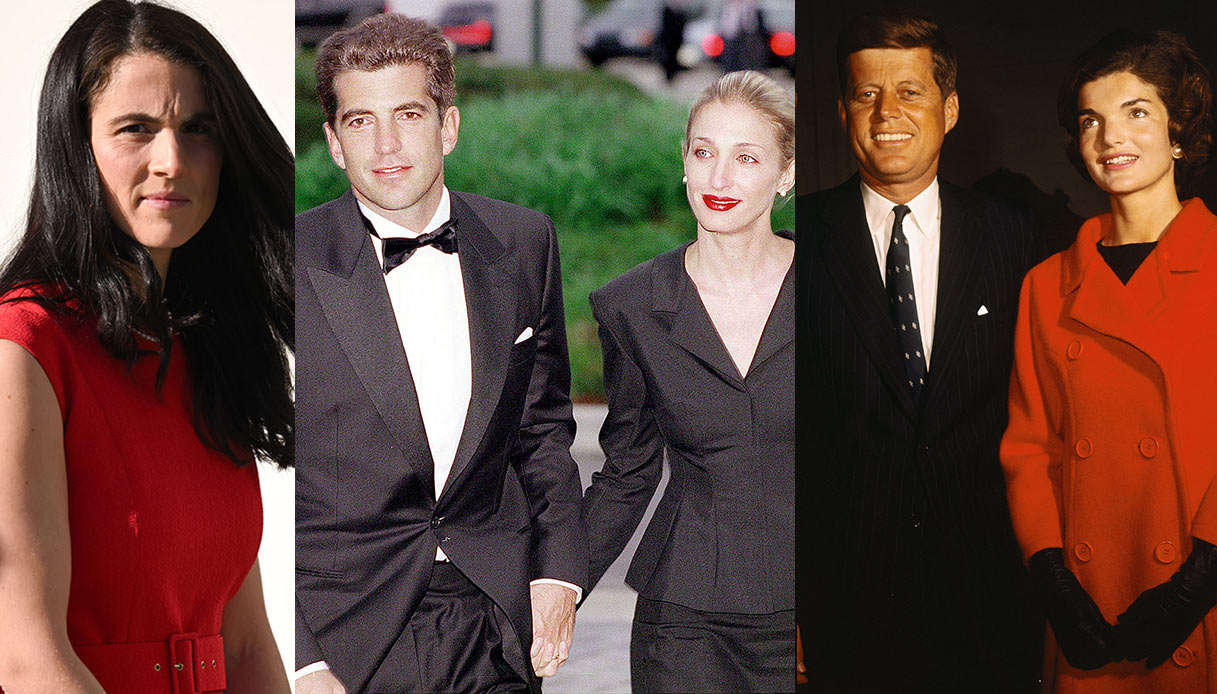





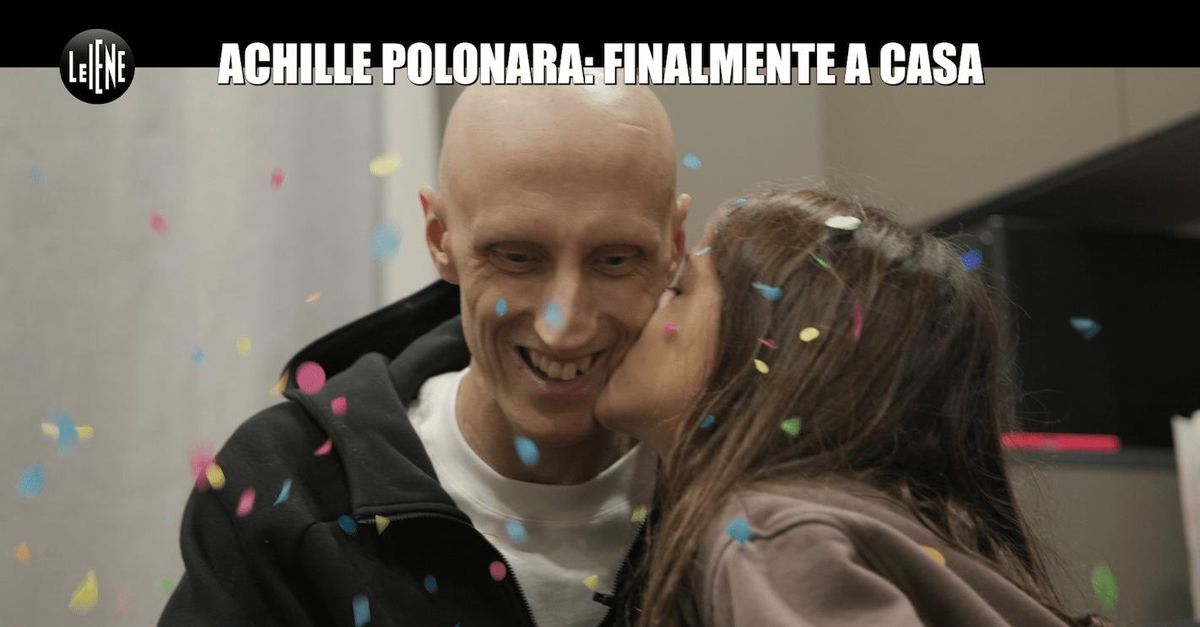

















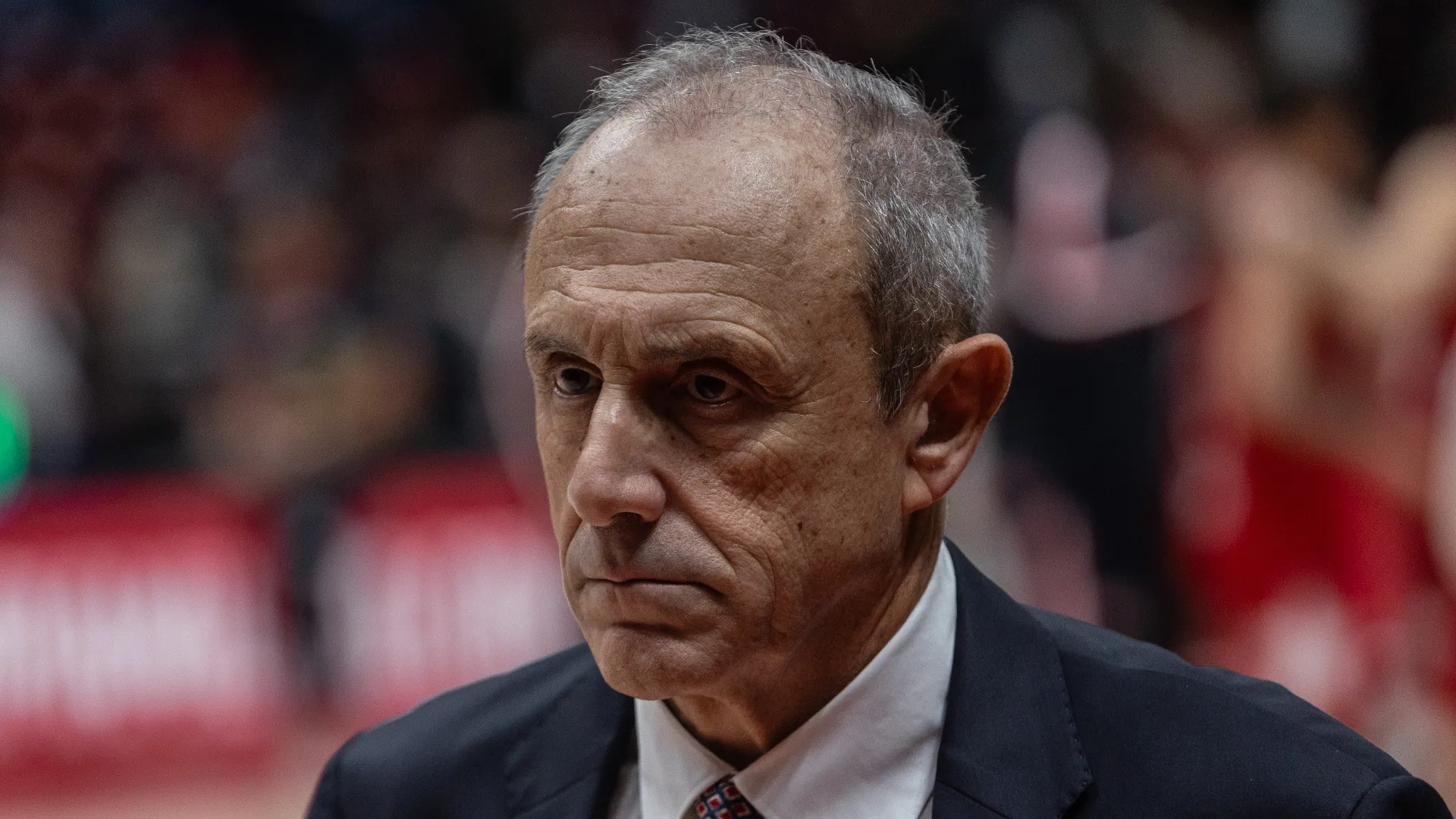



























ddd-1763990389998.jpeg--una_partita_di_monopoly_a___torino__da_oggi_e_realta.jpeg?1763990390034#)





-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)