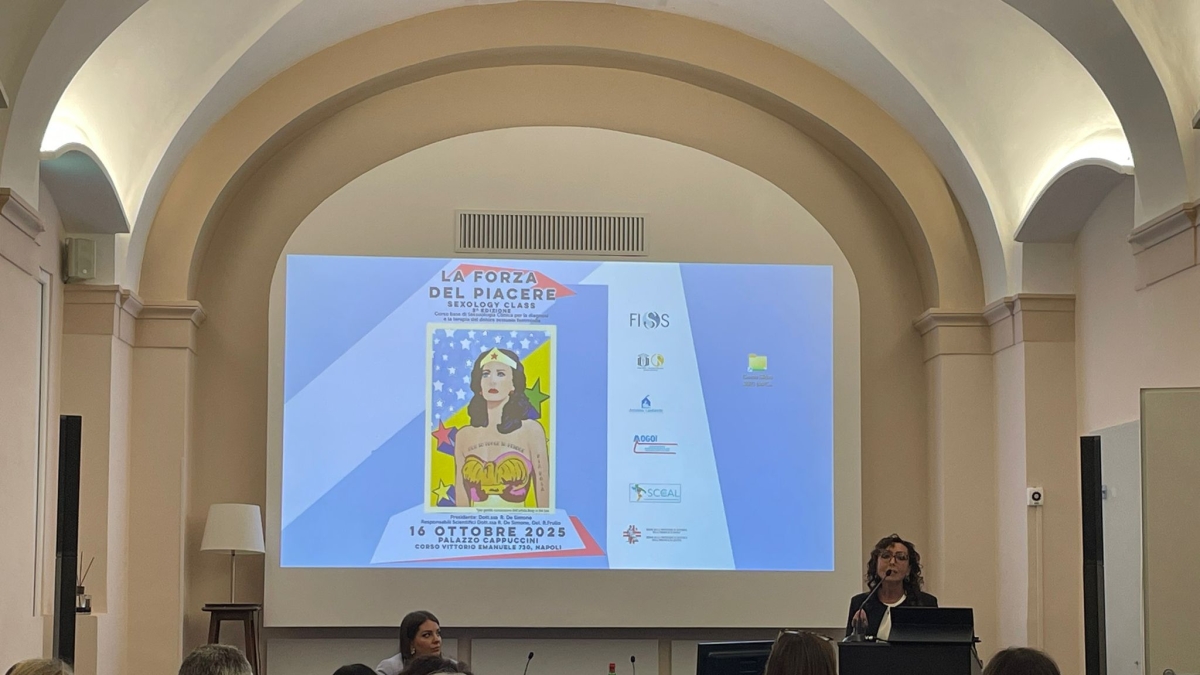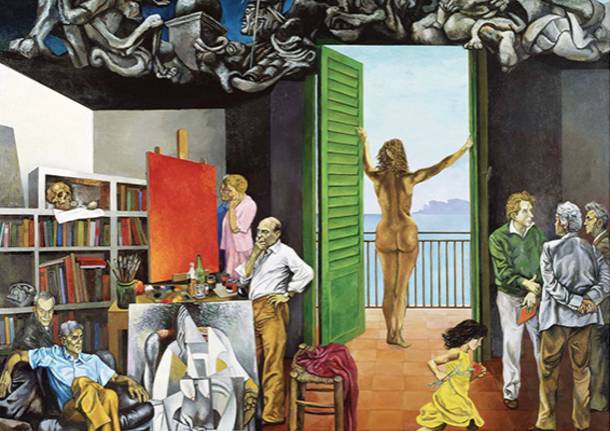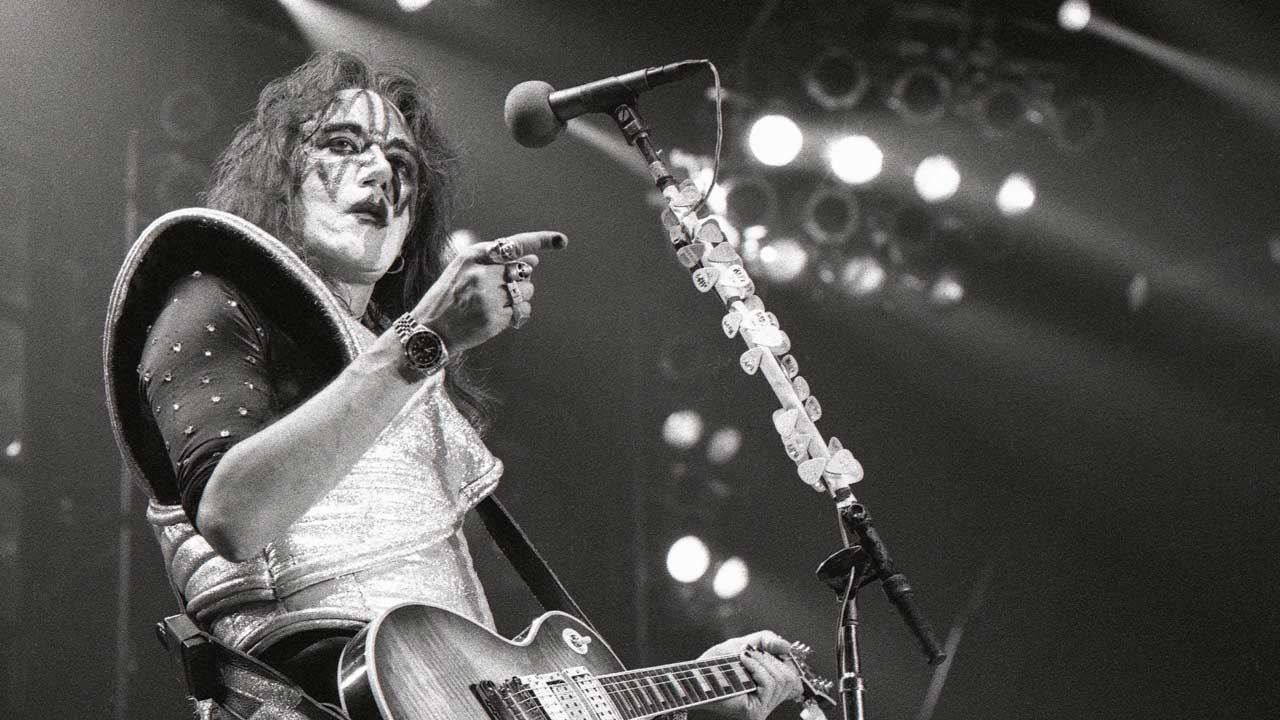Le finestre rotte (e riparate) dell’Ucraina


Periferia di Lviv, Ucraina, esterno giorno. Supermercato della catena Silpo. Fuori, il consueto panorama suburbano a cui i popoli della galassia post sovietica, quella raccontata da Svetlana Aleksievič, sono abituati: gli edifici squadrati di cemento, a volte ravvivati da un verde urbano pieno di buona volontà come in certi quartieri gentrificati della Polonia, della Germania Est e dei Paesi baltici, a volte lasciati a sé stessi, davanti ai quali sfilano le automobili e i monopattini del XXI secolo. Si aprono le porte scorrevoli del supermercato, e quello che c’è al suo interno è a suo modo sorprendente. Sorprendente per noi, qui, in Europa occidentale, perché gli ucraini ovviamente lo sanno benissimo: nell’ordine, un banco dell’ortofrutta che è una cornucopia di benessere e di buoni prodotti; una panetteria di altissima qualità, e questo è quasi ovvio in questo Paese in cui il pane è stato il primo riscatto dalla fame imposta dagli invasori, dalla Holodomor in giù («Non c’è posto per l’amore, qui», come scrive Yaroslav Trofimov); e poi un banco del pesce con splendidi salmoni freschissimi, i surgelati con vasta scelta, un fiorista con i nasturzi, le mimose e le tuberose, un reparto alcolici felicemente fornito, con tanto di neon in stile night club, eccetera. Ma anche, scusate la frivolezza, un allestimento di prodotti che ricorda la Scandinavia, o un Paese nordico, molto più della nostra Italia: faretti posizionati nei punti giusti, schermi digitali a scritte mobili, musica soffusa. Bene. Ma perché raccontare queste cose dell’Ucraina, e non invece dei bombardamenti che si sono abbattuti sull’oblast di Lviv pochi giorni fa, che a settembre scorso hanno distrutto edifici residenziali nella zona di Sofiivka e nel quartiere della stazione, senza risparmiare nemmeno questo angolo dell’Ucraina occidentale? Perché non dire dei giornalisti torturati, come Victoria Roshchyna, della vita spezzata dei soldati poco più che adolescenti – la meglio gioventù d’Europa – seppelliti in numero crescente nel cimitero di Lychakiv, dei bambini rapiti, prelevati dalle zone occupate e deportati per la russificazione?
Intanto perché è la coesistenza di questi due piani che diamo troppo per scontata quando parliamo di questa guerra. Me ne ero accorto durante un viaggio carbonaro nel nord dell’Ucraina a settembre 2023, stavolta osservando non un supermercato ma un’altra cosa che ricorre nella vita quotidiana delle Nazioni moderne: gli autogrill. Le aree di servizio in Ucraina, un Paese in guerra, sembrano più quelle della Finlandia o della Danimarca, che quelle della scalcinata Italia. Lungo la superstrada che collega Kyjiv a Chernihiv, in una sera d’autunno, a poche decine di chilometri dal fronte, capita di fermarsi e di fare acquisti o prendere un hot dog in un bellissimo autogrill Okko, circondati da qualche sparuto gruppo di soldati. Anche qui la vicinanza tra le due situazioni fa impressione: la catena di distribuzione più che efficiente, la qualità e ricchezza e disposizione dei prodotti sugli scaffali, l’igiene e la civiltà complessiva di un punto di ristorazione che sembra sorgere in mezzo al nulla, e le mimetiche e le uniformi di ragazzi che magari tra un giorno o due saranno in una trincea, esposti al fuoco e ai droni degli invasori.
Raccontare questi aspetti dell’Ucraina contemporanea non è solo una sfida giornalistica affascinante, visto che l’Ucraina rappresenta tragicamente il primo caso nella storia di una democrazia europea del XXI secolo coinvolta in una guerra di aggressione: c’erano state democrazie in guerra ovviamente, Churchill e Roosevelt, ci sono oggi Paesi in guerra, in tutto il mondo; ma questo incrocio di circostanze si dà solo qui e ora. Raccontarlo diventa di più, una specie di missione, per provare a modificare la percezione in Italia dell’aspetto fisico, materiale dell’Ucraina, che è tutta sbagliata, lunare. La testa di un normale lettore di quotidiani, non parliamo di uno spettatore dei catastrofici talk show, è abituata a pensare a Kyjiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Dnipro come a delle specie di Sarajevo o di Srebrenica a metà anni Novanta, ridotte in macerie, o a Dresda nel ’45, con poveri fantasmi che si aggirano disperati tra scheletri di edifici. È vero che il panorama di alcune città ucraine, da Bakhmut a Mariupol ad Avdiivka, purtroppo non è lontano da questa descrizione, e ora che Google Maps ha aggiornato le mappe satellitari di queste città lo si può constatare con i propri occhi, dal salotto di casa. Eppure il novantanove per cento dell’Ucraina non corrisponde affatto alla scena descritta.
Una guerra ci costringe a ragionamenti di utilità. Cosa posso fare per aiutare una causa che ritengo giusta, senza tradire la verità? Cosa posso mostrare per convincere di più le persone a provare solidarietà ed empatia per una causa che avrebbe già dovuto raccogliere la loro solidarietà il 24 febbraio 2022? Che cosa raccontare, della semplice verità dell’Ucraina, per provare a scuotere quel poco ancora delle coscienze smarrite e annebbiate di italiani e occidentali al terzo anno dell’invasione? La prova che il racconto di come la vita quotidiana va avanti funziona più di molti editoriali l’ho avuta pubblicando sui social un video proprio dall’interno di quel supermercato Silpo, a Lviv, con le immagini delle pagnotte e del banco dei formaggi. È stato di gran lunga la cosa che in tre anni ha più coinvolto il giro di amici e conoscenti riguardo all’Ucraina. Ha scatenato un profluvio di reazioni e di commenti, molti (moltissimi) da persone che solitamente sulla guerra non si esprimono, non hanno un’opinione. Identificazione? Inclusione visiva nell’immaginario classico di un Paese europeo? Non lo so. Però funziona. Non è un po’ triste che a suscitare nella mente di un lettore / utente la simpatia per una causa sia il racconto di una rete di autogrill, e non la fremente indignazione che qualsiasi europeo dovrebbe provare per la sorte di Victoria Roshchyna o di Victoria Amelina o dei bambini rapiti? Sì, lo è. Però funziona.
Il tema non è solo comunicativo, cioè non riguarda solo noi che assistiamo alla guerra dal nostro divano. Correva l’anno 1982 quando James Q. Wilson (lo stesso Wilson che aveva scritto negli anni Sessanta dei saggi bellissimi sulla sociologia della Southern California, nei quali si intravedeva tutta l’ascesa di Ronald Reagan, prima governatore, poi presidente) pubblicava la famosa teoria delle finestre rotte, con George Kelling. L’idea, poi applicata con successo da Rudolph Giuliani quando era un decente sindaco di New York e non il trumpiano allucinato che nel 2020 ha negato la vittoria di Biden, la conosciamo un po’ tutti: se la finestra di un edificio si rompe e non viene riparata nell’arco di poche ore la probabilità che qualche teppista ne rompa un’altra è infinitamente maggiore rispetto a una pronta sostituzione. L’incuria invita all’incuria. Il degrado, come piace dire alle amministrazioni di destra, invita al degrado. Nel 2025, la teoria la possiamo declinare così: la distruzione invita alla distruzione. C’è anche questo, nell’urgenza frenetica degli ucraini che ricostruiscono in modo straordinario e rapidissimo la via di Bucha dove nell’aprile 2022 si accatastavano i carri armati dell’eroica battaglia a difesa della capitale, e un anno dopo già sorgevano ordinarie villette a schiera, con prati all’inglese e chioschi di caffè e cornetti, in una normale periferia suburbana che assomiglia in tutto e per tutto ai sobborghi di Varsavia o di Berlino. C’è il bisogno forsennato di difendere, insieme alla normalità della vita quotidiana, l’amor proprio. Riparare, aggiustare, restaurare. Mentre ci si difende dai missili di Mosca, non consentire che la distruzione l’abbia vinta, nemmeno per un angolo di un isolato.
Questo fanno milioni di ucraini oggi, con un affetto disperato per la propria terra che va ben oltre il voltairiano «bisogna coltivare il proprio giardino». Quanto può reggere, la teoria delle finestre rotte, nell’Ucraina che deve fare i conti con il mancato sostegno della nuova amministrazione americana? Si potrà continuare a lungo a ripristinare e restaurare gli edifici e i condomini, tanto quanto le persone (alla clinica Unbroken, nei dintorni di Lviv, si producono le protesi per i soldati, e intanto le organizzazioni che davano assistenza ai veterani restano senza gli aiuti preziosi di Usaid), ora che l’ombrello difensivo americano viene meno? A scrivere queste righe ci si sente subito occidentali: e cioè scettici e preoccupati e pessimisti. Ma se c’è una cosa più fantastica delle altre, nell’Ucraina che resiste, è che dopo un breve viaggio in quel Paese si torna sempre, tutte le volte con una semplice profonda convinzione: sì, gli ucraini ce la faranno. E se loro ne sono convinti, anche noi abbiamo il dovere di esserlo.
Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine ordinabile qui.
L'articolo Le finestre rotte (e riparate) dell’Ucraina proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















































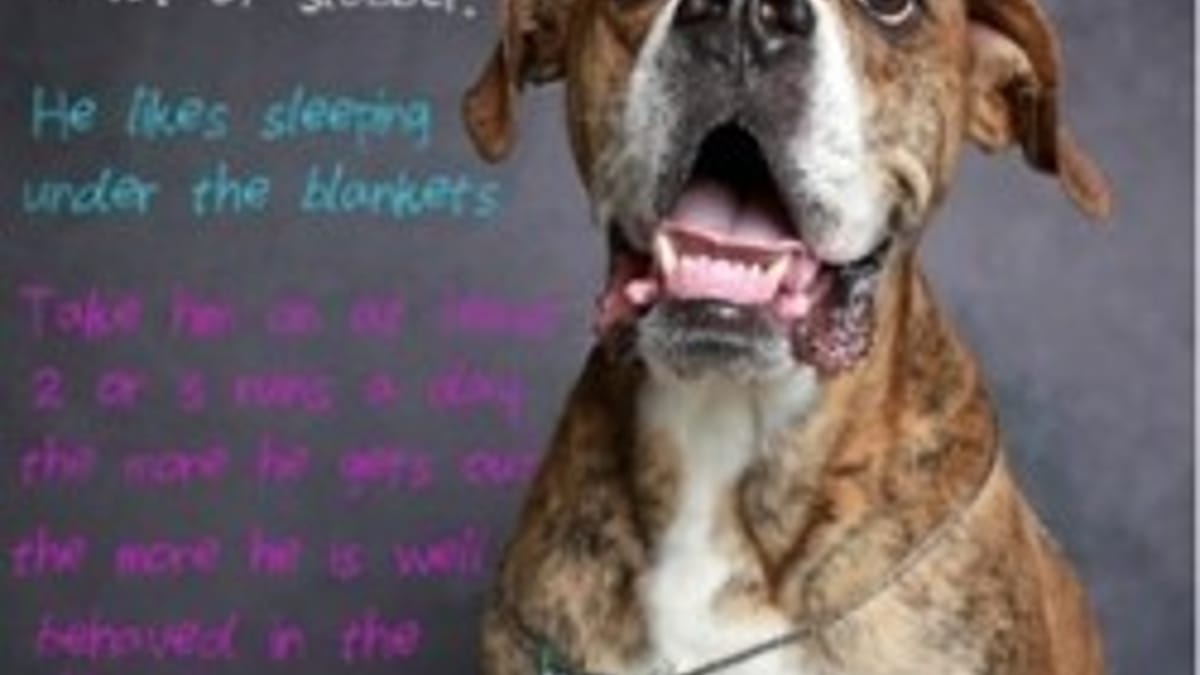













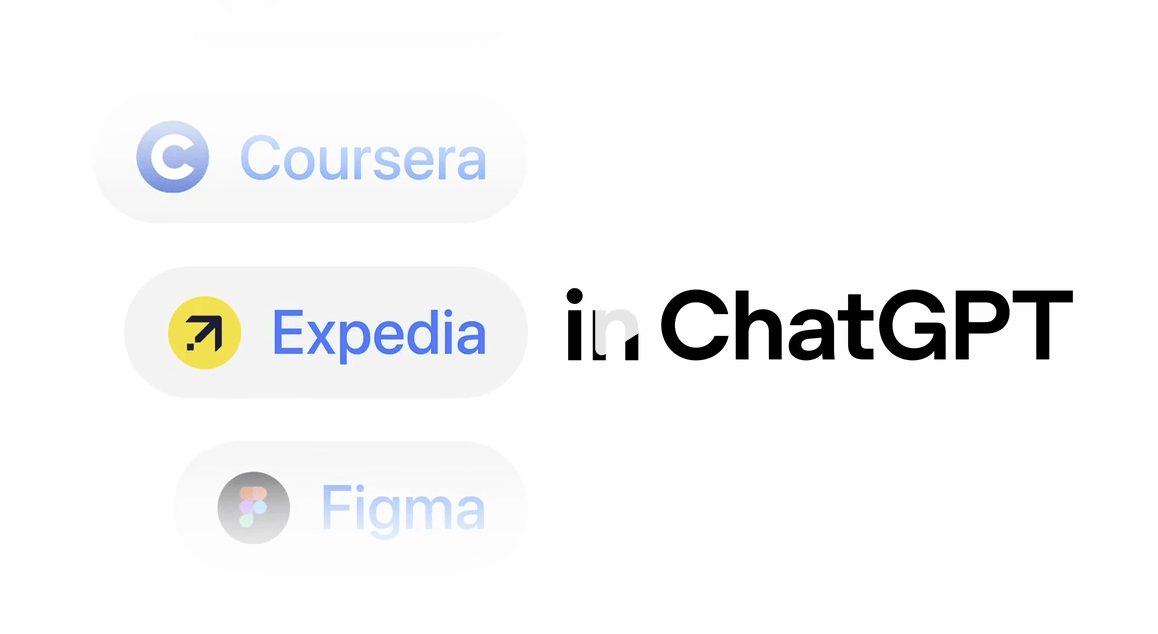
















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/05/persona-mentre-fa-shopping.jpg)



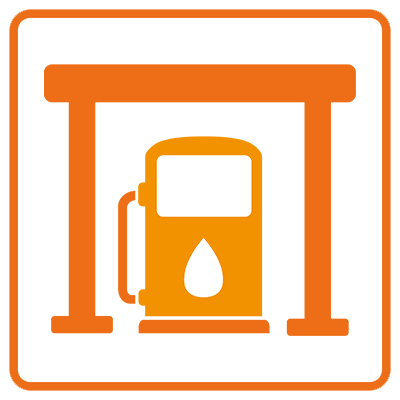







































































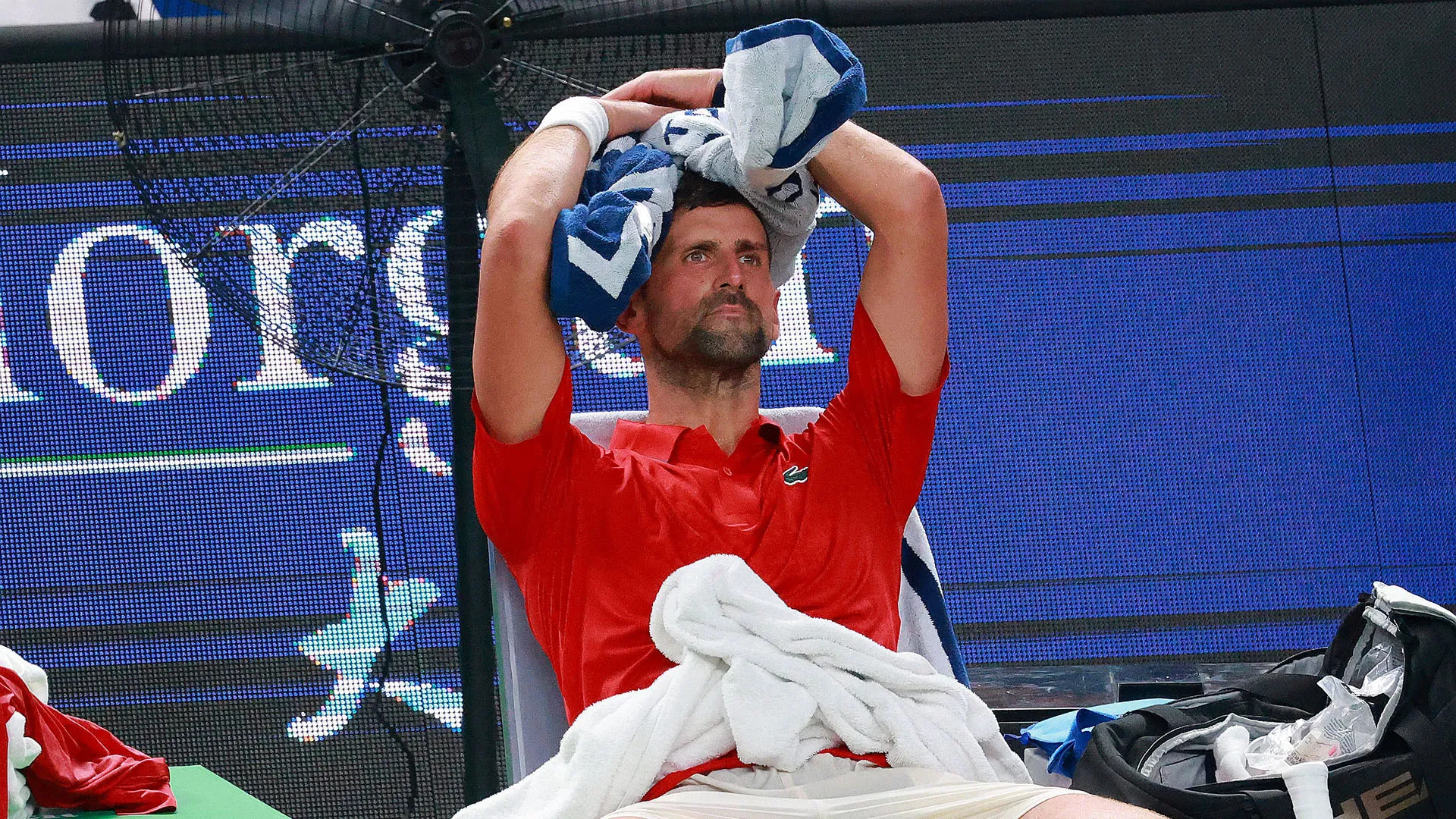
























-1760714215690_1760714235.jpeg--giardini_madre_teresa__scritte_e_insulti_contro_l_eurodeputata_silvia_sardone.jpeg?1760714235469#)





-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)