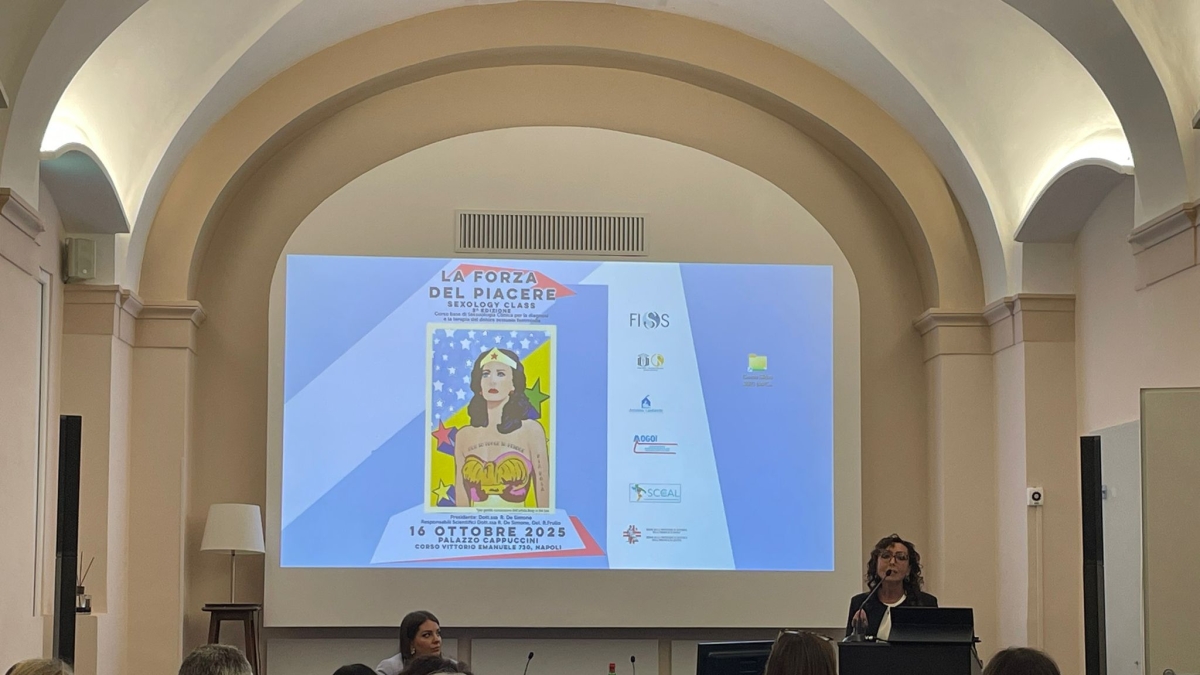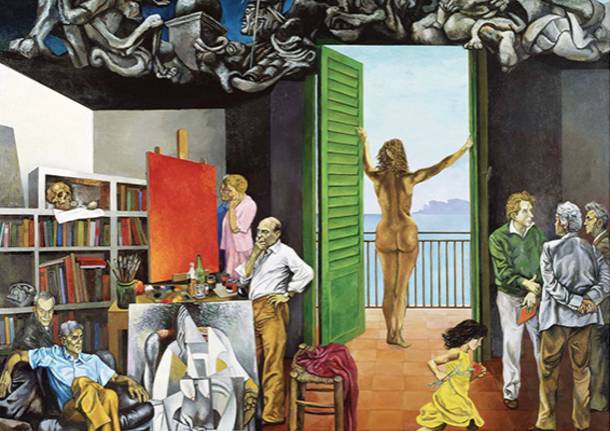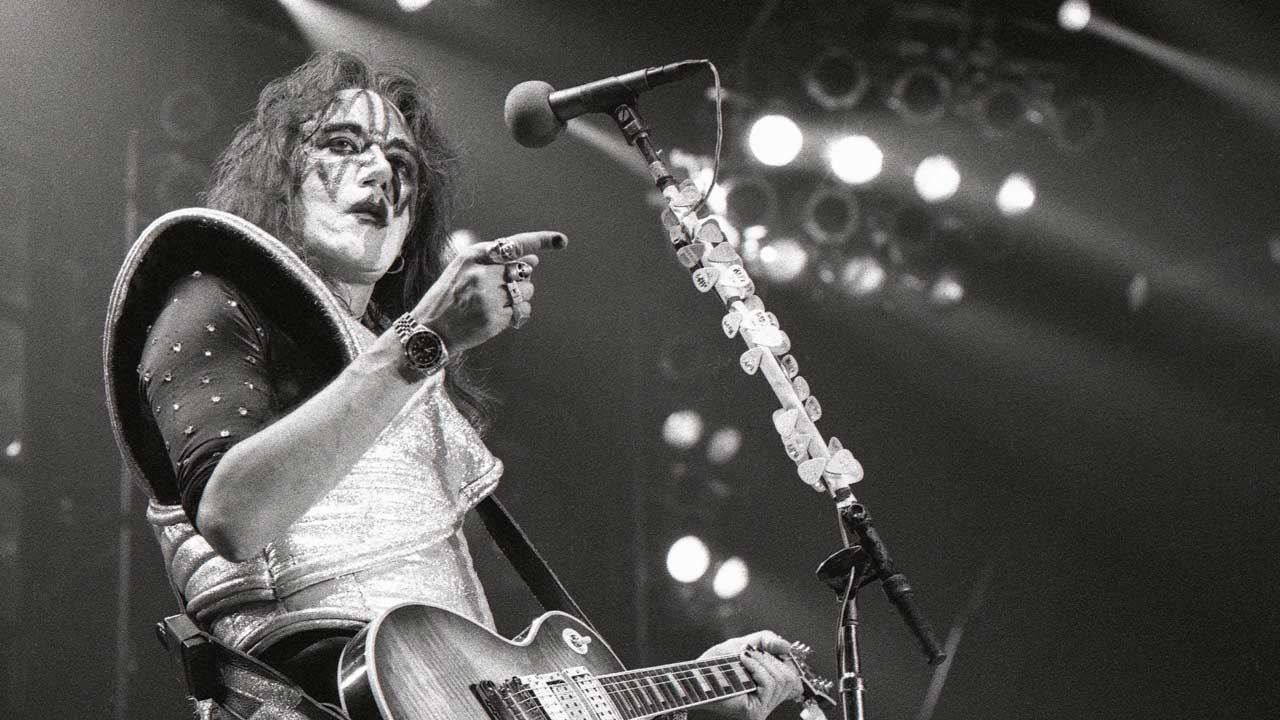L’economia dell’elemosina di Bressanini, e la suscettibilità dei follower non leggenti


Nelle classifiche degli inserti culturali che potrebbe capitarvi di sfogliare al bar nel fine settimana, vedrete tra i più venduti – settimo tra i più venduti in assoluto la scorsa settimana, terzo nella saggistica a meno che non decidano di catalogarlo nella varia – un libro intitolato “La dieta termodinamica” (lo pubblica Mondadori).
Non l’ho neppure sfogliato, e posso immaginare che sia un libro per l’ignorantissimo pubblico di oggi, quello al quale devi ancora dire che sì, il prosciutto vale come carne, e no, il riso non è un’eccezione rispetto all’essere i carboidrati un ostacolo alla perdita di peso. Ma un’altra è la ragione per cui è interessante parlare delle settemila e settecentonove copie che il nuovo libro di Dario Bressanini ha venduto nei primi sei giorni in cui è stato in commercio.
Io Dario Bressanini non sapevo chi fosse, perché ormai il mondo va così: che puoi avere seicentomila e spicci follower che seguono le tue gesta minuto per minuto, e il resto del mondo può non essersi mai accorto della tua esistenza. Essere famosi non basta più neppure a essere famosi.
Una volta seicentomila – copie di dischi, biglietti del cinema, libri venduti – era una cifra enorme che garantiva che ti conoscessero in sei milioni almeno, perché esistevano i prodotti del cui consumo si parlava tra amici, esistevano le opere, esistevano gli argomenti di conversazione. Adesso seicentomila – follower – non significano un bel niente, perché la gente ti spollicia al cesso.
Comunque. L’altro giorno Bressanini pubblica su Instagram un video che è una lezione magistrale di economia dell’elemosina, e rappresenta il momento nel quale decido d’interessarmi a lui. È un video in cui spiega perché è «costretto» (ohibò), anche se stufo, a parlare sempre del suo nuovo libro. Ve ne trascrivo le parti che mi hanno colpito.
«Il successo di un libro si vede nelle prime due settimane di uscita, magari tre, ma la prima è decisiva, altrimenti il libro è spacciato». Oddio, Bressanini: lo dica a Valérie Perrin, il cui “Cambiare l’acqua ai fiori” partì la prima settimana con quattrocento misere copie (molto meno di quel che vende la prima settimana lei, Bressanini, ma persino meno di quel che vendo io, che nel mercato editoriale conto come il due di coppe quando briscola è a danari), la seconda era a settecento, poi scese addirittura a seicento, e col passaparola è nei mesi e negli anni arrivata a un totale di novecentoventimila copie.
Una cifra, diciamolo per i lettori non in confidenza coi numeri editoriali, per la quale io cederei un rene, ma alla quale non arriva neppure lei: “La scienza delle pulizie” è arrivato a centocinquemila copie – nonostante la prima settimana ne avesse vendute cinquemila e cinquecento: quattordici volte la prima settimana della Perrin.
«La classifica è importantissima perché è un volano di vendita». Sì, insomma. Vent’anni fa, forse: quando i librai si prendevano il disturbo di comprare i giornali. E soprattutto: la classifica non esiste per il pubblico degli influencer (che vent’anni fa non esistevano), sebbene essi si affrettino a fotografarla perché rappresenta ancora un qualche prestigio percepito e hanno i parenti giù al paese che vogliono sapere che il nipote fa una cosa che sanno cosa sia, un libro.
La classifica è quella cosa che il ceto medio riflessivo che la domenica fa cadere pezzi di brioche su Robinson o su Tuttolibri o su La lettura guarda per ispirarsi: ma il ceto medio riflessivo compra Carofiglio, mica un libro sulle diete (a meno che non gliene parlino i figli che l’hanno visto su TikTok).
È però vero che è importantissima la prima settimana, quella di ciò che in analfabetese si chiama preordine (come fa un ordine a non essere «pre»?). Bressanini, in questa economia dell’elemosina travestita da «spiegato bene», illustra i tecnicismi: tu prenoti il libro su Amazon e la copia che hai prenotato viene conteggiata nelle vendite della prima settimana. Non è vero, come dice lui, che serva a far prendere il libro ai librai (i librai se lo vendono lo prendono, mica son diversi dagli altri commercianti): serve ad avere un picco di vendite all’inizio, con schema tipico degli influencer, cioè di coloro i cui libri vengono comprati non per ciò che c’è scritto dentro ma perché la loro clientela s’illude d’avere un rapporto con loro.
È un modello economico che funziona sempre più anche per chi di mestiere non si accende la telecamera del telefono in faccia: si lancia il libro prima in modo che molti lo prenotino e le vendite della prima settimana siano esorbitanti, e poi quelle successive non sono all’altezza: Dan Brown, partito la prima settimana da cinquantasettemila copie, la seconda era già a trentuno, e poi ventitré, e poi diciotto (si dice che Rizzoli gli abbia dato tre milioni: spero sia una leggenda, altrimenti staranno piangendo).
Ma proseguiamo con l’economia dell’elemosina di cui Bressanini si è assicurato la cattedra. «In fase di prevendita, il mio libro ha venduto circa cinquemila copie: sono tantissime per il libro medio», dice, proseguendo a mentire sul fatto che certo non sarà ai primi posti della classifica perché coi Cazzullo e i Barbero non c’è partita (è una menzogna sottile: certo che Cazzullo e Barbero hanno venduto di più alla loro prima settimana, ma ora sono usciti da un mese, e la gara è sul venduto della settimana, mica su quello totale).
E a dire poi che si aspetta che da qui a Natale il dato triplichi, «guardate che non mi sto lamentando», ma l’ordine di grandezza quello è. Solo che no. L’ordine di grandezza è quello per i libri medi, ma Bressanini ha venduto centocinquemila copie con “La scienza delle verdure”, quasi centomila con “La scienza della pasticceria”, ottantasettemila con “La scienza della carne”. Solo che in un altro passaggio del video dice che ha una royalty a partire dal dieci per cento (spero menta, in caso contrario: cambi agente), e che quindi prende due euro a copia, e sappiamo come funziona Instagram, no?
Funziona che ti allevi un pubblico ignorante e populista, che sta lì perché non ha una vita e quindi ha bisogno di quegli amici immaginari che vivono nel telefono (gli amici immaginari di suo nonno vivevano nei romanzi: tutto cambia), che guarda gratuitamente la tua vita e in cambio ti dà la vera dopamina dei cuoricini e la finta rilevanza di farti sembrare uno con un pubblico, finta rilevanza che indurrà case editrici a commissionarti libri e altre forme di sussistenza.
Però a quel pubblico ignorante e populista non puoi dire che a ogni libro incassi duecentomila euro, perché quel pubblico lì è troppo ignorante per pensare che scrivere un libro richieda più impegno di quello che mette lui nello spolliciare Instagram, e troppo populista per concepire che i suoi amici immaginari dentro al telefono guadagnino più di lui.
Il nucleo di ciò che dice Bressanini – tradotto dal democristianese: voi qua siete seicentomila e sì e no l’uno per cento di voi mi compra, ma non vi vergognate di scroccare contenuti tutto il tempo e poi con tutto quel che faccio per voi non vi accattate la mia batteria di pentole? – è vero, ma è anche un comma 22. Se c’è l’economia dell’elemosina, cioè quella per cui uno che fa i video social può colpevolizzarvi perché lui vi fa i contenuti gratis e voi dovreste come minimo sentire il dovere di comprargli il libro, è perché c’è un pubblico ormai intellettualmente slabbrato – e viceversa.
A un certo punto Bressanini fa vedere una sleppa di libri di influencer della chimica (una categoria che neppure sapevo esistesse) dicendo che è per questo limite numerico della conversione («conversione» è il modo tecnico in cui si chiama la percentuale di follower che si compra quel che hai da vendere) che Tizia e Caio e Sempronia hanno anche loro parlato molto dei loro libri su Instagram.
Ma, se non ci fosse Instagram e altri analoghi contesti analfabeti, Bressanini e Caio e Sempronia non pubblicherebbero libri. Non era trecento anni fa, che arrivare a pubblicare un libro era qualcosa non alla portata di qualunque tizio con la parlantina. Adesso è così, e in parallelo il pubblico è diventato più refrattario al gravoso impegno di leggere un libro: l’internet te la dà, l’internet te la toglie.
Il passaggio più straziante è quello in cui Bressanini dice che gli chiedono cose che lui ha già scritto nei libri. E io mi chiedo se si possa essere intelligenti e istruiti e persino di successo, e aver capito così poco il mondo: non vogliono andarsi a leggere i libri, vogliono che tu gli dica gratis ciò che vogliono sapere. Gratis, brevemente, con parole semplici, e taggandoli: mica dovranno leggersi i post per intero, vogliono la notifica così leggono solo la risposta a loro, proprio a loro, a loro che il tuo libro col cazzo che lo comprano ma si considerano tuoi amici e si offendono se non rispondi alle loro curiosità.
L'articolo L’economia dell’elemosina di Bressanini, e la suscettibilità dei follower non leggenti proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















































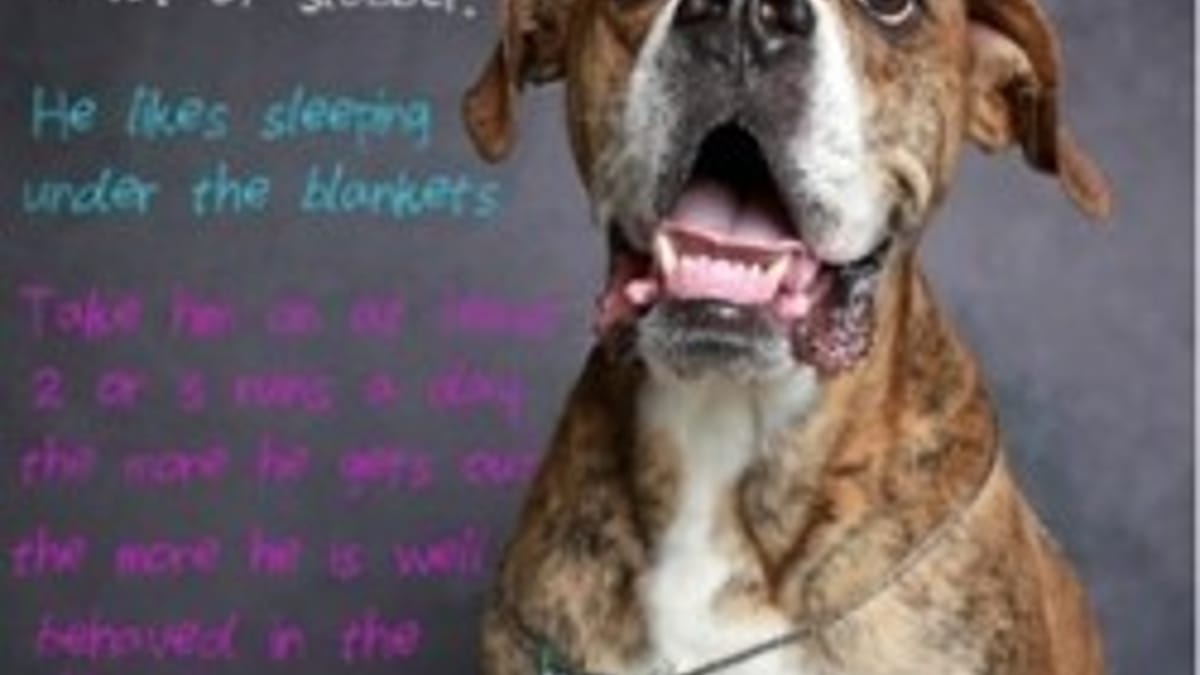













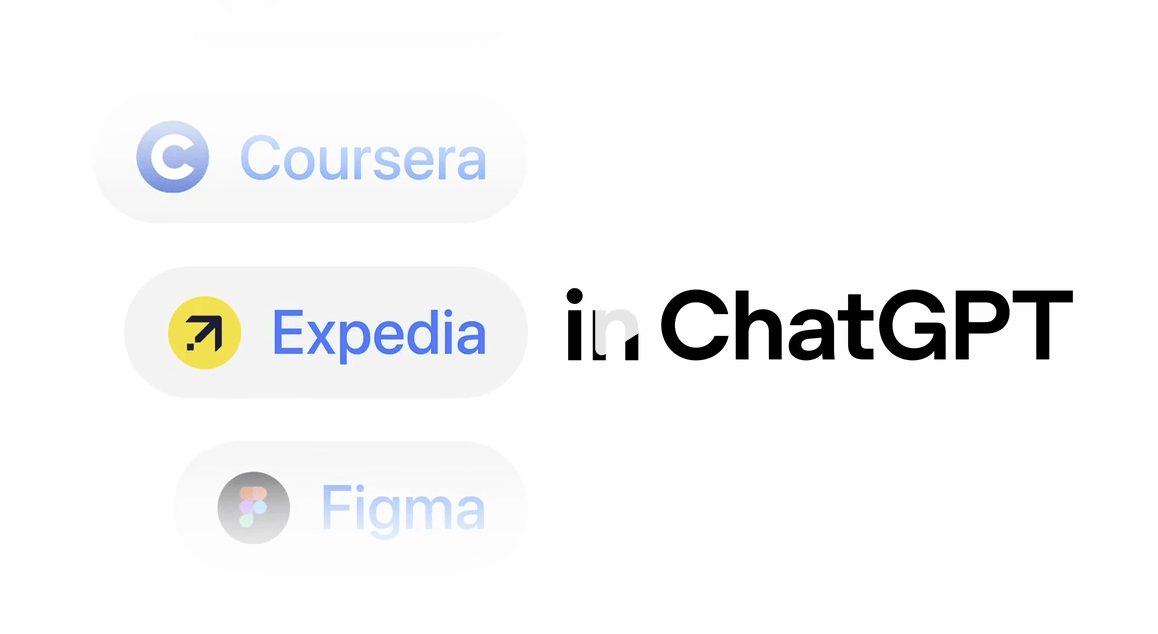
















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/05/persona-mentre-fa-shopping.jpg)



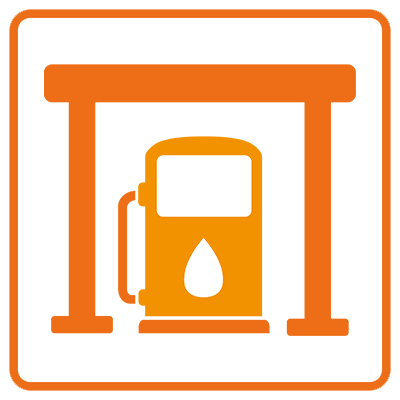







































































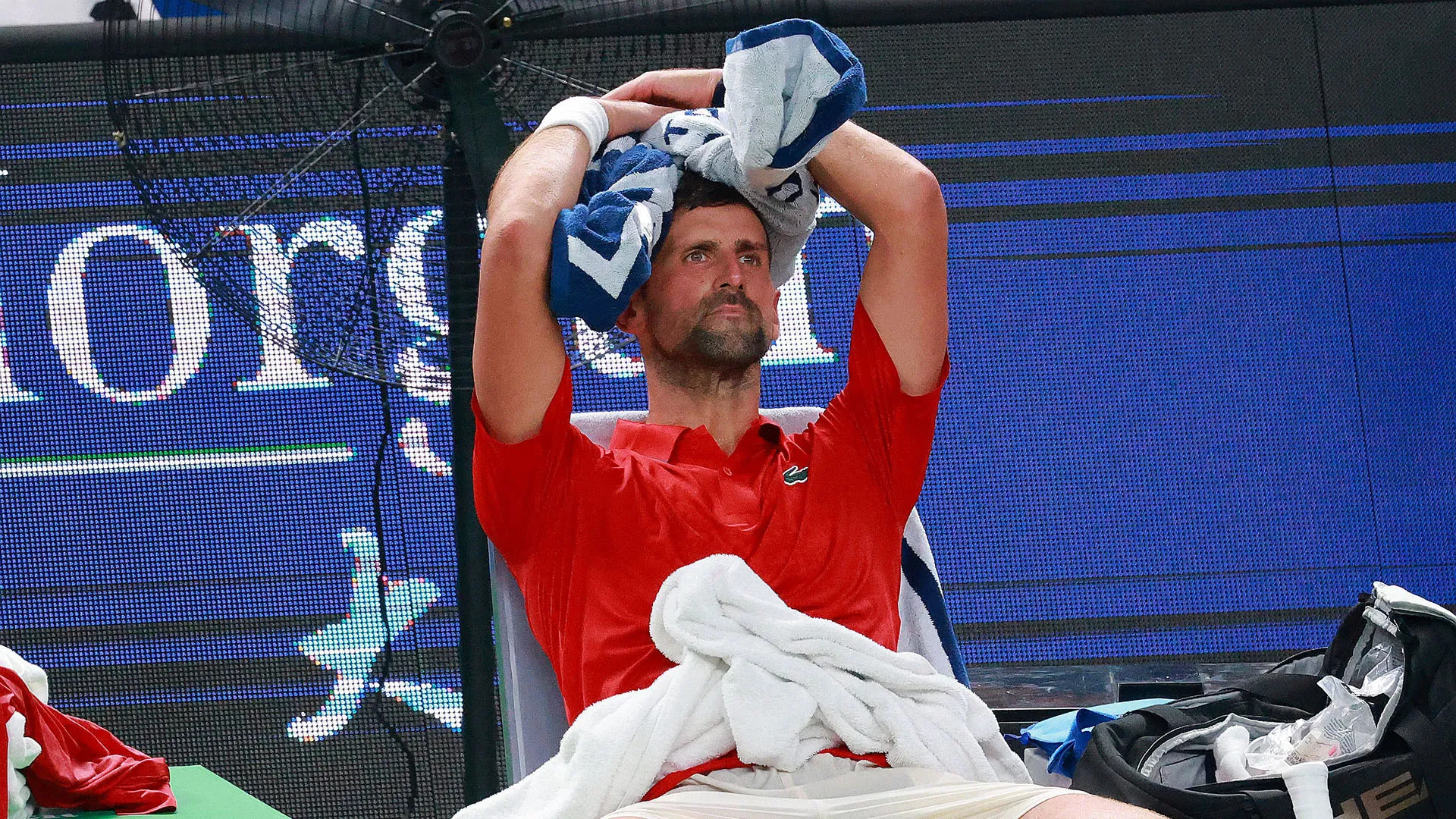
























-1760714215690_1760714235.jpeg--giardini_madre_teresa__scritte_e_insulti_contro_l_eurodeputata_silvia_sardone.jpeg?1760714235469#)





-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)