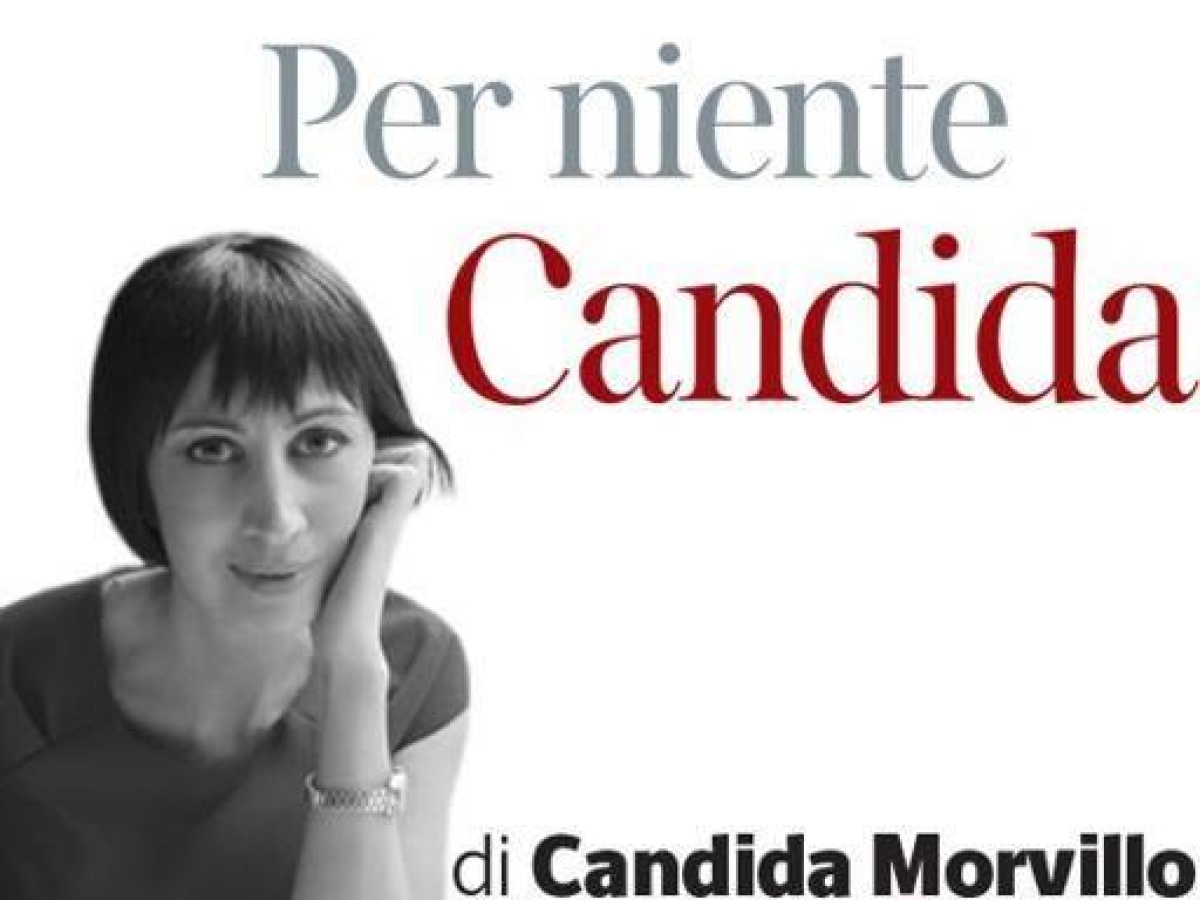Perdita di chance dei dirigenti e inerzia regolamentare della PA: onere della prova, causalità e confini del danno erariale

lentepubblica.it
In questo approfondimento il Dottor Luca Leccisotti analizza onere della prova, causalità e confini del danno erariale nel contesto della perdita di chance dei dirigenti e dell’inerzia regolamentare della PA.
Premessa: la tentazione della ‘chance’ come scorciatoia risarcitoria
Nel pubblico impiego dirigenziale la responsabilità della pubblica amministrazione viene spesso evocata in relazione a situazioni di prolungata inattività organizzativa: mancata adozione dei regolamenti, ritardo nella definizione delle macro‑strutture, assenza di piani dei fabbisogni o di atti di conferimento degli incarichi. In questi contesti, alcuni dirigenti non ottengono per tempo un incarico coerente con la qualifica e prospettano una domanda risarcitoria per perdita di chance: si assume che l’inerzia dell’ente abbia frustrato la probabilità di conseguire un esito favorevole (assegnazione dell’incarico, progressione, trattamento accessorio collegato all’incarico), domandando il ristoro dell’occasione perduta.
Un recente arresto del giudice contabile – in linea con un consolidato orientamento civile e amministrativo – ha tuttavia ribadito che la chance non è un’automatica scorciatoia probatoria: richiede un serio accertamento controfattuale, un nesso causale specifico tra condotta dell’amministrazione e pregiudizio, una probabilità apprezzabile di conseguire il risultato mancato e una quantificazione ancorata a criteri oggettivi. La sola inerzia regolamentare – per quanto censurabile – non basta; occorre dimostrare che, a parità di condizioni, la chance esisteva e aveva un peso non meramente ipotetico.
Lo scopo di questo contributo è ricostruire in chiave sistematica i presupposti della perdita di chance nel pubblico impiego dirigenziale, collocando l’istituto lungo i confini tracciati dal diritto civile (artt. 1223, 2043 c.c.), dal diritto amministrativo (buon andamento, imparzialità, art. 97 Cost.) e dalla giurisdizione contabile, con particolare attenzione agli oneri di allegazione e prova in capo al dirigente e ai riflessi sul danno erariale.
Natura della ‘chance’: bene giuridico autonomo o modalità di liquidazione?
La dottrina e la giurisprudenza italiane – in linea con esperienze straniere – oscillano fra due ricostruzioni. Una, ‘ontologica’, considera la chance un bene autonomo: l’interesse tutelato non è l’esito finale (l’incarico), ma la probabilità qualificata di conseguirlo, che ha un proprio valore. L’altra, ‘metodologica’, riduce la chance a criterio di liquidazione del danno futuro incerto: non un bene autonomo, ma una tecnica per commisurare il risarcimento a una probabilità.
Nel pubblico impiego prevale un’impostazione prudente: il giudice richiede, comunque la si qualifichi, che la chance sia seria e concreta, non un’alea indifferenziata. Ciò implica che il dirigente non può limitarsi a dedurre l’esistenza di un posto in pianta o la mera qualifica: deve allegare elementi che rendano verosimile e probabile l’attribuzione dell’incarico a suo favore nel contesto dato (profilo professionale, esiti di precedenti selezioni, criteri regolamentari, performance, comparazioni interne, regole di rotazione e trasparenza).
Illo tempore: il ruolo del tempo nell’accertamento del nesso causale
L’inerzia regolamentare si misura sul tempo: quanto è durato il vuoto normativo o organizzativo? quali effetti ha prodotto sulla programmazione del fabbisogno? quali incarichi sono stati nel frattempo conferiti, e con quali procedure? Il nesso causale tra inerzia e perdita di chance si costruisce, quindi, su una cronologia: serve mostrare che, in quel periodo specifico, il dirigente aveva opportunità concrete che l’ente ha impedito o ritardato oltre la soglia della ragionevolezza.
La controfattualità è l’asse portante: se l’ente avesse adottato il regolamento/atto organizzativo nei tempi tipici, vi sarebbe stata una probabilità apprezzabile che quel dirigente fosse incluso nella rosa dei possibili destinatari e, con elevata verosimiglianza, scelto? Tanto maggiore è la dimostrazione documentale (interpelli, short‑list, precedenti deliberazioni, fabbisogni scoperti), tanto più sostenibile è la pretesa.
Onere della prova: ciò che compete al dirigente e ciò che non può presumersi
La perdita di chance, in quanto danno eventuale, non tollera presunzioni generalizzate. Spetta al dirigente provare: (a) la condotta antigiuridica dell’ente (inerzia nell’adozione di regolamenti o atti dovuti, violazione di norme organizzative, discriminazioni); (b) l’esistenza di una chance seria e concreta, documentando opportunità effettive in cui, in base a regole e prassi, avrebbe potuto essere destinatario dell’incarico; (c) il nesso causale specifico; (d) il quantum del pregiudizio, calibrato secondo criteri probabilistici (perdita del trattamento accessorio connesso, minorazioni di carriera misurabili).
Non è sufficiente l’allegazione dell’inadempimento organizzativo in sé: l’inerzia può essere fonte di illegittimità o di responsabilità per violazione di doveri, ma il danno patrimoniale (perdita di chance) richiede un quid pluris dimostrativo. Anche il danno non patrimoniale non è in re ipsa: la frustrazione professionale va provata con circostanze oggettive (demansionamento di fatto, svilimento dell’immagine professionale, esclusioni ingiustificate da processi selettivi).
Causalità e concorrenza di cause: la platea dei potenziali destinatari
Nelle organizzazioni complesse gli incarichi dirigenziali sono contesi tra una platea ampia di candidati qualificati. La perdita di chance esige di misurare la competizione: più sono i possibili destinatari con profili equivalenti, più la probabilità individuale si assottiglia e più stringente diventa l’onere probatorio del singolo.
Il giudice, per quantificare la chance, utilizza spesso criteri statistici o comparativi: numero dei posti vacanti, numero dei potenziali candidati, esiti di selezioni analoghe, punteggi di valutazione, regole di rotazione. Un esempio tipico: se vi erano tre posizioni vacanti e sei candidati con profili simili, la chance astratta di ciascuno è del 50%; ma l’attore deve dimostrare elementi che spostino quella probabilità in suo favore (esperienze pregresse, performance, titoli). Senza questa calibrazione, la domanda risarcitoria rischia di ricadere in una mera aspettativa non tutelabile.
Il tema dell’interesse legittimo: tutela reintegratoria vs tutela risarcitoria
Sovente la pretesa è articolata in via parallela: si chiede l’annullamento degli atti (o l’accertamento dell’inerzia) e, in via consequenziale, il risarcimento del danno da perdita di chance. È necessario tenere distinti i piani. L’accertamento dell’illegittimità o dell’inerzia non implica automaticamente la liquidazione del danno: occorre la prova dell’an e del quantum secondo i criteri civilistici.
Per converso, la rimozione giudiziale degli atti e la riedizione della procedura selettiva possono avere effetti reintegratori (attribuzione dell’incarico, ripetizione della selezione) che assorbono, in tutto o in parte, la domanda risarcitoria. La perdita di chance resta, quindi, uno strumento sussidiario e complementare, non un rimedio automatico.
La quantificazione: metodi, percentuali e prudenza
La liquidazione del danno da chance non si fa “a sensazione”. I metodi più utilizzati sono: (i) il metodo percentuale, che stima la probabilità di conseguire l’incarico e applica tale percentuale al differenziale economico tra situazione attuale e situazione controfattuale (trattamento accessorio, indennità di posizione/risultato); (ii) il metodo comparativo, che guarda a casi analoghi (incarichi conferiti a dirigenti con profili comparabili) per stimare il valore medio del beneficio perduto; (iii) il metodo integrato, che combina evidenze statistiche e elementi specifici del caso.
Il giudice adotta un criterio di prudenza: più l’incertezza è elevata, più la percentuale si comprime. Elementi che aumentano la percentuale: inserimento in rose finali, punteggi elevati in valutazioni precedenti, requisiti specialistici rari, coerenza forte tra profilo e posto. Elementi che la riducono: ampiezza della platea, punteggi medi, assenza di manifestazioni di interesse formali, precedenti esclusioni legittime.
Inerzia regolamentare e responsabilità dell’ente: profili organizzativi
La mancata adozione di regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o dei criteri per il conferimento degli incarichi è certamente censurabile sotto il profilo del buon andamento. Tuttavia, perché ciò si traduca in danno, occorre dimostrare che proprio quell’inerzia ha impedito la procedura che verosimilmente avrebbe portato all’incarico. Se, ad esempio, l’ente ha conferito incarichi con atti sostitutivi (delibere, determinazioni) seguendo criteri comunque trasparenti, la sola mancanza del regolamento difficilmente fonda una chance apprezzabile.
All’opposto, se l’inerzia ha bloccato ogni conferimento per un lungo periodo, lasciando vacanti posizioni chiave nonostante fabbisogno e coperture, e il dirigente documenta di essere stato stabilmente nella rosa dei possibili destinatari, il tassello causale si fa più solido. Rimane, però, l’esigenza di una prova individuale, non collettiva: la platea dei dirigenti astrattamente pregiudicati non coincide con i titolari di una chance qualificata.
Demansionamento, inattività forzata e danno curricolare
Diversa dalla perdita di chance per mancato incarico è l’ipotesi del demansionamento o dell’inattività forzata, quando il dirigente venga privato di compiti confacenti e lasciato in posizione inoperosa. Qui il danno si articola su due piani: (a) il danno patrimoniale (perdita di indennità correlate a funzioni effettive); (b) il danno curricolare e di immagine, che però richiede una prova seria (es. preclusione documentata a successive selezioni proprio per l’assenza di esperienze, feedback negativi spendibili all’esterno, evidenze di reputazione professionale lesa).
Il confine è sottile ma importante: non ogni sottoutilizzo si traduce in perdita di chance; la chance attiene al mancato esito favorevole (incarico), mentre l’inattività coinvolge il pregiudizio derivante dalla privazione di funzioni e dalla conseguente compressione delle prospettive professionali. La prova e la liquidazione seguono, pertanto, tracciati parzialmente diversi.
Connessioni con il settore degli appalti pubblici: effetti organizzativi e responsabilità
Per un’amministrazione che gestisce cicli di appalto e concessione, la presenza di dirigenti senza incarico o la reiterazione di reggenze informali non è solo un problema di HR: impatta sulla responsabilità amministrativo‑contabile e sulla qualità delle funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023). Strutture instabili generano ritardi di gara, proroghe postume, ricorso improprio a negoziate senza bando: tutte patologie che espongono l’ente a rilievi ANAC, contenzioso, maggiori costi.
In questa chiave, l’adozione tempestiva dei regolamenti organizzativi e la corretta attribuzione di incarichi non solo prevengono pretenziose domande da perdita di chance, ma sono condizione abilitante per la buona amministrazione degli appalti. Un RUP senza chiaro inquadramento o un dirigente tecnico “pro tempore” in perenne reggenza indeboliscono la catena di accountability e complicano la tracciabilità delle scelte (motivazioni, responsabilità, incentivi ex art. 45).
Difese dell’amministrazione: come si risponde a una domanda da perdita di chance
Un’istruttoria difensiva efficace si concentra su quattro profili: (i) inesistenza di opportunità concrete nel periodo rilevante (assenza di posti vacanti, selezioni non bandite per legittime ragioni di spending review, riorganizzazioni complesse in corso); (ii) assenza di causalità specifica (il mancato incarico dipende da scelte legittime e motivate, non dalla sola mancanza del regolamento); (iii) ampiezza della platea e, dunque, bassa probabilità individuale; (iv) quantum: anche a voler riconoscere un profilo di chance, la percentuale è ridotta e il differenziale economico modesto.
È essenziale ‘raccontare’ la cronologia: atti adottati (delibere, determinazioni), ragioni dei ritardi, stato dei fabbisogni, procedure di selezione svolte o programmate. La trasparenza documentale riduce le aree grigie su cui spesso si innestano pretese risarcitorie ipertrofiche.
Strategie attoree: come si costruisce una domanda solida
Dal lato del dirigente, la strategia vincente non è la denuncia generica dell’inerzia, ma la costruzione di un percorso probatorio: manifestazioni di interesse e candidature presentate, collocazione in rose finali, valutazioni positive, indici di coerenza tra profilo e posizioni rimaste vacanti, raffronto con colleghi destinatari di incarichi in condizioni simili. Dove possibile, è utile quantificare in termini probabilistici e economici il pregiudizio, mostrando come la chance superi la soglia dell’apprezzabilità.
Un uso accorto degli strumenti di accesso agli atti (documentale e civico) e dei dati organizzativi (organigrammi, dotazioni organiche, Piani integrati di attività e organizzazione) può fornire la trama documentale necessaria per superare la diffidenza del giudice verso pretese astratte.
Il parametro costituzionale e il bilanciamento degli interessi
Il fondamento costituzionale della disciplina sta nell’art. 97 Cost.: buon andamento e imparzialità. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali deve essere funzionalizzata all’interesse pubblico, non a premialità individuali. Il giudice tende a presidiare questo equilibrio: da un lato, non legittima inerzie organizzative e pratiche di gestione opaca; dall’altro, non trasforma la funzione dirigenziale in un diritto soggettivo all’incarico.
La perdita di chance, intesa come tutela sussidiaria, interviene quando la compressione delle aspettative supera la soglia di tollerabilità e, soprattutto, quando è provata la concreta probabilità perduta. Il bilanciamento evita il pendolo tra automatismi (risarcimento in re ipsa) e negazione aprioristica (impossibilità di tutela).
Linee guida organizzative per evitare il contenzioso
In termini propositivi, alcune scelte organizzative riducono il rischio di contenzioso e, insieme, migliorano la qualità dell’azione amministrativa:
– Regolamenti chiari e aggiornati sui criteri di conferimento;
– Calendarizzazione annuale dei conferimenti con finestre temporali note e trasparenti;
– Banche dati interne sulle competenze e le esperienze, utili a fondare motivazioni comparative;
– Avvisi interni con griglie di valutazione puntuali e verbali motivati;
– Presidio del controllo interno (OIV, anticorruzione) sugli scostamenti;
– Tracciabilità delle reggenze e limiti temporali stringenti.
Queste misure, oltre a rispondere a canoni di legalità, rendono più facile rigettare domande risarcitorie pretestuose e, viceversa, facilitano un ristoro equo nei casi in cui la chance perduta sia effettiva.
Spunti dalla giurisprudenza recente
Gli orientamenti più attuali ribadiscono tre assi: (i) la chance è risarcibile solo se seria; (ii) l’onere della prova non si alleggerisce per il solo fatto dell’inerzia regolamentare; (iii) il quantum si determina secondo criteri prudenziali, con riduzione delle pretese non suffragate da dati oggettivi. In talune decisioni di merito, la domanda è stata respinta in blocco per carenza di prova sul nesso causale; in altre è stato riconosciuto un ristoro limitato (percentuale modesta del differenziale economico) proprio in ragione della concorrenza interna elevata e della mancanza di elementi specifici a favore del ricorrente.
In controluce, si nota l’intento di evitare che la perdita di chance diventi un grimaldello per monetizzare ogni disfunzione organizzativa: il risarcimento non è strumento di sanzione astratta dell’ente, ma di riparazione di un pregiudizio individuale provato.
Conclusioni: dalla retorica del ‘diritto all’incarico’ alla cultura della prova
Il messaggio al sistema è semplice: non esiste un diritto soggettivo all’incarico; esiste, semmai, un diritto a procedure trasparenti e a decisioni ragionevoli. Quando l’amministrazione viola questi canoni e ciò sopprime una probabilità concreta di esito favorevole, la perdita di chance è risarcibile, ma resta un istituto selettivo, che richiede prova seria e quantificazione prudente.
La cultura della prova – cronologie, documenti, comparazioni – è l’antidoto sia alla negazione aprioristica della tutela, sia alla sua inflazione. Per le amministrazioni, l’investimento in regole organizzative, trasparenza e tracciabilità è la vera assicurazione contro contenziosi seriali; per i dirigenti, la qualità delle allegazioni fa la differenza tra una domanda credibile e un’aspirazione velleitaria.
In questo equilibrio si colloca la fisiologia del pubblico impiego dirigenziale: selezione per merito, conferimento per ragioni organizzative motivate, responsabilità misurabile e, solo quando davvero dovuto, risarcimento per la chance perduta.
The post Perdita di chance dei dirigenti e inerzia regolamentare della PA: onere della prova, causalità e confini del danno erariale appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0









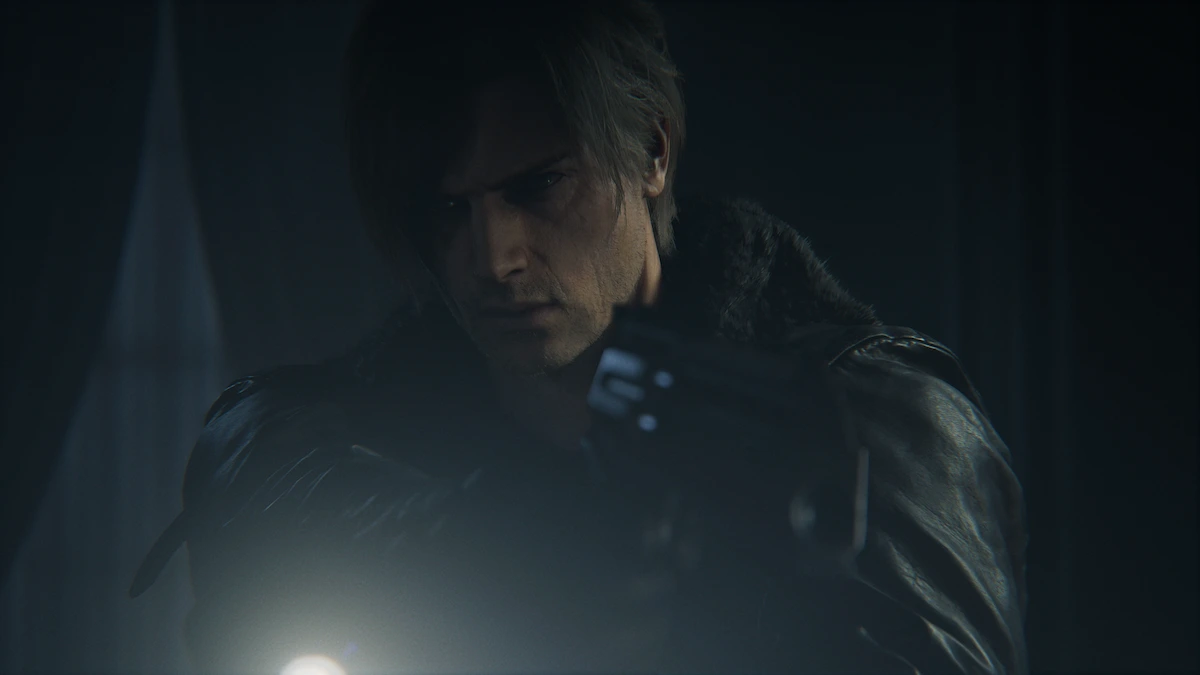























![Mondiale WRC 2026. Nel bene e nel male sarà stagione cruciale. Allora, vogliamo essere seri? [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48295138/1200x/si202510171702.jpg)































 Fonderie Ariotti S.p.a.-U88165282343aAr-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)



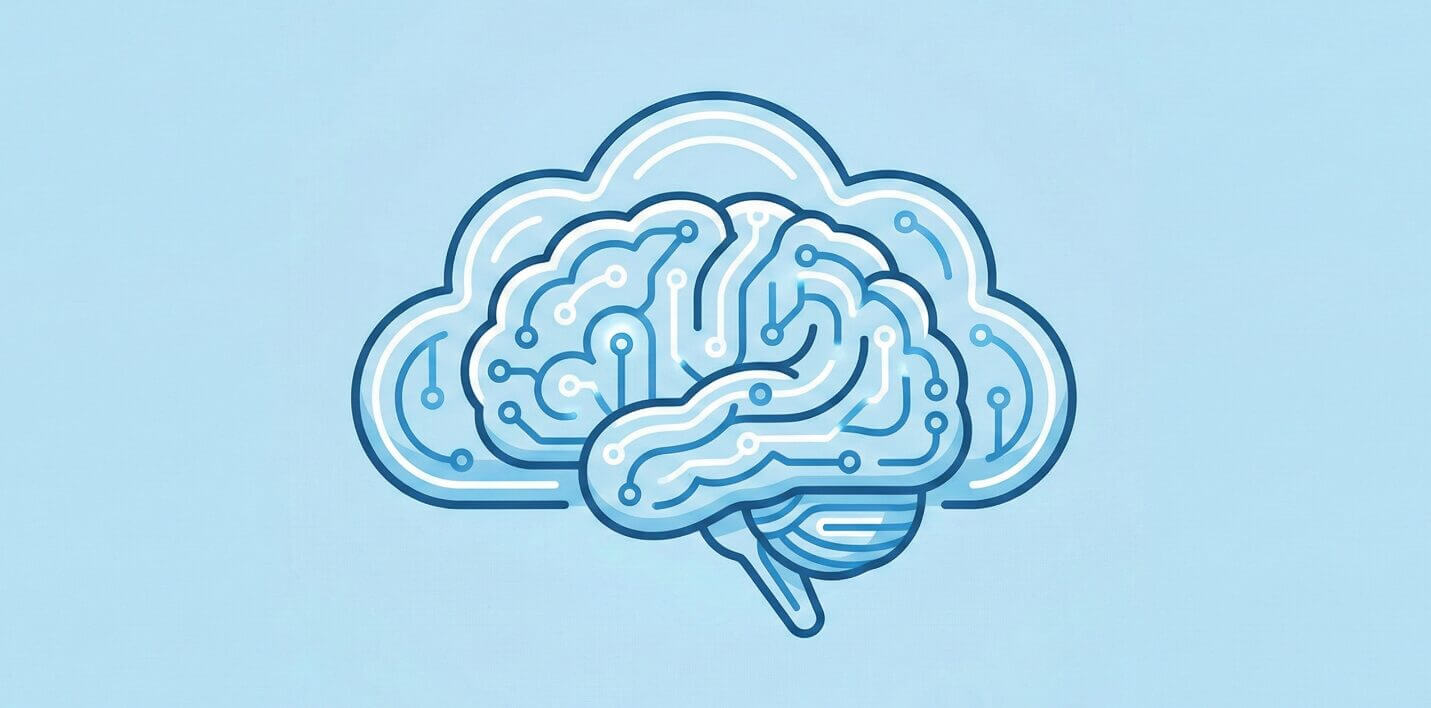









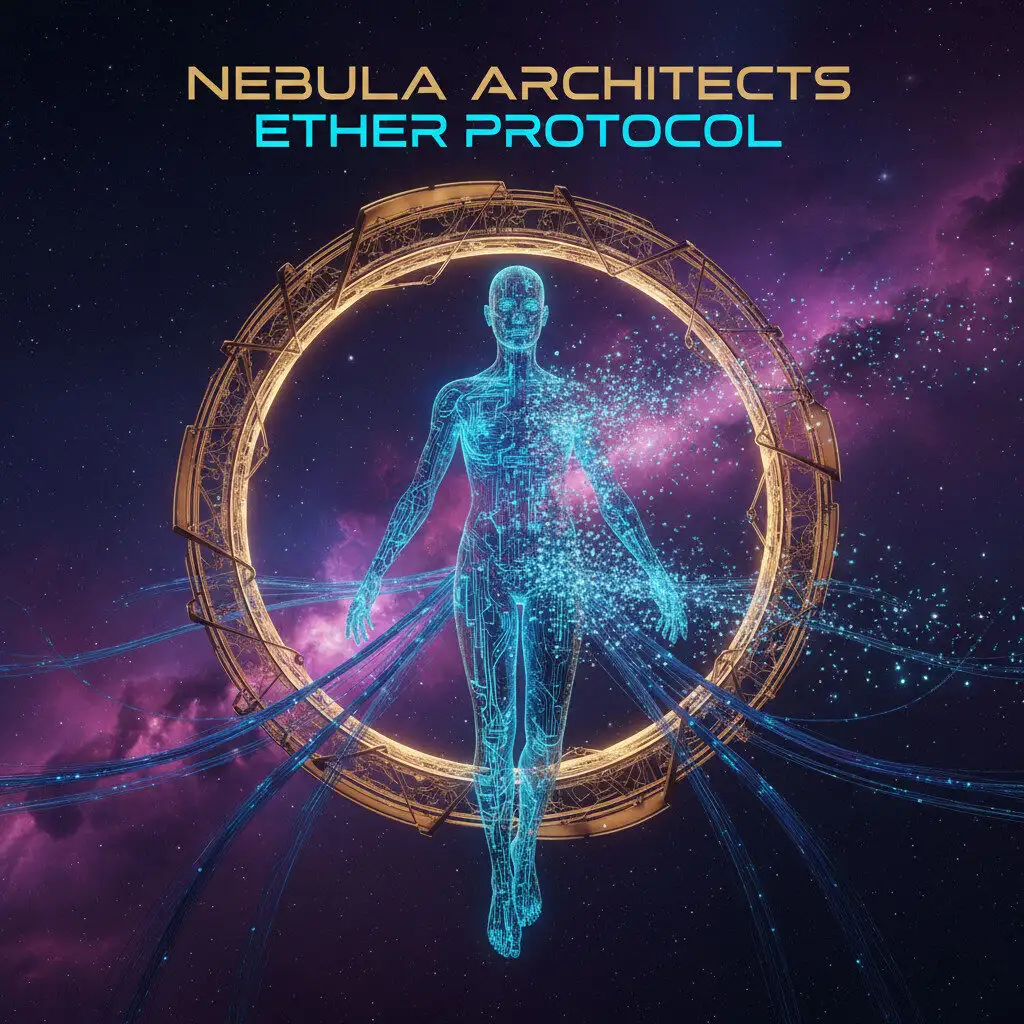



/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/offerte-attuale-coinbase-incredibile-approfittane-subito.jpg)























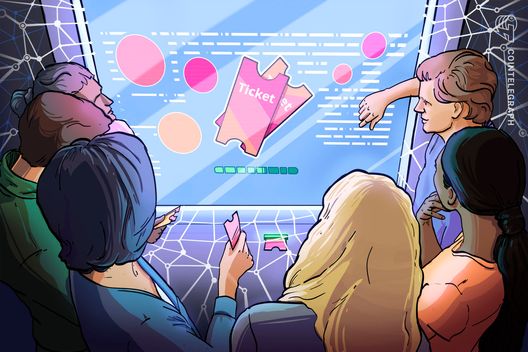




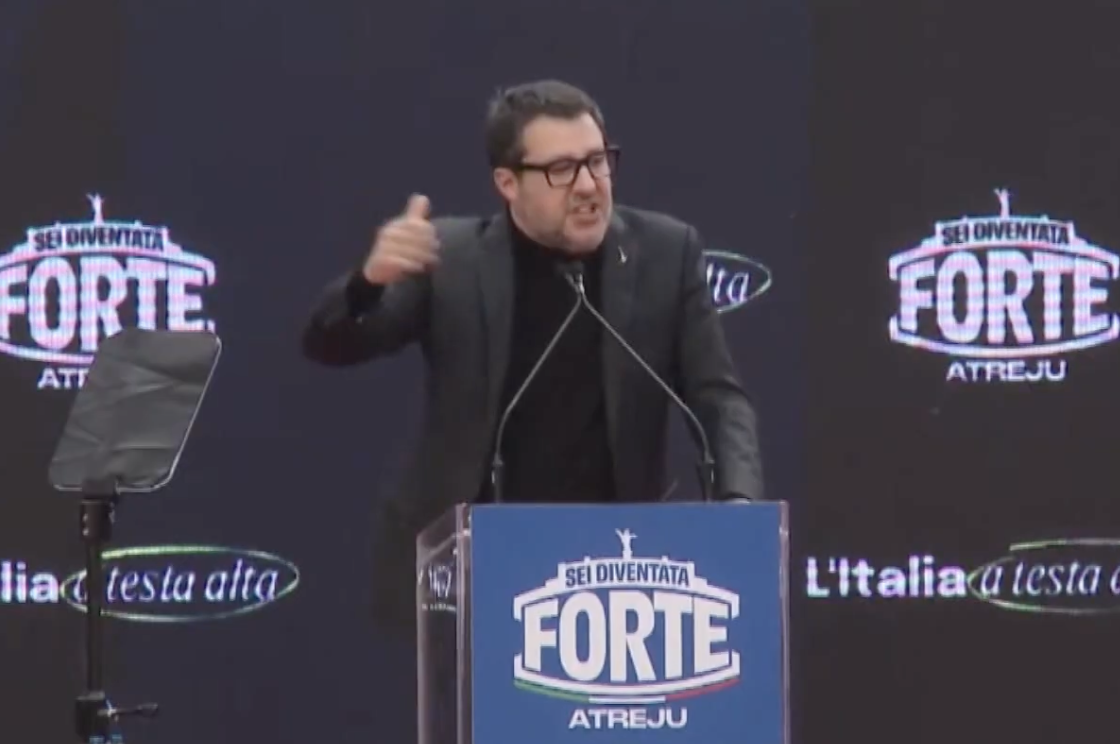












































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)