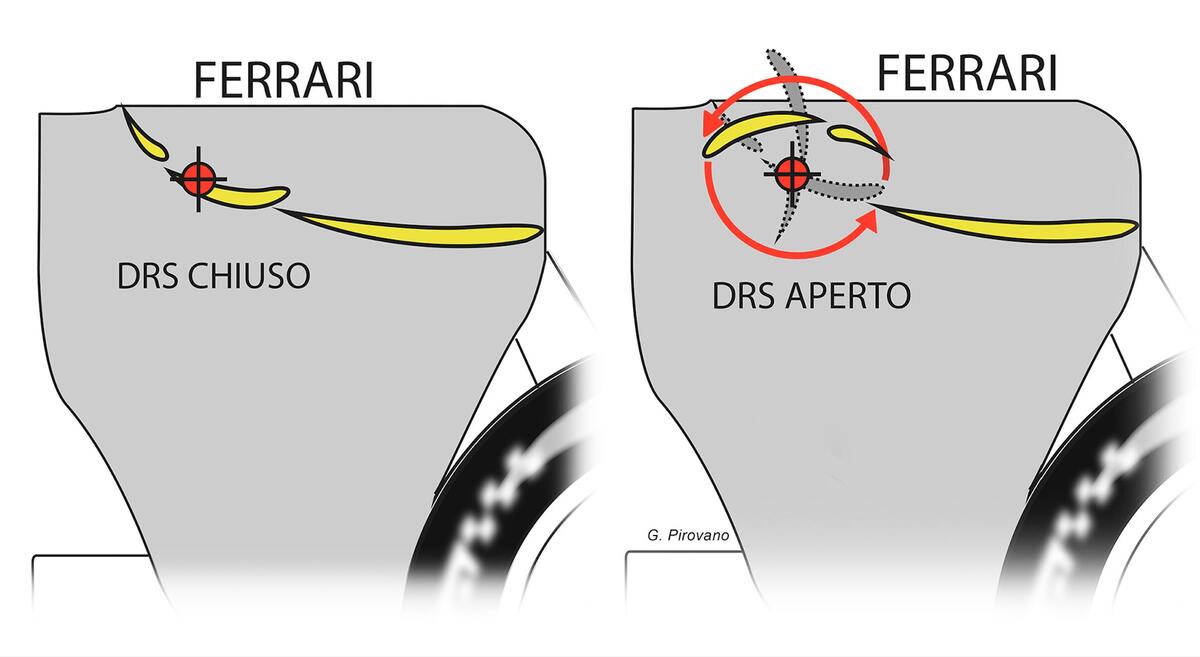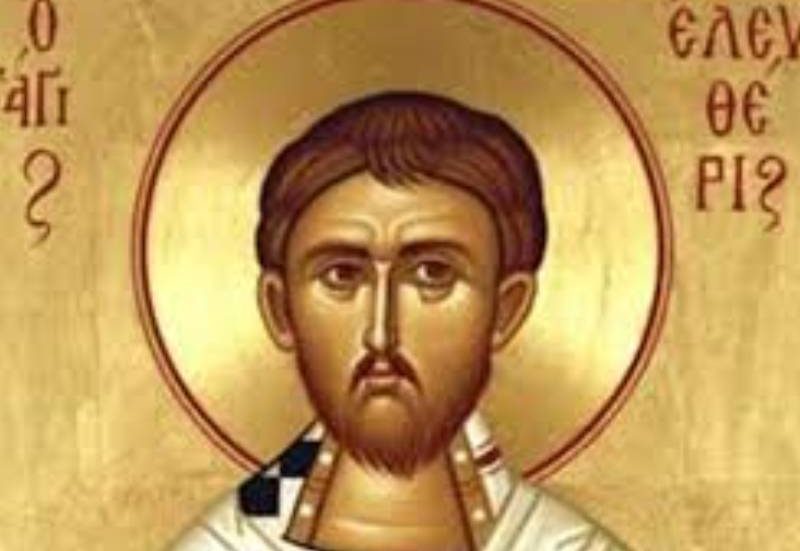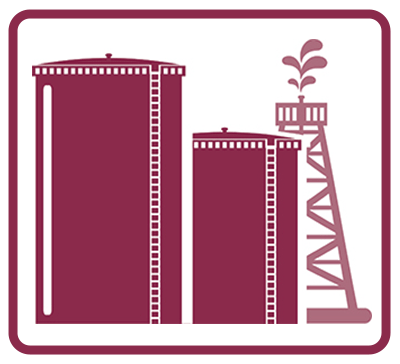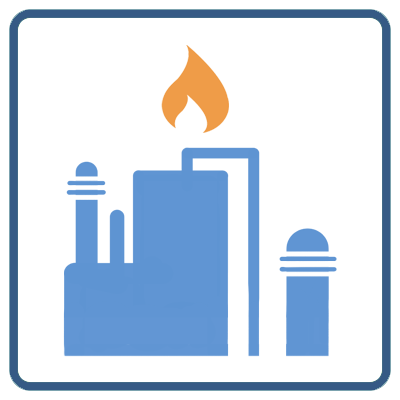I tagli di Bezos, la scoperta del bidet, e altre ragioni per cui la democrazia morirà per troppa luce


Di tutte le conferme che la vita è sceneggiatrice, non ne avevo ancora vista una così didascalica come il fatto che il disastro del Washington Post – in breve: trecento persone licenziate, la più clamorosa una giornalista che seguiva l’occupazione dell’Ucraina mentre si trova appunto in Ucraina, chissà se le hanno organizzato almeno un volo di ritorno – coincida col cinquantennale di “Tutti gli uomini del presidente”, uscito all’inizio d’aprile del 1976.
È colpa del fatto che il mondo di prima è finito, e non c’è nessuno disposto a prenderne atto, neanche i fantastiliardari che prima comprano i giornali e poi si rendono conto che i giornali sono sempre rotture di coglioni e mai profitti? È colpa di TikTok le cui informazioni la figlia di Leonardo Maria Del Vecchio troverà più che esaustive? È colpa della mistica del giornalismo e quindi anche di “Tutti gli uomini del presidente”? È colpa di “Rocky”? È colpa d’una candidata giapponese? È colpa dei democratici che si seccarono per il mancato editoriale di appoggio alla candidatura di Kamala Harris?
Partiamo da qui, dai duecentomila (così li quantificano i moltissimi articoli usciti sulla dismissione d’interi settori del WP) abbonamenti disdetti come protesta nell’autunno 2024, quando gli abbonati di sinistra presero l’editoriale cassato (già scritto ma non pubblicato per volontà dell’editore, un certo Jeff Bezos) per un segno che il loro giornale non gli assomigliava più.
L’altro giorno ho cliccato su un articolo del Post. Il Post di Milano, non quello di Washington. L’aveva linkato qualcuno per irriderlo, che è l’unico modo in cui mi passano davanti gli articoli del Post: l’algoritmo ha deciso che sono una da sarcasmo. In genere i miei contatti social infieriscono sull’accanimento con cui il Post milanese insegue ventenni confusi scrivendo frasi come «anche i corpi maschili possono partorire», e questo era un articolo di quel tipo.
Ogni volta penso che dovrei scrivere un pezzo dicendo va bene, sono d’accordo che sia una cosa ridicola, però è abbastanza da cinquenni anche pretendere che un giornale sia d’accordo con noi in tutto, su tutto, rispetto a tutto. Io non sono d’accordo neanche con tutte le idee mie, figuriamoci con tutte quelle di qualcun altro, figuriamoci con tutte quelle d’un giornale, cioè d’un prodotto fatto da un gruppo di persone.
Poi non lo scrivo mai, quel pezzo che dovrebbe difendere il Post milanese. Ma quel giorno ho cliccato sul loro articolo e, aprendolo, ho scoperto che al Post milanese avevano anche loro pensato che i lettori avessero bisogno di sentirsi ribadire questa ovvietà. In fondo all’articolo c’erano un po’ di righe che facevano così: «Ti capiterà di leggere anche sul Post una cosa che non ti piacerà, che ti farà arrabbiare o che ti farà pensare che il Post non la pensa come te. Sarà una buona notizia. Andrà bene così. Il Post serve anche a trovare pensieri e idee diverse, che ci aiutino a capire e inquadrare meglio le cose».
Beato il secolo in cui ai lettori adulti non tocca dire cose che dopo i dodici anni dovrebbero aver capito da soli. Beato il secolo in cui non ci sono duecentomila adulti che disdicono un abbonamento perché voi non avete fatto l’editoriale pro la candidata che piaceva a me e allora io non sono più amico vostro.
(La Bbc ha commissionato un sondaggio sulla disponibilità a fare amicizia con chi non la pensa come noi. Terribile, titolano i giornali inglesi: il 37 per cento dei ventenni non concepisce di chiacchierare con chi non condivide ogni sua idea. Non so, a me pare più preoccupante che lo stesso ottuso limite ce l’abbia il 21 per cento degli adulti. E, considerato che i sondaggi sono autocertificazioni, triplicherei il dato: no, non ci sono quattro adulti su cinque che non vedono l’ora di bersi una birra con chi la pensa in un altro modo, non nel 2026).
L’incipit migliore che abbia letto sui giornali recenti era giovedì sul Times di Londra, e faceva così: «Una giovane donna la ama perché “parla con grande chiarezza”. I suoi amici dicono che in lei ci si riconosce e che dà un’idea di vicinanza. A qualcuno piacciono le sue borse, a qualcuno le sue penne, a qualcuno il rituale con cui si strucca. Quando si tratta di Sanae Takaichi, primo ministro giapponese, tutti sanno dire come li fa sentire; ma quali siano le sue idee, e dove intenda portare il Giappone, è assai meno chiaro».
Ho idee che non condivido: certo che i giornali servono a dirmi che ci troviamo al punto in cui la regola è, cito il titolo del Times, “Come vincere le elezioni: parla chiaramente ma non dire niente”; ma, se l’elettorato vuole sapere che creme usi e che borse ti piacciono e quanto sei empatica, a cosa servono i giornali? Non basta davvero TikTok?
Ieri sul Venerdì di Repubblica c’erano tre tragiche righe che dicevano così: «Care lettrici e cari lettori, da due mesi abbiamo moltipicato la nostra presenza su Instagram. Vi ringraziamo della grande attenzione (visualizzazioni, like, repost) che ci dimostrate. Da questa settimana siamo anche su TikTok». Forse è sindrome di Stoccolma. Sarà curabile?
Mentre il Washington Post dismetteva, tra le altre, le pagine dello sport, i cronisti americani di altre testate davano il loro meglio dalle Olimpiadi invernali milanesi. Il loro meglio non esattamente nei termini di “Tutti gli uomini del presidente”, ma certamente in quello di visualizzazioni e repost (che hanno il minuscolo limite che portano fatturato ai proprietari delle piattaforme e non a quelli dei giornali).
La corrispondente della Cnn ha informato il suo pubblico del rito per cui gli italiani al bar non ordinano il cappuccino dopo mezzogiorno (una tenace leggenda americana chiaramente tesa a discriminare chi si sveglia tardi e a negargli l’ambita identità italiana). Quella d’una tv di Minneapolis ha fatto un video in cui diceva di non capire il funzionamento del bidet e chiedeva di spiegarglielo.
Non è solo che i contenuti giornalistici siano ormai identici a quelli prodotti dalle influencer: è che sono fatti per un pubblico evidentemente troppo scemo anche per l’internet. L’utente medio, se proprio ci tiene a lavarsi il culo, va a cercarsi un tutorial sul bidet (immagino abbondino), non chiede al pubblico delle testate giornalistiche di spiegargli come si faccia.
Il primo ministro inglese Starmer, scrive il corrispondente dal Giappone del Times, «se lo sogna il culto della personalità di cui gode Takaichi», e io penso a Dustin Hoffman e Robert Redford, i Bernstein e Woodward del cinema, e a cosa avrebbero detto d’un mondo che ha deciso di adeguarsi al ribasso: volete l’amabile carisma? E noi quello vi daremo, mica è compito nostro spiegarvi che i criteri per scegliere chi vi governa dovrebbero essere diversi da quelli con cui scegliere a che concerto andare.
La sceneggiatura di “Tutti gli uomini del Presidente” fu riscritta molte volte, intervennero Carl Bernstein e la sua allora fidanzata Nora Ephron, la cui versione fu cassata, e poi lo stesso Redford assieme al regista, Alan J. Pakula. Lo sceneggiatore ufficiale, William Goldman, raccontava di non aver mai riscritto niente così tante volte. L’obiezione era che c’erano troppe conversazioni brillanti e non abbastanza giornalismo investigativo. Sono abbastanza certa che oggi sarebbe considerata una sceneggiatura perfetta, quella scartata per eccesso di battutismo.
Potrebbe Jeff Bezos, che ha probabilmente un deposito di dobloni in cui nuota, continuare a finanziare un giornale in perdita senza licenziare nessuno e passare per eroe invece che licenziare trecento persone e passare per il cattivissimo trumpiano, nonostante i licenziamenti siano nei settori che meno danno fastidio a una qualsivoglia amministrazione politica (ha chiuso il dorso di recensioni di libri, cioè il genere di pubblicazione che interessa solo alla vanità degli scrittori)?
Certo che sì, ma forse non gliene importa niente. Non gli importa di imparare a vestirsi, o di fare delle vacanze non tamarre: perché gli dovrebbe importare di salvare il giornalismo, quel relitto novecentesco?
Come avete letto anche sul volantino delle offerte dell’Esselunga, lo slogan del Washington Post è storicamente «La democrazia muore nel buio», che a tutti gli altri che ne hanno scritto pare il modo perfetto di chiosare questi tempi. Non per dire sempre che tutti sono scemi e mancano il punto, ma: dove sarebbe, il buio? A me, non per citare Adriano Celentano, pare che il problema sia semmai che c’è troppa luce.
Abbiamo bisogno di meno informazioni, non di più. Sì, conosco l’obiezione: abbiamo bisogno di informazioni più selezionate. Ma, amici cui piace illudersi, ho una brutta notizia: dal rumore di fondo non si torna indietro. Il cittadino mediamente scemo una volta leggeva i giornali perché altrimenti non sapeva niente di niente, lavorava quattordici ore al giorno e sì e no aveva contezza di che giorno fossero le elezioni.
Il cittadino mediamente scemo di oggi passa quattro ore (magari fossero solo quattro) al giorno a spolliciare il telefono, ha un PhD ma sbaglia ad accentare i monosillabi, ed esercita un’attenzione da pesce rosso per cui già le card di Instagram da tre righe gli sembrano un trattato filosofico.
Nell’ipotesi dell’irrealtà in cui egli compri i giornali, ci trova il corrispondente dal Giappone del Times che definisce il predecessore della Takaichi «un uomo la cui scarsa familiarità con la crema idratante è disastrosa», e a quel punto dagli torto se torna a spolliciare qualche influencer di ricette vegane.
Non sto mica dicendo che la soluzione è tornare alle Tribune Politiche in bianco e nero. Non lo sto dicendo perché, come già detto, dal rumore di fondo non si torna indietro (e dall’instupidimento collettivo neanche). Ma soprattutto non lo sto dicendo perché non ho la soluzione. Non ce l’ha nessuno.
L’unico barlume di speranza, in quell’articolo sulle elezioni giapponesi, è la notizia che la penna da pochi euro con cui scrive la Takaichi è andata esaurita, mandando in tilt l’Amazon giapponese dove tutti cercavano di comprarla. Quindi c’è un elettorato in grado di scrivere a penna. Un’élite che ormai temo esista solo in Giappone, ma comunque un argine al fatto che nessuno sa più fare le cose più semplici, da leggere il corsivo a leggere l’ora su un orologio a lancette, e noi qui ce la meniamo con l’importanza dei reportage di guerra e delle pagine di politica estera. Non per citare due film interpretati da Redford e scritti da Goldman in un articolo solo, ma sembriamo Butch e Sundance preoccupati di affogare se si tuffano dalla cascata: fuori dal cinema, è la botta d’impatto che ci ammazza.
Su Netflix, il posto in cui questo secolo di analfabeti va a farsi spiegare la storia, c’è un documentario sugli anni Settanta nel cinema americano, s’intitola “Breakdown: 1975”. A un certo punto appare Martin Scorsese, e delimita i confini di quanto si sta raccontando: la demolizione del potere costituito, il cinema indipendente, la libertà autorale. Il momento in cui tutto finisce, dice Scorsese, è la fine di marzo del 1977.
Tra i candidati a miglior film c’è “Tutti gli uomini del presidente”, sì. C’è “Taxi driver”, sì. Ma soprattutto (il «soprattutto» è mio, non di Scorsese), c’è “Quinto potere”. L’Oscar come miglior film lo vince “Rocky”. «Quella è la sera in cui tutto finisce, basta», dice Scorsese. Il guaio di dover commentare la demolizione del Washington Post è che non disponiamo d’uno Scorsese: di qualcuno in grado di individuare esattamente quale sia la sera in cui è tutto finito. Ma che sia una sera che è già passata, beh, quello temo sia chiaro pure a Sylvester Stallone.
L'articolo I tagli di Bezos, la scoperta del bidet, e altre ragioni per cui la democrazia morirà per troppa luce proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0