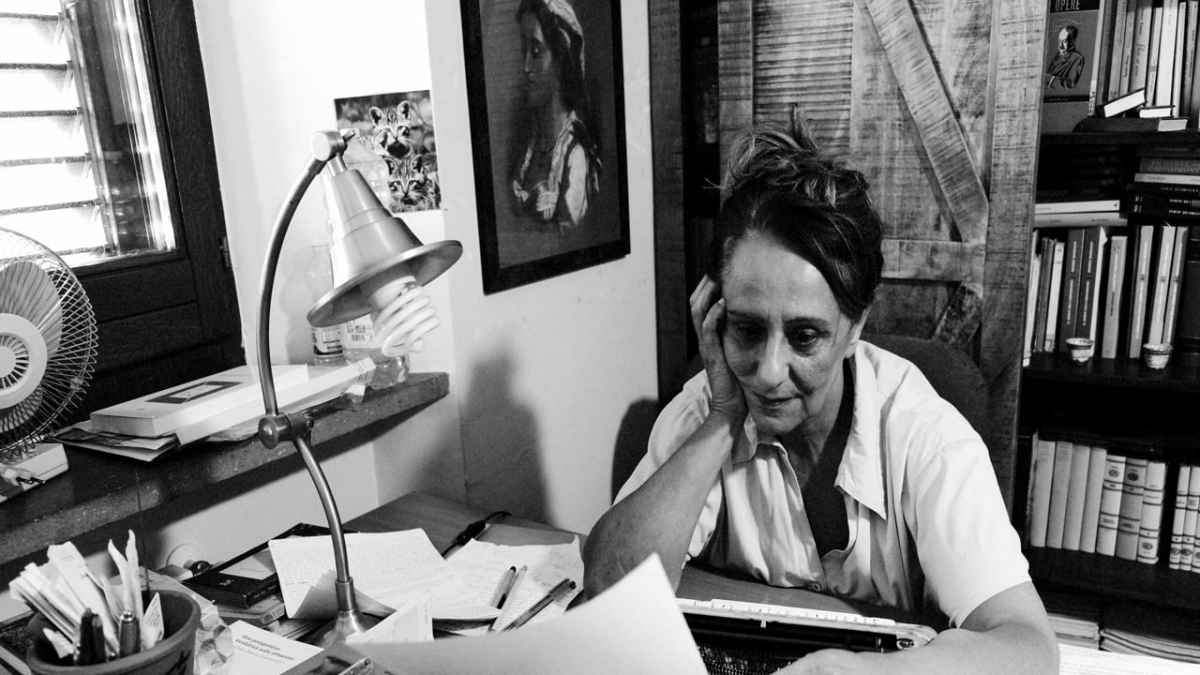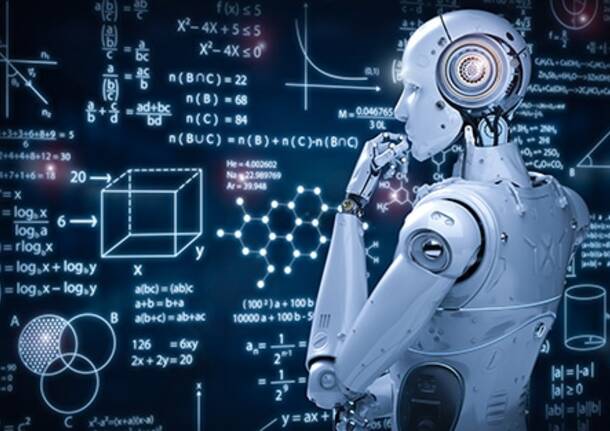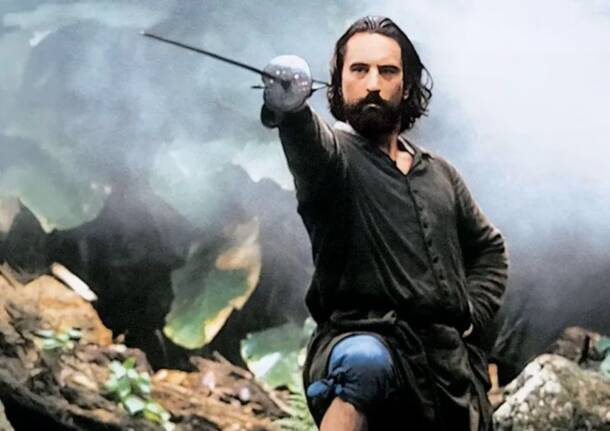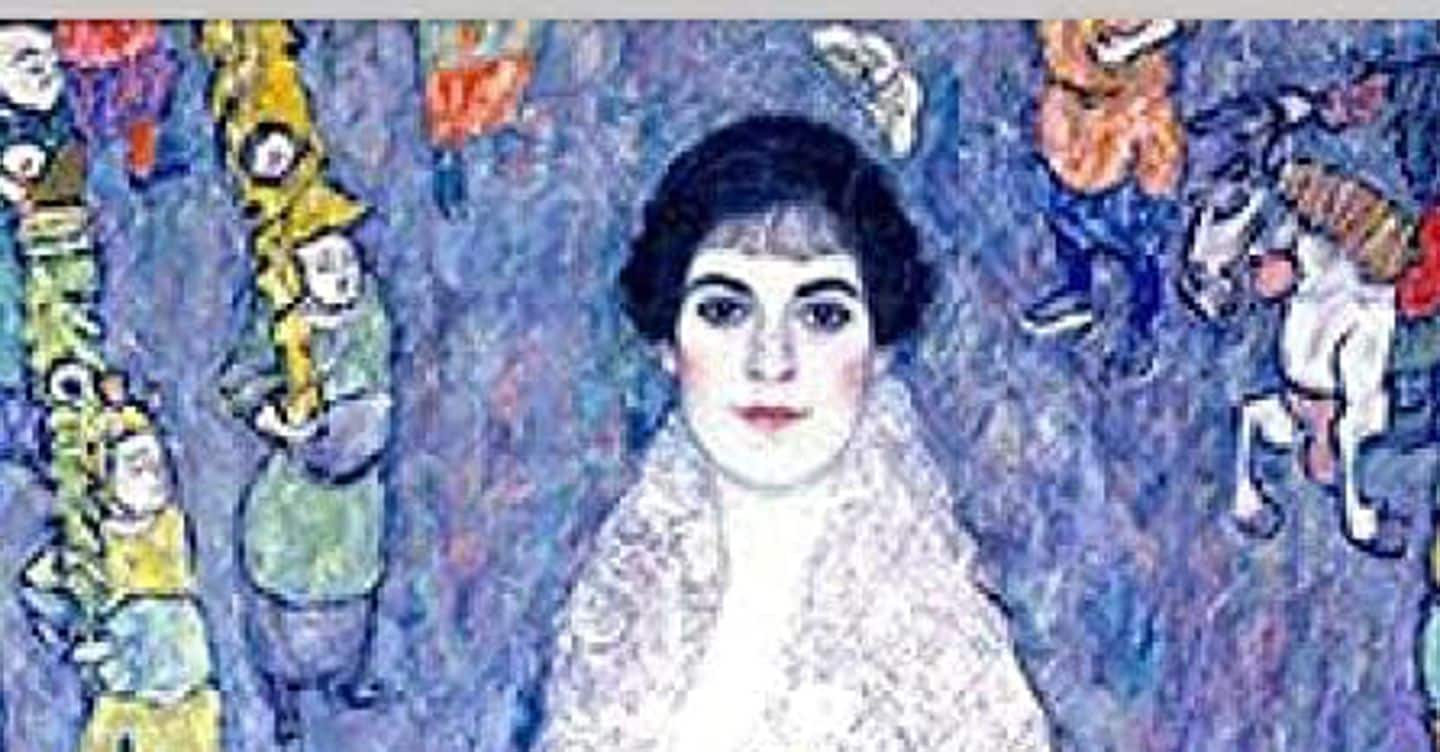La comunicazione ecclesiale è malata? Diagnosi senza sconti


Diagnosi di un paziente cronico (ma guaribile)
La comunicazione ecclesiale assomiglia spesso a un paziente con diverse patologie: nessuna incurabile, ma molte trascurate da troppo tempo. Alcune sono note e ammesse con un certo imbarazzo; altre emergono solo quando si decide di eseguire analisi più approfondite.
Il contesto in cui ci muoviamo, ormai radicalmente cambiato, ci interpella con forza: siamo davvero capaci di interpretare e vivere questo cambiamento? Martin Luther King ricordava che “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Vale anche – e forse soprattutto – per la comunicazione.
Comunicare come nel Medioevo
Se vogliamo essere onesti, il primo problema riguarda il “come” comunichiamo. Le nostre parrocchie si affidano ancora a modalità che potremmo definire senza eccessi… medioevali. Il banditore moderno coincide con gli avvisi letti alla fine della Messa; le pitture rupestri sono le locandine stampate e appese ovunque; il volantinaggio resta una delle strategie più usate.
Non è solo una questione di strumenti. È il modello stesso di comunicazione a essere superato: una logica unidirezionale, non targettizzata, costruita sull’idea che il mondo stia aspettando i nostri messaggi. Una comunicazione rivolta solo a chi è fisicamente presente, spesso confusa, disordinata e incapace di intercettare chi è “fuori”.
Lo sguardo dell’esterno: un rebus indecifrabile
Provare a mettersi nei panni di una persona esterna alle dinamiche ecclesiali è un esercizio rivelatore. Che cosa può capire realmente dei nostri messaggi? Quanta conoscenza presupponiamo senza rendercene conto? Troppo spesso sembra che non stiamo comunicando con il mondo, ma semplicemente ripassando ad alta voce la nostra agenda interna. Una comunicazione autoreferenziale, più orientata a chi già c’è che a chi potrebbe avvicinarsi.
Gli strumenti: un arsenale vecchio (e usato male)
La fotografia degli strumenti comunicativi parrocchiali è spesso (ma grazie a Dio non sempre) sconfortante:
– La bacheca, reliquia di tempi passati (spesso con notizie superate)
– l’informatore cartaceo, mensile o settimanale, che funziona solo se uno sa dove trovarlo
– un sito web aggiornato – forse – nell’ultimo anno (ancora vedo foto in apertura di siti parrocchiali con le foto di epoca covid … )
– una pagina Facebook che resiste per inerzia come copia incolla delle locandine parrocchiali
– un profilo Instagram raramente curato, attivo principalmente nel periodo estivo
– un canale YouTube bloccato al periodo post-lockdown o usato solo per trasmettere le Messe
– una segreteria parrocchiale dai contorni quasi leggendari, se non si conoscono orari e riferimenti
– e infine l’universo parallelo dei gruppi WhatsApp: decine, centinaia, spesso inutili, terreno fertile per i peggiori “buongiornissimo caffè”.
Una costellazione di strumenti che, invece di facilitare, spesso complica. E soprattutto rischia di non parlare davvero alle persone che vorremmo raggiungere.
Sia chiaro non si vuole generalizzare ma guardare con un sano realismo alle tantissime energie che impieghiamo per tenere in vita strumenti spesso non coordinati e alle volte decisamente da ripensare e rivedere.
Conclusione – Verso una cura possibile
Questa è solo la fotografia della situazione, la diagnosi iniziale. Non è un atto d’accusa, ma un atto di realismo: riconoscere i problemi è il primo passo per poterli affrontare.
Nel prossimo articolo proveremo a individuare la cura e la terapia: come può la comunicazione ecclesiale diventare finalmente efficace, accogliente e comprensibile per tutti?
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
Articoli correlati
“Gesù camminava davanti a tutti”: Mons. Angelo Spina co...
Redazione Eventi e... Novembre 20, 2025 0



































![Formula 1. Il Gran Premio di Las Vegas è a rischio? Allerta meteo e pista allagata [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/47936018/1200x/las-vegas-ansa.jpg)


















































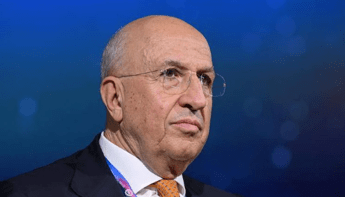


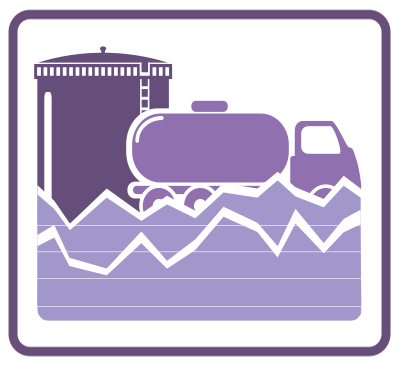
























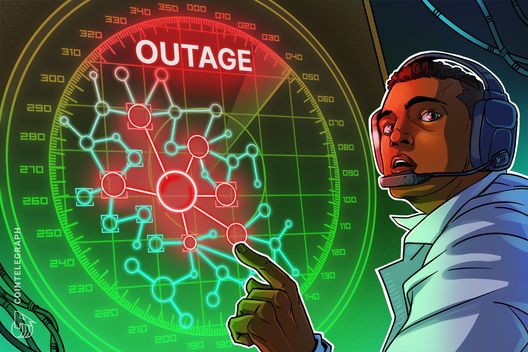
















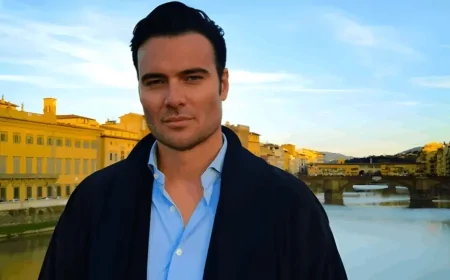




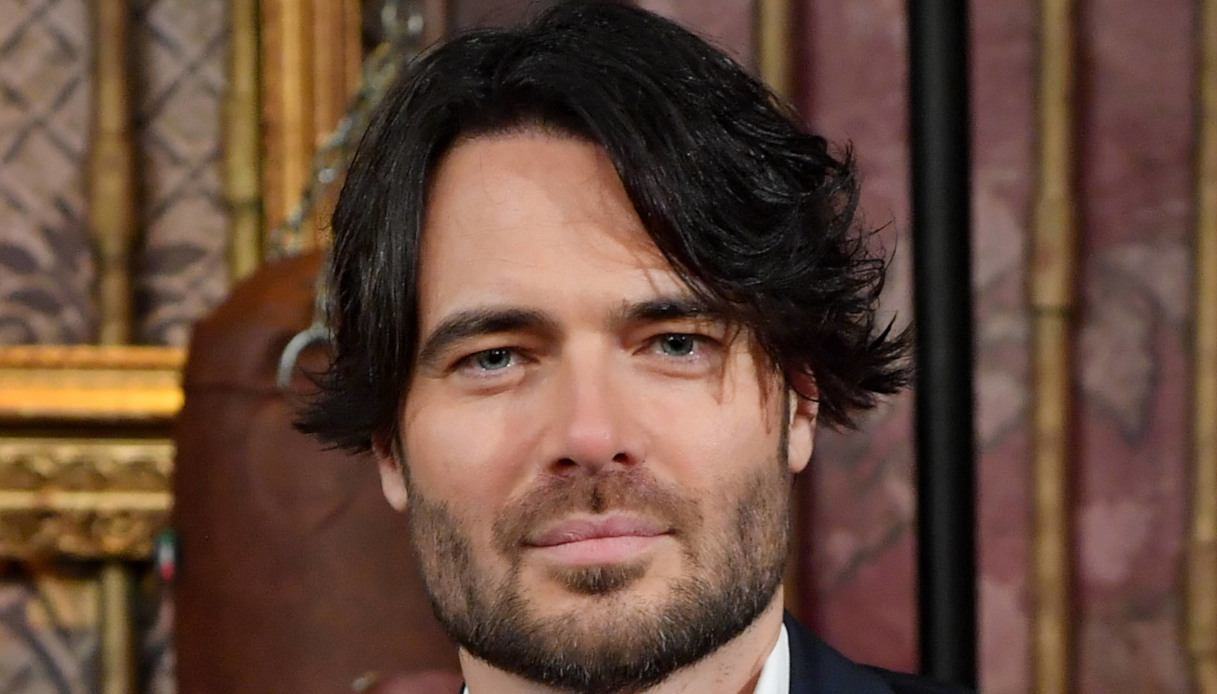




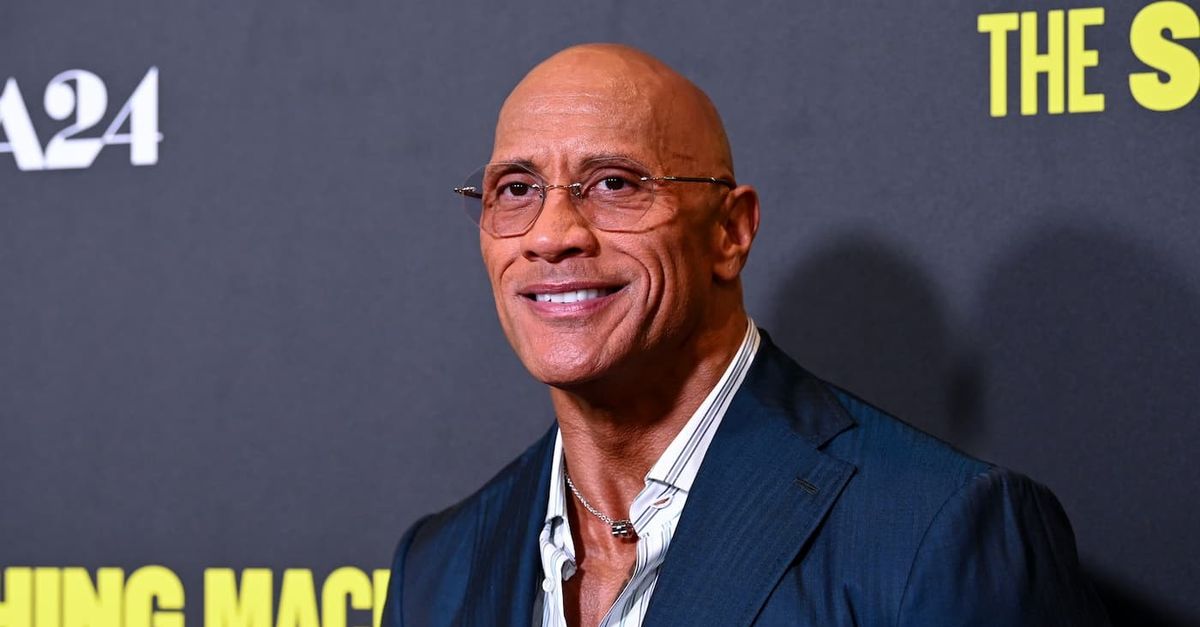
















































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)