La cicatrice che si riapre con un nuovo dolore: sintomo allarmante da non sottovalutare

La cicatrice che si riapre potrebbe essere sintomo di una neoplasia, caratterizzata da una proliferazione anomala delle cellule squamose.
Il carcinoma spinocellulare origina dalle cellule squamose, che costituiscono uno dei principali tipi cellulari presenti nello strato superficiale della pelle, l’epidermide. Queste cellule, di forma piatta, svolgono un ruolo fondamentale nel rinnovamento cutaneo e sono soggette a continui processi di rigenerazione. Tuttavia, l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti (UV) e ad altri agenti nocivi può causare danni al DNA di queste cellule, provocandone mutazioni che determinano una crescita incontrollata e disordinata, alla base dello sviluppo del carcinoma.
Dal punto di vista clinico, l’SCC si presenta con una varietà di manifestazioni cutanee che includono lesioni eritematose squamose, ulcerazioni non guarenti, formazioni ispessite e ruvide simili a verruche, noduli con ulcerazioni centrali e, talvolta, croste con prurito o sanguinamento. Queste lesioni compaiono prevalentemente nelle aree cutanee più esposte al sole, come viso, labbra, cuoio capelluto, orecchie, mani e avambracci, ma possono altresì manifestarsi in zone meno esposte o addirittura genitali.
È fondamentale sottolineare che la presentazione clinica può variare significativamente da paziente a paziente, e una mancata o ritardata diagnosi può portare a complicanze gravi, quali l’invasione locale profonda e la metastatizzazione a distanza, fattori che aumentano notevolmente la mortalità associata a questa patologia.
Epidemiologia e fattori di rischio
Il carcinoma spinocellulare rappresenta circa il 20% dei tumori cutanei non melanomatosi, mentre il restante 80% è costituito principalmente da carcinomi basocellulari. L’incidenza di SCC è maggiore nelle persone di fototipo chiaro, caratterizzate da una scarsa protezione naturale verso i raggi UV dovuta a bassi livelli di melanina. In Italia, si calcolano circa 22-23 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno, con una prevalenza più elevata nei soggetti di età superiore ai 60 anni, particolarmente di sesso maschile.
Tra i principali fattori di rischio spiccano:
- Esposizione prolungata e non protetta ai raggi UV del sole e alle lampade abbronzanti, che rappresentano la causa principale della mutazione del DNA e dell’insorgenza del tumore.
- Pelle chiara, capelli biondi o rossi e occhi chiari, che aumentano la suscettibilità ai danni solari.
- Storia di scottature solari gravi, soprattutto nell’infanzia e adolescenza, che incrementa il rischio in età adulta.
- Lesioni cutanee precancerose, come la cheratosi attinica e la malattia di Bowen, che possono evolvere in carcinoma squamoso.
- Sistema immunitario compromesso, come nei pazienti trapiantati o con patologie ematologiche, che presentano un rischio fino a 100 volte superiore rispetto alla popolazione generale.
- Infezioni da papillomavirus umano (HPV), in particolare quelle genitali, associate all’insorgenza di carcinoma squamoso in sedi non fotoesposte.
- Presenza di cicatrici o ferite croniche, come ustioni o ulcere non guarite, che possono trasformarsi in lesioni tumorali.
Altri fattori meno comuni includono condizioni genetiche rare come lo xeroderma pigmentoso, che determina una elevata fotosensibilità e un rischio elevatissimo di carcinomi cutanei.
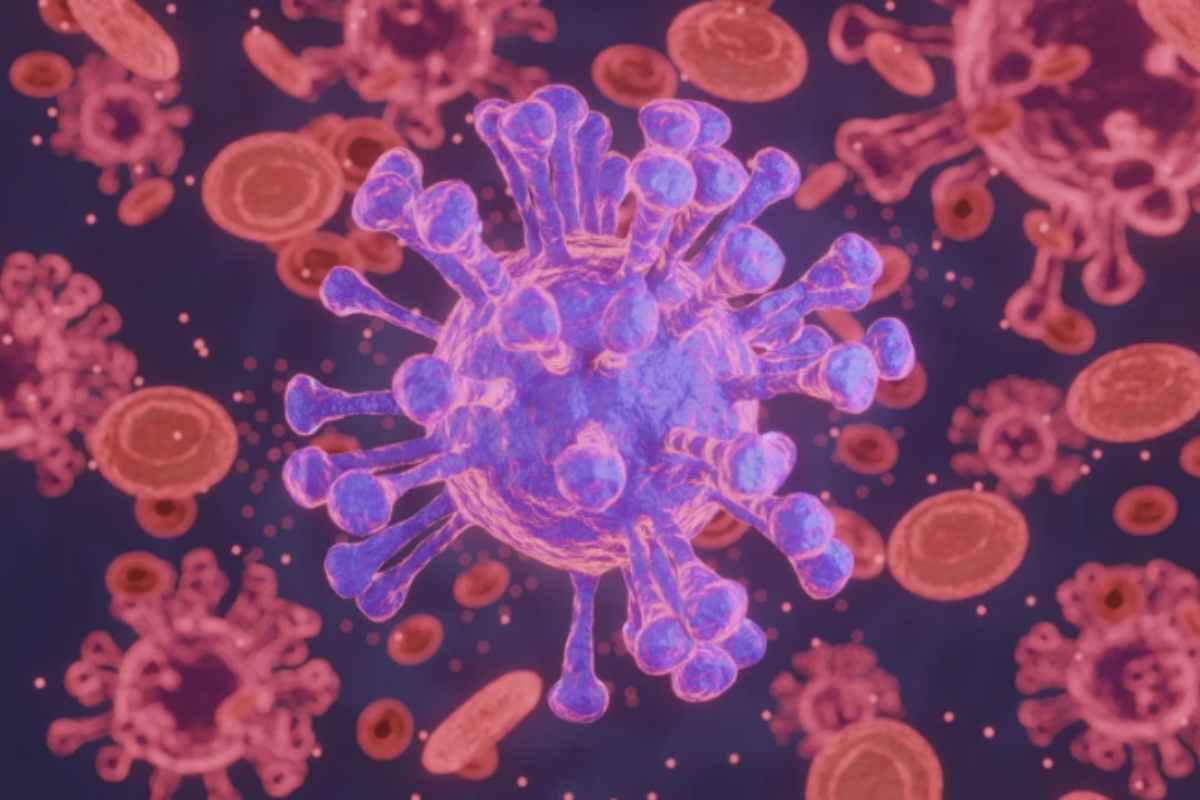
La diagnosi di carcinoma spinocellulare si basa innanzitutto sull’esame clinico accurato della pelle da parte dello specialista dermatologo, che valuta la presenza di lesioni sospette, analizzandone forma, dimensioni, colore e consistenza. In seguito, la conferma diagnostica avviene mediante biopsia cutanea, con diverse tecniche quali raschiamento, biopsia incisionale o escissionale, che permettono l’analisi istologica delle cellule per accertare la natura maligna.
Per la stadiazione e la valutazione dell’eventuale diffusione metastatica, soprattutto in caso di tumori di grandi dimensioni o localizzati in sedi ad alto rischio, si possono eseguire esami di imaging come la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RM) e, se necessario, la biopsia dei linfonodi regionali.
Il trattamento dipende dallo stadio della malattia e dal rischio di recidiva, valutato in base a dimensioni, localizzazione, grado di differenziazione cellulare e stato immunitario del paziente. Le opzioni terapeutiche includono:
- Chirurgia: l’escissione completa con margini di sicurezza rappresenta il trattamento di prima scelta. In casi selezionati, la chirurgia di Mohs consente una rimozione precisa e minimamente invasiva, particolarmente utile nei tumori ad alto rischio o localizzati in aree delicate.
- Radioterapia: indicata per tumori voluminosi o in sedi difficilmente operabili, oppure come trattamento adiuvante in presenza di margini chirurgici positivi o metastasi linfonodali.
- Crioterapia: utilizzata in lesioni iniziali o in pazienti non candidabili a intervento chirurgico.
- Terapie sistemiche: per forme avanzate o metastatiche, si impiegano farmaci immunoterapici come gli inibitori di PD-1 (es. cemiplimab, pembrolizumab) che potenziano la risposta immunitaria contro il tumore. La chemioterapia tradizionale ha un ruolo limitato e viene riservata a casi selezionati.
L'articolo La cicatrice che si riapre con un nuovo dolore: sintomo allarmante da non sottovalutare proviene da Blitz quotidiano.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0



















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/paypal-promuove-pagamenti-stablecoin.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/07/hype-logo-1.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/approfitta-2-percento-interesse-trade-republic-nessun-vincolo-solo-vantaggi.jpg)
























































































.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































