John Philip Kemble: l’arte tragica tra classicismo e rivoluzione teatrale

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, l’Inghilterra visse un momento di straordinaria trasformazione culturale. Il teatro, che da secoli era il cuore pulsante della vita artistica britannica, stava attraversando un passaggio cruciale: dal gusto classico e formale del Settecento alla passione e al pathos del Romanticismo. In questa transizione si staglia la figura di John Philip Kemble (1757–1823), attore, direttore e riformatore, la cui carriera definì nuovi standard di eleganza, compostezza e disciplina scenica. Fratello della celebre attrice Sarah Siddons, Kemble incarnò un ideale di recitazione sobria e intellettuale, lontana dagli eccessi emotivi ma ricca di gravità morale e perfezione formale. Il suo debutto come Amleto nel 1783 al Theatre Royal Drury Lane di Londra segnò non solo l’inizio di una carriera straordinaria, ma anche la nascita di una nuova idea di “attore tragico” nel panorama britannico.
Le origini e la formazione di un attore d’altri tempi
John Philip Kemble nacque il 1º febbraio 1757 a Prescot, nel Lancashire, in una famiglia che viveva di teatro. Suo padre, Roger Kemble, era il manager di una compagnia itinerante, i Warwickshire Comedians, che portava gli spettacoli da una città all’altra dell’Inghilterra provinciale. Quell’ambiente teatrale ambulante, fatto di scenografie smontabili e ruoli improvvisati, plasmò sin da subito la sensibilità artistica del giovane John, ma i genitori — cattolici devoti — avevano in mente per lui un futuro diverso. Il padre lo inviò infatti al collegio inglese di Douai, in Francia, per avviarlo alla vita religiosa.

Proprio a Douai, tuttavia, Kemble scoprì una passione irresistibile per la declamazione e per i testi classici. Le ore trascorse a leggere Orazio, Seneca e Sofocle lo avvicinarono all’arte drammatica da una prospettiva colta, più analitica che istintiva. Questo legame tra teatro e cultura classica lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera, distinguendolo dai colleghi più “naturali” e istintivi. Secondo il Dictionary of National Biography dell’Ottocento, Kemble sviluppò in quegli anni un’eccezionale memoria e una dizione quasi musicale, qualità che divennero la sua firma sulla scena.
Dopo aver lasciato Douai senza prendere i voti, tornò in Inghilterra deciso a seguire la vocazione teatrale. Fece il suo debutto nel 1776 a Wolverhampton, interpretando Theodosius di Nathaniel Lee, e poco dopo entrò nella compagnia di Tate Wilkinson, uno dei più autorevoli impresari provinciali dell’epoca. Per quasi sette anni si formò sul campo, affrontando tragedie classiche e ruoli complessi che gli consentirono di affinare una recitazione misurata e controllata. La Royal Shakespeare Company odierna riconosce in questi anni il periodo in cui Kemble maturò il suo stile “scultoreo”, destinato a influenzare generazioni di attori successivi (Royal Shakespeare Company).
La consacrazione giunse con il debutto irlandese a Dublino nel 1781, dove interpretò Amleto. Fu il preludio al trionfo londinese: il 30 settembre 1783, al Theatre Royal Drury Lane, Kemble calcò per la prima volta il palcoscenico della capitale nel ruolo del principe di Danimarca. Il pubblico londinese, abituato alla potenza emotiva di attori come David Garrick, si trovò di fronte a qualcosa di completamente diverso: un Amleto composto, intellettuale, quasi scultoreo nella sua immobilità.

Le cronache raccontano che la recitazione di Kemble fosse lenta, quasi ieratica, con pause calcolate che davano al monologo una maestosa solennità. Alcuni critici, come James Boaden, suo biografo e amico, sottolinearono la “dignità romana” della sua interpretazione; altri, più impazienti, lamentarono una freddezza eccessiva. Eppure, anche i detrattori riconoscevano che il suo modo di recitare inaugurava un linguaggio teatrale nuovo, più consapevole, più vicino a un rito che a una semplice rappresentazione.
Il Theatre Royal Drury Lane era allora uno dei centri nevralgici della cultura britannica. Gestito da Richard Brinsley Sheridan, autore di The School for Scandal, ospitava il meglio della scena inglese. Esibirsi lì significava ottenere il riconoscimento definitivo, e Kemble seppe conquistarselo con disciplina ferrea. Si dice che passasse ore a studiare i versi, provando da solo le inflessioni della voce fino a trovare la modulazione perfetta. In un’epoca in cui molti attori improvvisavano o adattavano le battute, Kemble seguiva il testo con rigore quasi filologico, un atteggiamento che lo avvicinava più a un interprete musicale che a un recitante tradizionale.
La critica moderna, come quella della Royal Society of Literature, ha rivalutato il suo contributo alla professionalizzazione del mestiere d’attore (Royal Society of Literature). La sua attenzione ai costumi, alla gestualità e al contesto storico dei personaggi anticipò infatti le riforme ottocentesche di realismo scenico. Kemble riteneva che un costume dovesse “parlare” tanto quanto le parole: per Amleto, abbandonò l’abbigliamento elisabettiano in favore di un mantello scuro e linee severe, coerenti con la malinconia del principe. Questa ricerca di coerenza visiva e concettuale segnò una svolta nella direzione teatrale britannica.
Al di là del palcoscenico, John Philip Kemble era noto per la sua compostezza nella vita privata. Nonostante il successo, conduceva un’esistenza ordinata, lontana dagli scandali che spesso circondavano gli attori del tempo. Era un uomo di studi, con una biblioteca personale di oltre quattromila volumi, molti dei quali dedicati alla storia romana e alla tragedia greca. La sua passione per Cicerone e per la retorica antica traspare nelle sue lettere, dove descriveva l’attore ideale come “un sacerdote del sentimento umano, non il suo schiavo”.
Questo rigore gli attirò anche accuse di freddezza. Quando nel 1783 apparve come Amleto, il pubblico londinese si trovò di fronte a un principe più filosofo che folle. L’introspezione prevaleva sull’emozione, la misura sulla furia. Ma nel clima intellettuale dell’Illuminismo britannico, quella sobrietà aveva un valore morale: Kemble incarnava la razionalità dell’uomo che riflette sull’abisso, non che vi precipita. Era, in fondo, l’Amleto che poteva nascere solo nella Londra di fine Settecento, una città divisa tra ragione e sentimento, tra la compostezza classica e la tempesta romantica che si stava annunciando.
Il trionfo con Sarah Siddons e la riforma del teatro britannico
Dopo il debutto londinese, John Philip Kemble si impose rapidamente come figura centrale della scena drammatica. Ma la vera consacrazione arrivò grazie all’incontro scenico con sua sorella Sarah Siddons, la più acclamata attrice tragica del suo tempo. Insieme formarono una delle coppie artistiche più leggendarie della storia del teatro inglese, un sodalizio che univa l’intensità emotiva della Siddons alla misura e alla maestosità di Kemble. Il loro primo grande successo congiunto avvenne nel 1785 con Macbeth al Drury Lane Theatre: lui nel ruolo del tormentato generale, lei in quello di Lady Macbeth. Lo spettacolo fece scalpore per la sua coerenza drammatica e per la novità del registro interpretativo, fondato su un equilibrio tra gesto, voce e significato morale. La British Library conserva ancora recensioni dell’epoca che lodano “la gravità sublime” dei due fratelli, definiti “i veri eredi di Garrick, ma più vicini ai Greci che agli inglesi” (British Library).

La recitazione di Kemble, tuttavia, si discostava profondamente da quella del suo predecessore David Garrick. Dove Garrick aveva portato in scena la naturalezza, Kemble introdusse la maestà del controllo. Ogni movimento era studiato, ogni inflessione ponderata. Il suo Macbeth non esplodeva di rimorsi violenti ma si consumava in un lento declino morale, scandito da silenzi e da gesti carichi di gravità. Allo stesso modo, il suo Bruto nel Giulio Cesare era una figura di dignità politica più che di passione tragica. In lui, l’arte dell’attore diventava architettura: una costruzione morale, un tempio di parole e gesti.
Questo rigore formale trovò espressione anche nella sua visione di riformatore teatrale. Nel 1788, Kemble assunse la direzione del Theatre Royal Drury Lane, con l’obiettivo di elevare la qualità artistica e morale del teatro britannico. Era convinto che l’attore dovesse essere un intellettuale, non un istrione, e che lo spettacolo dovesse educare il pubblico oltre che intrattenerlo. Introdusse così nuove regole: prove più lunghe e disciplinate, attenzione ai costumi storici, ricerca di verosimiglianza nei dettagli scenici. Ogni tragedia doveva essere ambientata nel suo contesto storico e visivo esatto. Se si rappresentava Coriolano, gli attori indossavano armature romane; se Amleto, abiti scandinavi austeri. Queste scelte — che oggi sembrano scontate — erano rivoluzionarie in un’epoca in cui si usavano costumi generici e riciclati da un ruolo all’altro.
L’attenzione maniacale di Kemble per la scenografia e la mise-en-scène rifletteva il suo spirito di studioso. Nella biblioteca personale, consultava testi di storia antica, cronache, incisioni e dipinti per ricostruire ogni dettaglio. Collaborò con pittori come Philippe de Loutherbourg, celebre scenografo, per creare sfondi e luci capaci di suggerire atmosfera e profondità. Per la prima volta, la scena teatrale britannica si avvicinava a una forma di arte totale, in cui parola, gesto e immagine dialogavano armonicamente.
Il pubblico londinese, però, non sempre accoglieva queste innovazioni con entusiasmo. Molti spettatori trovavano che le rappresentazioni fossero troppo “studiate”, troppo lente rispetto alle abitudini del teatro settecentesco, ancora legato alla rapidità della farsa e al brio dell’improvvisazione. Ma tra gli intellettuali e i critici più raffinati, Kemble veniva considerato un maestro di stile. Lo scrittore Charles Lamb lo definì “una statua che parla”, intendendo con ciò non un difetto, ma una virtù: la capacità di dare voce all’eternità del gesto umano.

Durante la sua direzione al Drury Lane, Kemble introdusse anche nuove forme di collaborazione professionale. Pretese contratti scritti, orari di prove regolari e rispetto gerarchico verso i ruoli di regia e scenografia. Tali innovazioni, oggi alla base della gestione teatrale, allora segnarono una svolta. In un teatro ancora dominato da attori-manager carismatici e caotici, Kemble impose disciplina e metodo. Ma la convivenza con Richard Brinsley Sheridan, proprietario del teatro e autore brillante, si rivelò difficile: Sheridan puntava a un teatro popolare, satirico, capace di riempire le sale; Kemble cercava invece un’arte alta, morale, quasi sacerdotale. La loro divergenza culminò nel 1802, quando Kemble lasciò il Drury Lane per assumere la direzione del Covent Garden Theatre, acquistandone una parte insieme a un gruppo di investitori.
Il Covent Garden divenne così la sua seconda casa, il laboratorio della maturità. Qui poté dare pieno sfogo alle sue idee di riforma. Le produzioni erano sontuose, curate nei minimi particolari, e la collaborazione con Sarah Siddons raggiunse l’apice. Le rappresentazioni di Coriolano, Cato, The Roman Father e King John furono acclamate come esempi di perfezione visiva e oratoria. Gli spettatori ammiravano la postura eretta, il volto immobile, la voce profonda e scolpita, la lentezza solenne con cui pronunciava ogni verso. Anche quando interpretava personaggi di tormento, come Amleto o Macbeth, Kemble non cedeva mai alla dismisura: il dolore si faceva forma, la tragedia diventava pensiero.
Nel 1808, però, il destino lo colpì duramente. Un incendio distrusse il Covent Garden Theatre, riducendo in cenere anni di lavoro. Kemble, con il sostegno del Duca di Northumberland, ricostruì il teatro nel giro di un anno, ma la riapertura segnò anche l’inizio di una delle crisi più celebri della storia teatrale britannica: le Old Price Riots. Per recuperare le perdite economiche, Kemble aumentò i prezzi dei biglietti, scatenando la rabbia del pubblico popolare. Per più di sessanta sere consecutive, le rappresentazioni furono interrotte da fischi, cori e proteste che paralizzarono Londra. Il teatro divenne campo di battaglia tra élite e pubblico, tra l’idea di arte come privilegio e quella di arte come diritto comune.
Kemble, coerente con il suo temperamento aristocratico, rifiutò per settimane di cedere, ma alla fine dovette tornare sui suoi passi. Il conflitto lasciò però un segno indelebile nella sua figura pubblica: da eroe tragico era diventato simbolo di distacco sociale. Tuttavia, la vicenda non ridusse il suo prestigio artistico. Le sue interpretazioni successive di Coriolano e Bruto sono ancora ricordate come apici di perfezione stilistica, tanto che William Hazlitt, uno dei critici più influenti dell’epoca, scrisse: “Kemble non interpreta: incarna la dignità del pensiero. È il teatro stesso, nella sua forma più pura.”
La fine del periodo di Covent Garden coincise con l’inizio del declino personale. L’energia che aveva sostenuto vent’anni di recitazione e direzione cominciava a spegnersi. Nel 1817, Kemble annunciò il ritiro dalle scene, scegliendo come ultimo ruolo Coriolano — il personaggio che meglio rappresentava la sua idea di nobiltà tragica. La sera del 23 giugno, quando pronunciò le ultime battute tra applausi interminabili, molti compresero che si chiudeva un’epoca: l’epoca del teatro classico, del gesto ponderato, della tragedia come architettura morale.
L’eredità di John Philip Kemble e la nascita del “tragico moderno”
Dopo il ritiro del 1817, John Philip Kemble trascorse gli ultimi anni tra la Francia e la Svizzera, lontano dai clamori di Londra. Si stabilì infine a Losanna, dove morì il 26 febbraio 1823, circondato dai libri che avevano accompagnato tutta la sua vita. Nonostante la distanza, continuò a seguire le vicende del teatro inglese, scambiando lettere con colleghi e critici. La sua scomparsa fu percepita come la fine di un’era: quella del “grande attore classico”, depositario di una tradizione oratoria e morale che il Romanticismo stava ormai trasformando.
La generazione successiva di interpreti — primo fra tutti Edmund Kean — incarnava una recitazione opposta alla sua: istintiva, passionale, quasi anarchica. Kean, con i suoi improvvisi scoppi emotivi, divenne l’idolo di un pubblico che voleva sentire il sangue e la follia sulla scena, non la misura del verso. Ma proprio per contrasto, la figura di Kemble apparve ancora più necessaria. Era il simbolo della disciplina, della compostezza, della fede nel teatro come arte morale. Laddove Kean rappresentava la libertà romantica, Kemble incarnava l’ordine classico. I due, pur diversissimi, formarono le due colonne di una stessa evoluzione: dal teatro della forma al teatro dell’anima.
Il contributo di Kemble al teatro britannico non si esaurisce nella recitazione. Egli fu uno dei primi riformatori sistematici della gestione teatrale moderna. Le sue innovazioni — prove regolari, attenzione alla storicità dei costumi, coordinamento tra attori e scenografi — costituirono la base del teatro professionale ottocentesco. Prima di lui, l’attore era una figura isolata, spesso priva di guida o di metodo. Con lui, divenne parte di un organismo strutturato, in cui ogni elemento aveva funzione e responsabilità.
Nel corso della sua carriera, Kemble interpretò più di cento ruoli, molti dei quali tratti da Shakespeare. Ma furono i personaggi romani — Bruto, Coriolano, Cato — a definirne la grandezza. La critica dell’epoca notava come il suo portamento e la sua voce fossero perfettamente adatti a incarnare la gravità dell’antico. Aveva una statura imponente, un profilo nobile, e un modo di camminare che ricordava le statue di marmo. Quando entrava in scena, scrisse William Hazlitt, “il tempo stesso sembrava rallentare”. La lentezza che gli veniva rimproverata da alcuni spettatori era, per altri, la chiave della sua forza: un ritmo interno, una sospensione che trasformava il linguaggio in scultura sonora.
La sua influenza si estese anche alla critica e all’estetica teatrale. Molti studiosi dell’Ottocento lo citarono come esempio di recitazione “ideale”, capace di esprimere i valori morali del personaggio più che la sua psicologia. La Royal Society of Literature e la British Library conservano documenti e lettere in cui Kemble discute di dizione, gesto e interpretazione come “arti sorelle della filosofia” (Royal Society of Literature, British Library). Queste riflessioni furono fondamentali per lo sviluppo di scuole di recitazione più tarde, come quella di Henry Irving e, in seguito, di John Gielgud. Tutti riconoscevano in lui un padre nobile, il primo a concepire l’attore come intellettuale e artigiano insieme.
A livello iconografico, la sua immagine rimase impressa nei ritratti di artisti come Sir Thomas Lawrence e George Romney, che lo ritrassero in pose solenni, spesso nei panni di Coriolano o Amleto. La National Portrait Gallery di Londra custodisce alcune di queste opere, testimoni di un culto quasi eroico che accompagnò la sua figura (National Portrait Gallery). L’Inghilterra romantica, pur preferendo i toni più viscerali di Kean, non dimenticò mai l’eleganza “statutaria” di Kemble, il suo modo di parlare come se ogni parola fosse scolpita nel marmo del tempo.
Dopo la sua morte, la famiglia Kemble — già celebre grazie a Sarah Siddons — continuò a dominare la scena teatrale per decenni. I nipoti e pronipoti, tra cui Fanny Kemble, divennero attori, drammaturghi e cronisti del palcoscenico. Fanny, in particolare, pubblicò memorie dettagliate sulla vita e l’arte dei suoi antenati, contribuendo a tramandare il mito familiare. In quelle pagine, John Philip appare come il patriarca severo ma giusto, l’uomo che credeva nel teatro come in una liturgia.
Uno dei segni più tangibili della sua eredità è la statua commemorativa a Westminster Abbey, vicino a quella di Sarah Siddons. Scolpita in marmo bianco, lo raffigura in toga classica, lo sguardo rivolto verso l’alto: un’immagine perfetta della sua poetica, sospesa tra Roma e Londra, tra l’antico e il moderno. I visitatori che ancora oggi attraversano la Poets’ Corner trovano nella sua effigie un simbolo della continuità del teatro britannico, dal verso elisabettiano alle scene contemporanee.
Kemble lasciò anche una lezione etica che superava il palcoscenico. Per lui, l’attore non doveva “provocare” ma “elevare”. Il pubblico non era un giudice, ma un testimone da guidare verso la verità morale. È per questo che il suo stile, pur distante dalla sensibilità odierna, continua a esercitare fascino. Nel suo rigore, c’è una purezza d’intenti che lo rende un punto di riferimento per chi considera il teatro non solo intrattenimento, ma esercizio di civiltà.
Oggi, studiosi e appassionati ricordano John Philip Kemble come un precursore del teatro consapevole, quello in cui ogni gesto è pensato, ogni parola pesa, ogni silenzio parla. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla spettacolarità, la sua lentezza torna a essere una virtù. Rileggere la sua vita significa riscoprire il valore del tempo nel teatro: il tempo dell’attesa, del respiro, della forma che dà senso al sentimento.
Curiosità e domande frequenti
Chi fu il principale rivale di John Philip Kemble?
Il suo rivale storico fu Edmund Kean, interprete passionale e romantico che rappresentò l’opposto della sua compostezza classica.
Qual è il ruolo più celebre di Kemble?
Oltre al Coriolano che segnò la sua ultima apparizione nel 1817, il suo Amleto del 1783 al Drury Lane resta uno dei più discussi della storia del teatro britannico.
Quale fu il contributo più innovativo di Kemble alla scena inglese?
La professionalizzazione del mestiere d’attore: impose prove regolari, coerenza storica nei costumi e un modello etico di recitazione fondato sulla disciplina.
Dove si trova oggi commemorato?
È ricordato con una statua a Westminster Abbey, nella Poets’ Corner, accanto alla sorella Sarah Siddons.
Quali fonti principali testimoniano la sua carriera?
Le più autorevoli sono la British Library, la Royal Society of Literature, la National Portrait Gallery e la Westminster Abbey Collection.
Le immagini utilizzate sono su Common free license o tutelate da copyright. È vietata la ripubblicazione, duplicazione e download senza il consenso dell’autore.
Immagini interne e di copertina: By William Hamilton – Folger Shakespeare Library Digital Image Collection http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/y85615, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40905764
The post John Philip Kemble: l’arte tragica tra classicismo e rivoluzione teatrale first appeared on Londra Da Vivere : il più grande portale degli italiani a Londra.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































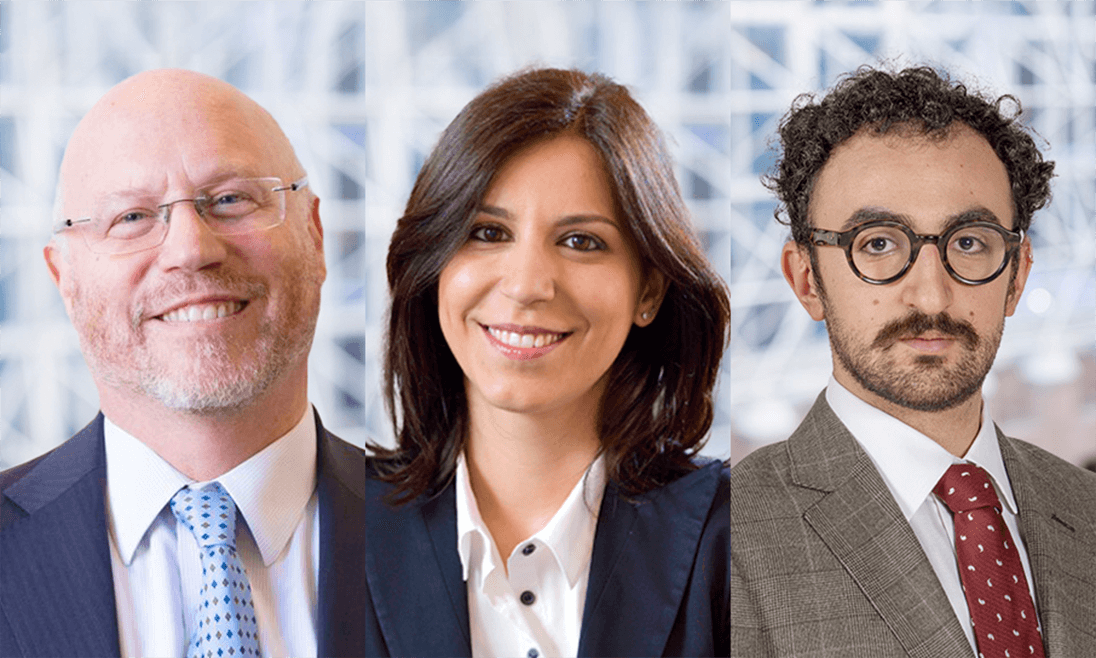




















































































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































