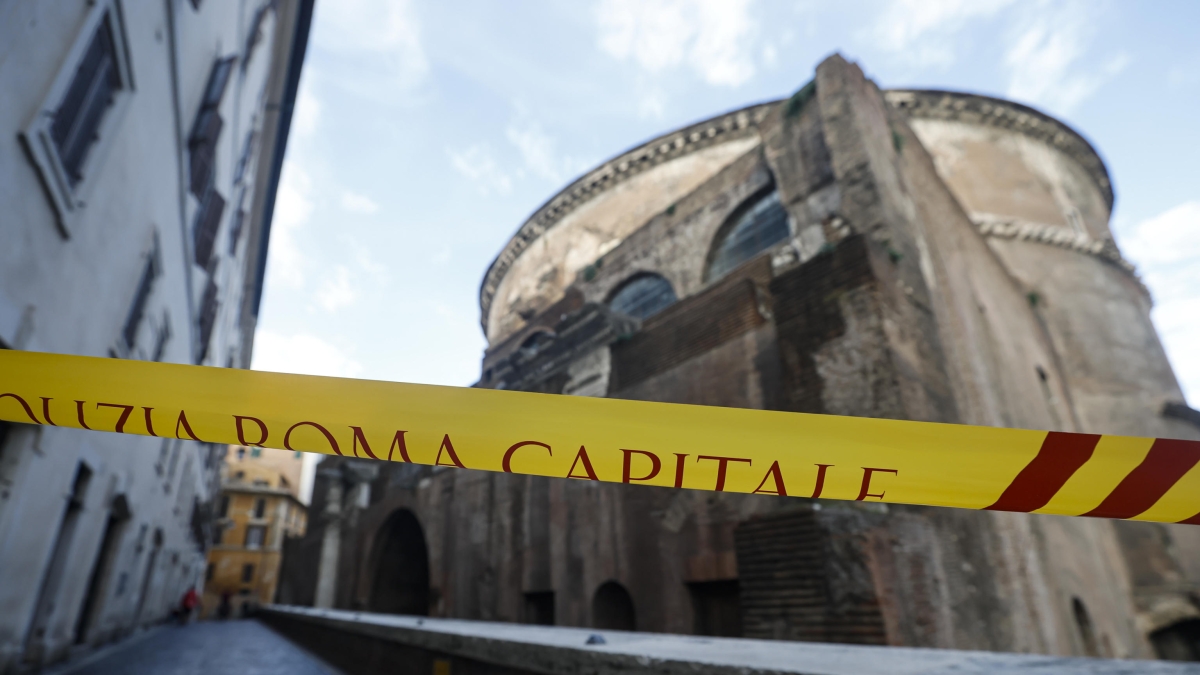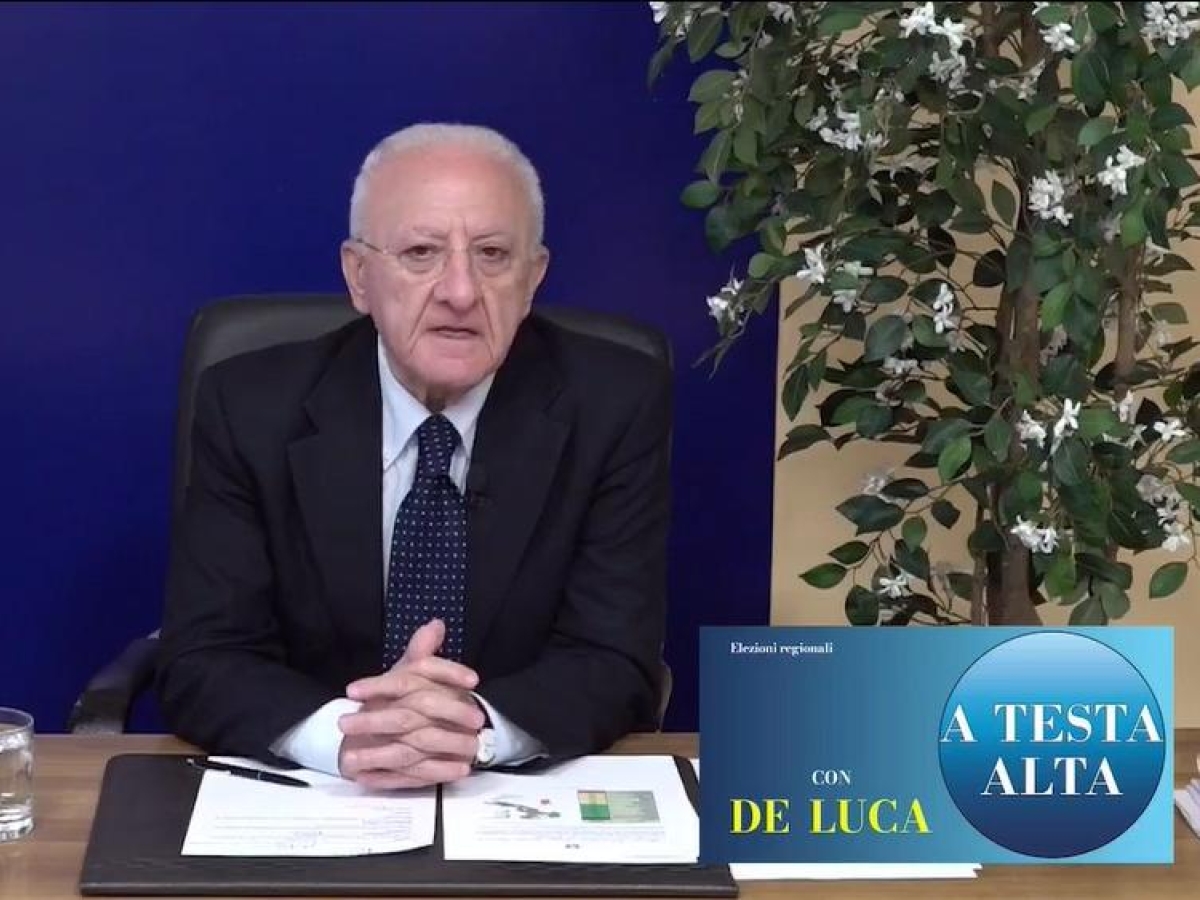Responsabilità erariale per omessa comunicazione della deliberazione sulle tariffe

lentepubblica.it
In questo approfondimento l’Avvocato Maurizio Lucca offre uno spaccato sulla responsabilità erariale per omessa comunicazione della deliberazione sulle tariffe analizzando una recente pronuncia giuridica.
La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 325, accoglie parzialmente la richiesta della procura erariale di condanna del responsabile finanziario di un Comune per l’omessa comunicazione al Ministero dell’Economia, ai fini della relativa pubblicazione, della deliberazione consiliare relativa alla rideterminazione in aumento delle tariffe TARI (tassa rifiuti).
La certezza delle tariffe
La peculiarità della TARI è contraddistinta da una stretta correlazione tra il prelievo e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: la tariffa deve coprire tutti i costi [1] e proprio la stretta correlazione esistente tra il piano economico finanziario e le tariffe della TARI induce a ritenere che, avendo il piano finanziario un orizzonte temporale annuale, anche le tariffe approvate dall’ente sulla base del piano stesso debbano necessariamente essere applicate su base annuale, con le avvertenze di cui all’art. 193, Salvaguardia degli equilibri di bilancio, del d.lgs. 267/2000 (parte finale del comma 3) [2].
In effetti, la programmazione esige che la manovra tariffaria sia coerente con le previsioni di bilancio, dovendo ritenere che è capace di apportare concreti vantaggi alla collettività solo se esercitata tempestivamente, conferendo così maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in stretta aderenza al dettato dell’art. 97 della Costituzione.
Invero, la ratio della perentorietà del termine di approvazione, così come quello di efficacia con la pubblicazione della deliberazione di determinazione, è inteso nella volontà di rendere trasparente e chiara la disciplina applicativa (il dovuto), se si pensa che vi è l’assoluta necessità di garantire ai contribuenti un riferimento temporale preciso per l’individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta [3].
Fatto
La procura attorea citava in giudizio il responsabile del servizio finanziario del Comune per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore dello stesso di una determinata somma (quantum ridotto a zero dalla difesa della parte convenuta, oltre a negare una responsabilità sull’invio di competenza di altro responsabile all’epoca dei fatti), per non aver adempiuto agli obblighi di trasparenza, ex comma 15 ter, dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del DL n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
L’obbligo prevede che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi devono essere inviati in modo telematico al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro «il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno… I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente»: l’acquisto di efficacia coincide con la data della pubblicazione, e di converso la mancata pubblicazione (ergo mancato invio) comporta l’inefficacia delle tariffe modificate e l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente.
In dipendenza di ciò, l’omissione (alias grave negligenza) comporta un danno da minori entrate tributarie al Comune, e un disservizio per l’inevitabile correzione degli importi dei ruoli di nuova emissione e per coloro che avevano già pagato aveva riconosciuto, per il surplus, un credito da compensare con la TARI dell’anno successivo.
Il danno patito
Prima di entrare nella determinazione dell’aspetto soggettivo della responsabilità, la Corte si sofferma sulla quantificazione effettiva del danno in relazione alla dimostrazione (della parte convenuta) della sua insussistenza sulla base dell’analisi dei PEF (Piano economico finanziario che determina il costo del servizio, e riflesso le nuove tariffe) e della disciplina riferita all’epopea Covid-19: aspetto non accolto, sussistendo il danno patrimoniale come ricostruito dagli atti prodotti dalla procura.
Scudo erariale e imputabilità
Sulla rilevanza, nel giudizio, dell’intervenuto c.d. scudo erariale, ex art. 21, comma 2, del DL 16 luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, dove si limita la responsabilità erariale conseguente a condotte commissive «ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta», con la precisazione che tale limitazione «non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente», il giudice precisa che la responsabilità erariale conseguente a inerzia od omissioni presuppone, oggi come in passato, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, mentre la responsabilità connessa a condotte attive viene limitata alle sole ipotesi di causazione dolosa del danno.
Viene richiamata la giurisprudenza penale [4] che configura una responsabilità:
- commissiva, quando la condotta del soggetto agente viola un divieto, dunque un dovere di non facere, in termini civilistici;
- omissiva, la condotta violativa di un comando, il quale imporrebbe, al contrario, di attivarsi ed agire, quindi un facere (caso di specie nel mancato invio obbligatorio al MEF per l’efficacia del provvedimento);
- la colpa ha sempre una componente omissiva, in quanto si riferisce, per definizione, all’inosservanza di una regola di condotta (sia essa una regola di prudenza, diligenza o perizia).
Ne consegue che la distinzione fa riferimento alla natura della regola di condotta violata: la violazione di una regola di condotta che impone un divieto dà luogo a responsabilità commissiva, mentre la violazione di un comando, inteso come dovere di agire o compiere una determinata attività, dà luogo a responsabilità omissiva.
Rapporto di servizio
Ciò posto, sussistono tutte le componenti strutturali oggettive della responsabilità amministrativo-contabile:
- rapporto di servizio con il Comune;
- comportamento antigiuridico (condotta), in violazione di legge (ossia, l’art. 13, comma 15 ter, del DL n. 201/2011) nel periodo oggetto di giudizio, nel quale rivestiva la responsabilità del settore finanziario su cui incombeva l’obbligo della trasmissione al MEF ai fini della pubblicazione della deliberazione (obbligo risultato poi inadempiuto);
- il nesso di causa tra la condotta antigiuridica e il danno cagionato al Comune: il mancato invio determina la mancata efficacia del nuovo sistema tariffario Tari, rimodulato in aumento (ricadute negative sul comunale consistenti in un minor gettito di entrata dall’applicazione delle tariffe dell’anno precedente di importo inferiore: ossia, il danno).
Responsabilità erariale
La colpa grave risiede nel mancato (colpevole inerzia in funzione di un obbligo d’ufficio cogente che rientra nel patrimonio conoscitivo di tutti coloro che ricoprono il ruolo di responsabile presso un settore finanziario) invio entro i termini, donde l’inefficacia del provvedimento dispositivo.
Nella condotta è venuta meno una diligenza minima, nel senso di una mancanza di operosità per evitare il danno, rectius impedire l’evento, non osservando le regole di prudenza e di capacità insite alla funzione ricoperta (esigibile), configurando quella colpa grave nel concetto ulpianeo (culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt).
A ben vedere, è stata abbandonata l’antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall’agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l’ordinamento giuridico.
Ne discende l’esigenza di valutare l’azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell’agente: la forma di colpa va valutata nell’ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio “ex ante”, in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno [5].
L’elemento soggettivo della colpa grave va individuata unicamente nella “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata [6].
La determinazione del giudice erariale
Nel concreto si fanno rientrare:
- tutte quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio (in considerazione del ruolo apicale rivestito) e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza;
- elementi qualificanti vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso, di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 c.p. e 1176 c.c. [7].
Visto nel suo insieme, si censura la condotta assunta, soprattutto nell’assunzione «dell’incarico di responsabile del servizio finanziario si è del tutto disinteressata di quell’obbligo specifico, nonostante fosse a conoscenza, perché anche Segretario generale, della delibera di aumento delle tariffe; inoltre, in occasione del passaggio di consegne con il precedente dirigente del Servizio, non si è preoccupata di raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie ad evitare il mancato invio».
A completamento, e in riduzione dell’addebito, viene appurato anche un apporto causativo del danno del precedente responsabile, dovendo assegnare la responsabilità limitatamente al periodo temporale per il quale incombevano gli obblighi di servizio, ovvero la responsabilità per la cattiva gestione amministrativa va ridotta tenendosi conto del periodo in cui la parte convenuta ha assunto l’incarico e della circostanza che anche sul precedente responsabile incombeva l’obbligo di attivarsi per l’invio della deliberazione al MEF, con conseguente responsabilità erariale da addebitare nella misura del 50% del danno.
Potere riduttivo
Viene accolta la domanda di esercizio del potere riduttivo fondato sulle seguenti considerazioni:
- le oggettive difficoltà organizzative dovute al doppio incarico rivestito da parte del convenuto (Segretario generale e responsabile del Servizio finanziario);
- l’assenza di supporto dei dipendenti del Comune abilitati all’invio della deliberazione attraverso l’applicativo informatico dedicato, i quali non risulta agli atti si siano minimamente preoccupati di avvertire il responsabile dell’impellente necessità di assolvere all’obbligo di trasmissione.
Osservazioni
La sentenza (nello sfondo e al di là del fatto) dipinge una realtà assai frequente nei piccoli Comuni, dove il Segretario comunale non si limita a svolgere il proprio ruolo ma viene impiegato in altri ruoli diversi, coprendo posti che non sono coperti da anni, pretendendo una flessibilità non coerente con il sistema ordinamentale.
In questi ambiti lavorativi, le situazioni organizzative presentano delle evidenti carenze funzionali, con professionalità che oggettivamente non possono ricoprire la specializzazione richiesta dalla mole infinita di adempimenti, nell’impossibilità di svolgere formazione e di assicurare un minimo di rotazione, fosse solo per usufruire delle ferie.
È comprensibile, in questo contesto, una “distrazione” che può comportare delle gravi sanzioni, del tutto sproporzionate e abnormi, non potendo pensare (anzi, lo pensano coloro che non conoscono la realtà per una mancanza di prossimità con il lavoro) che sia sufficiente una norma a rimuovere i limiti di un’organizzazione deficitaria e antica (ove la semplificazione è sinonimo di complicazione), ove le regole sono uguali per tutte le realtà, in una evidente non comparazione per risorse e mezzi impiegati: una macedonia tra grandi comuni, città metropolitane e comuni polvere.
Allo stesso tempo, senza andare oltre, si deve osservare, come pronunciato dal giudice erariale, che usando una diligenza minima si possono evitare incidenti (sembra facile, dura lex sed lex).
Note
[1] Si rinvia, per una compiuta e illuminante analisi, PIEROBON, Minime e inattuali riflessioni sulla tariffa rifiuti, 12 marzo 2024, osservatorioagromafie.it/minime-e-inattuali-riflessioni-sulla-tariffa-rifiuti/, ove si rileva che «i costi della gestione del complessivo (integrato) servizio dei RU sono finanziati con i proventi tariffari (TIA in varie salse, TARI parimenti in varie salse) che contemplano anche dei ricavi».
[2] La variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, effettuata ai sensi dell’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, si colloca nella fase di gestione del bilancio e presuppone l’avvenuta adozione della deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2020, n. 2189. Ne consegue che risulta preclusa l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio) delle tariffe e delle aliquote approvate in data successiva al 1° gennaio e quindi una sorta di loro efficacia intertemporale: la delibera tariffaria TARI approvata tardivamente, cioè oltre il termine perentorio previsto per il bilancio di previsione, è efficace solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2356.
[3] Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4948.
[4] Cass. pen., sez. IV, sent. 22 giugno 2009, n. 26020; Cass. pen., sez. IV, sent. 22 luglio 2011, n. 29476.
[5] Occorre che il giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, verifichi, secondo un giudizio prognostico condotto ex ante ed in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma in concreto), la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma (c.d. profilo oggettivo del grado della colpa), avendo tuttavia nel contempo riguardo alle circostanze del caso concreto e alle caratteristiche del soggetto, sulla scorta del riferimento al parametro dell’agente modello (c.d. profilo soggettivo o individualizzante della colpa), Corte conti, sez. I App., 24 dicembre 2024, n. 257.
[6] Corte conte, sez. giur. Sardegna, 9 settembre 2025, n. 135.
[7] Corte dei conti, Sez. Riun., n. 56/1997.
The post Responsabilità erariale per omessa comunicazione della deliberazione sulle tariffe appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0












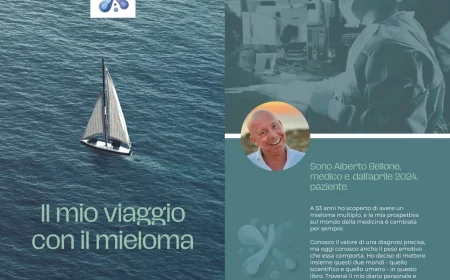












































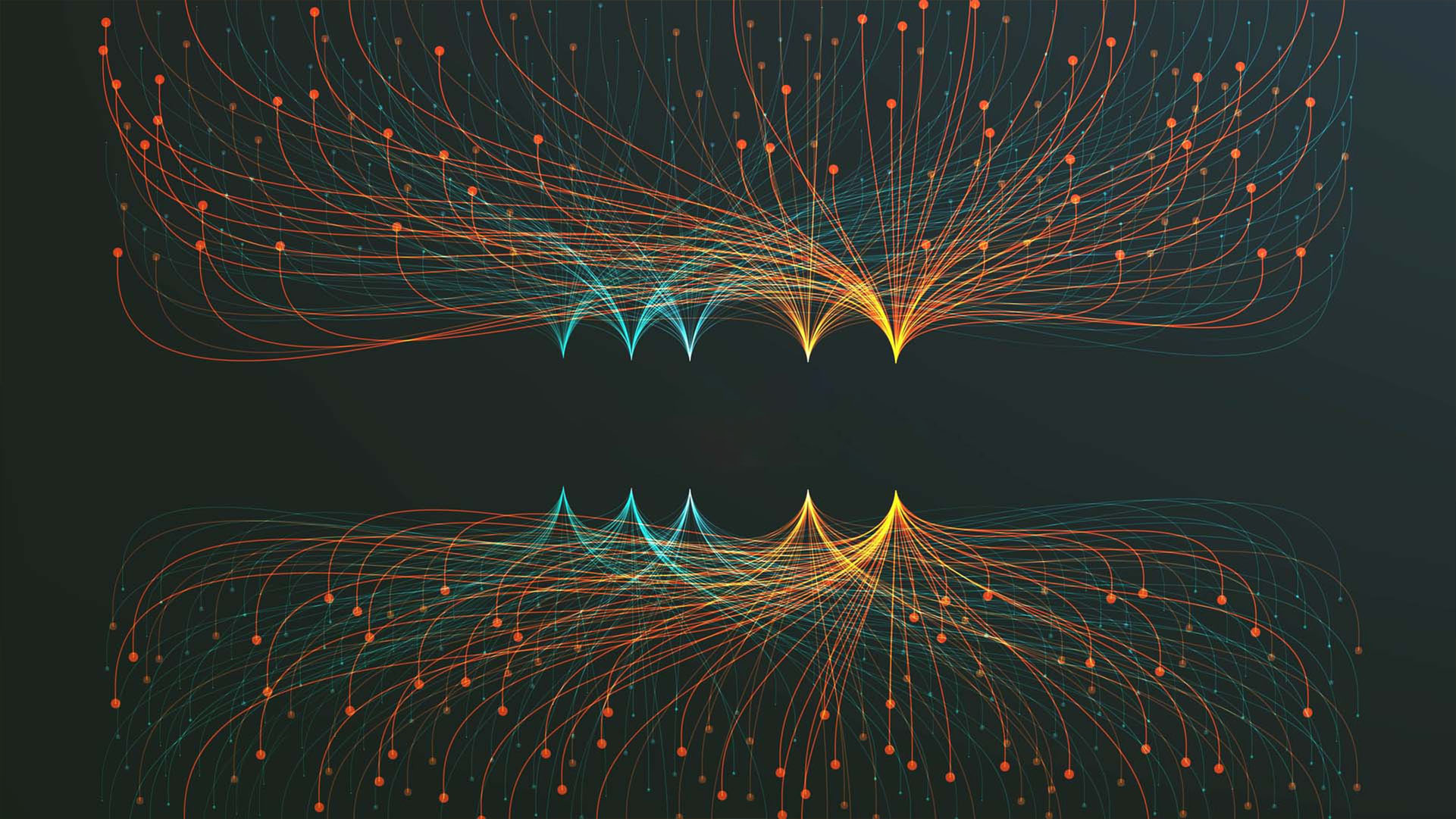
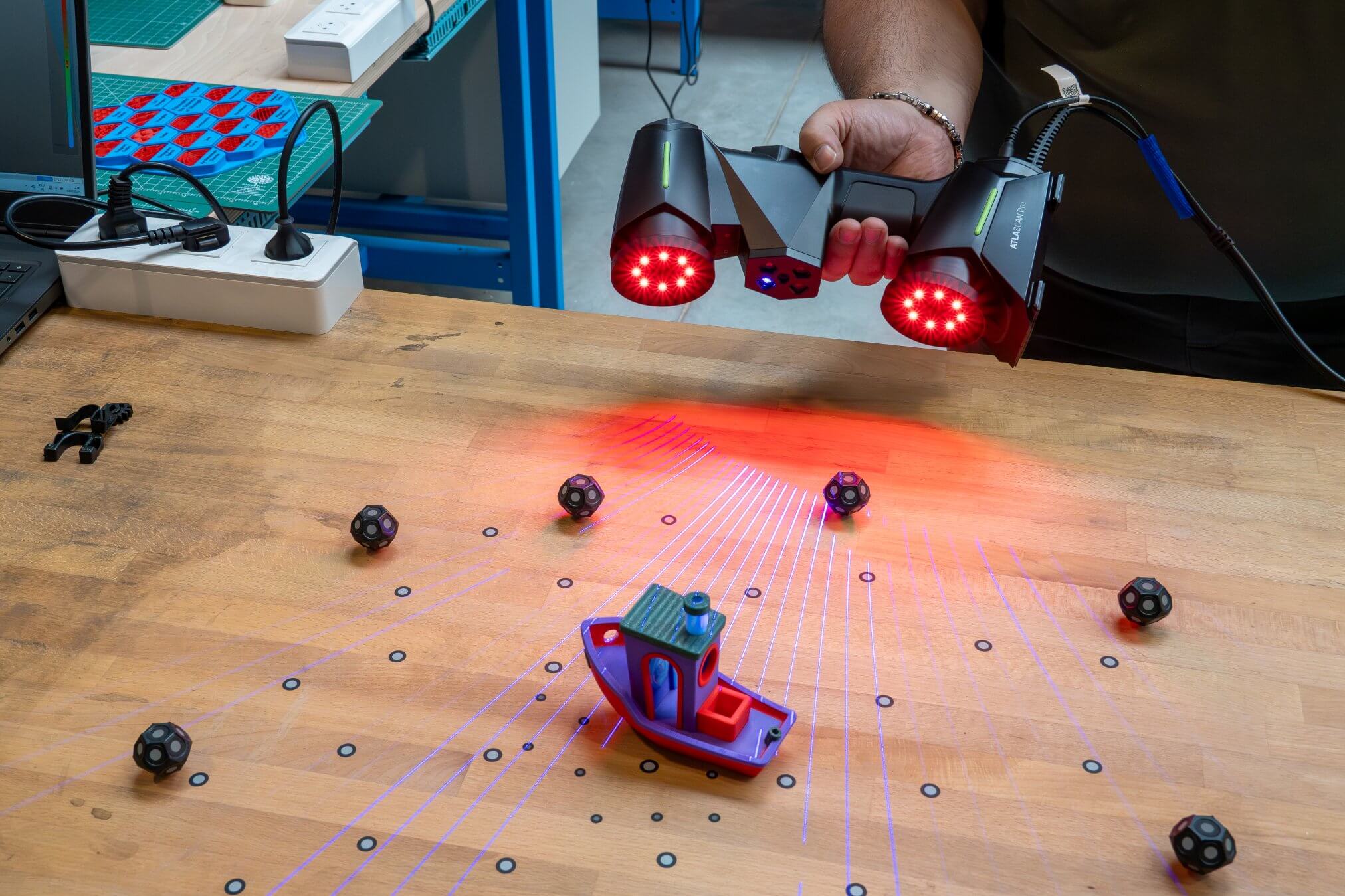
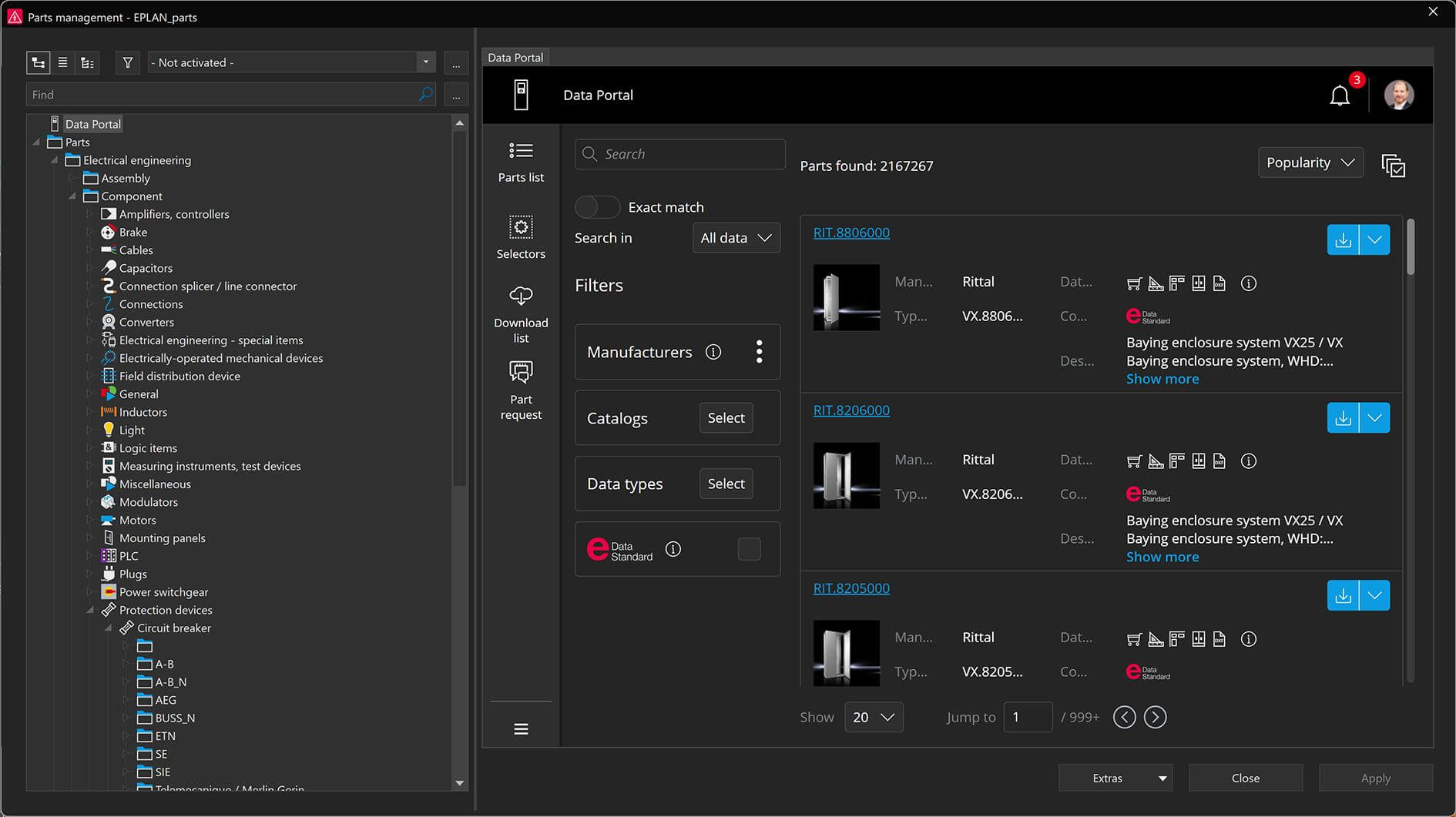

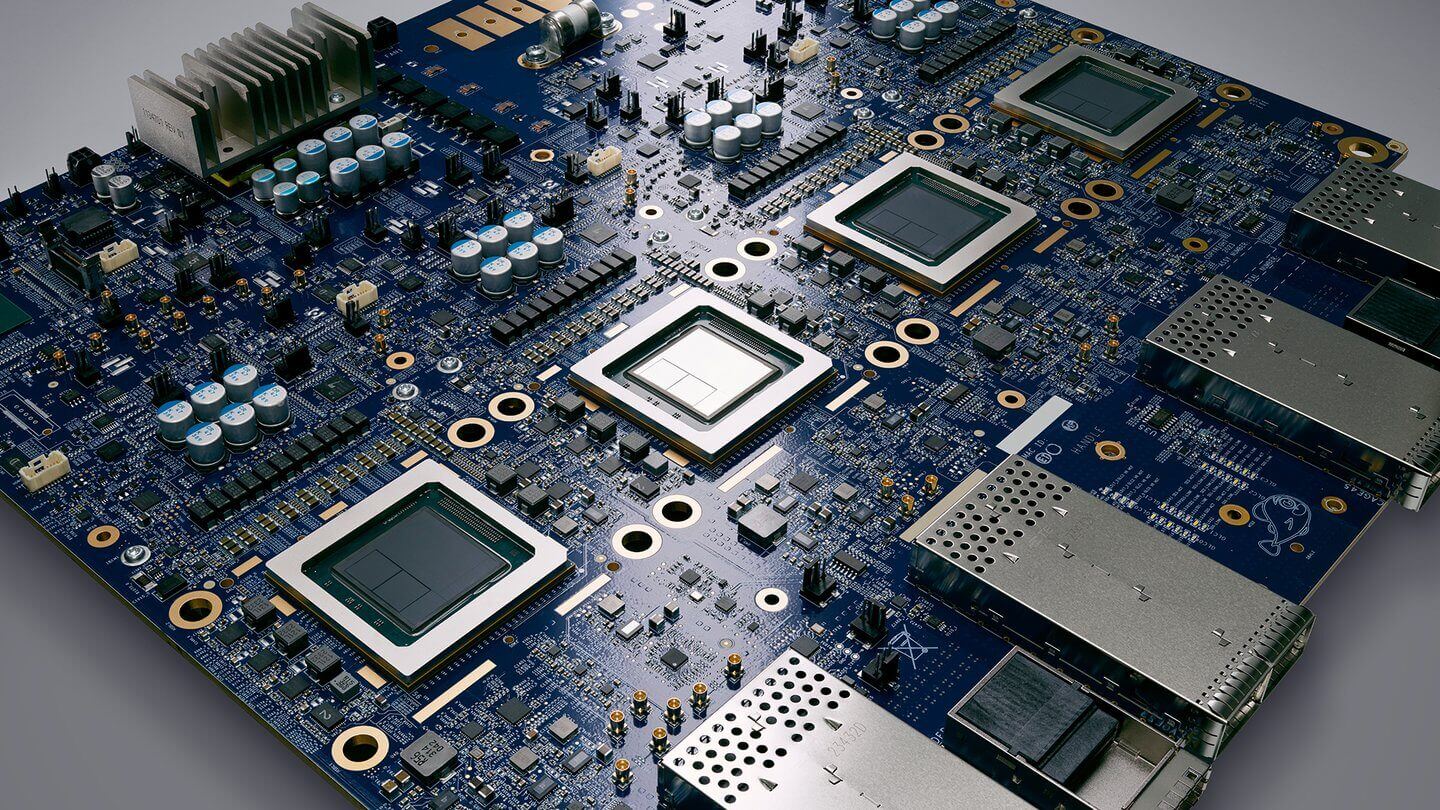

















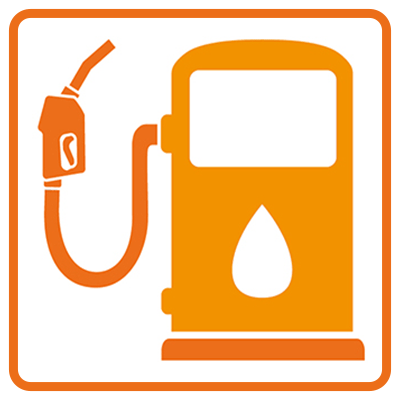
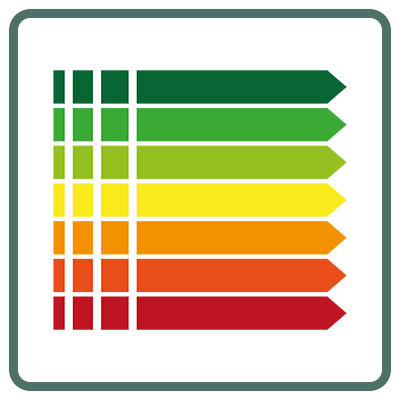
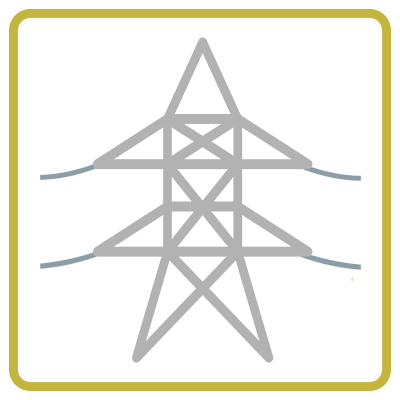










































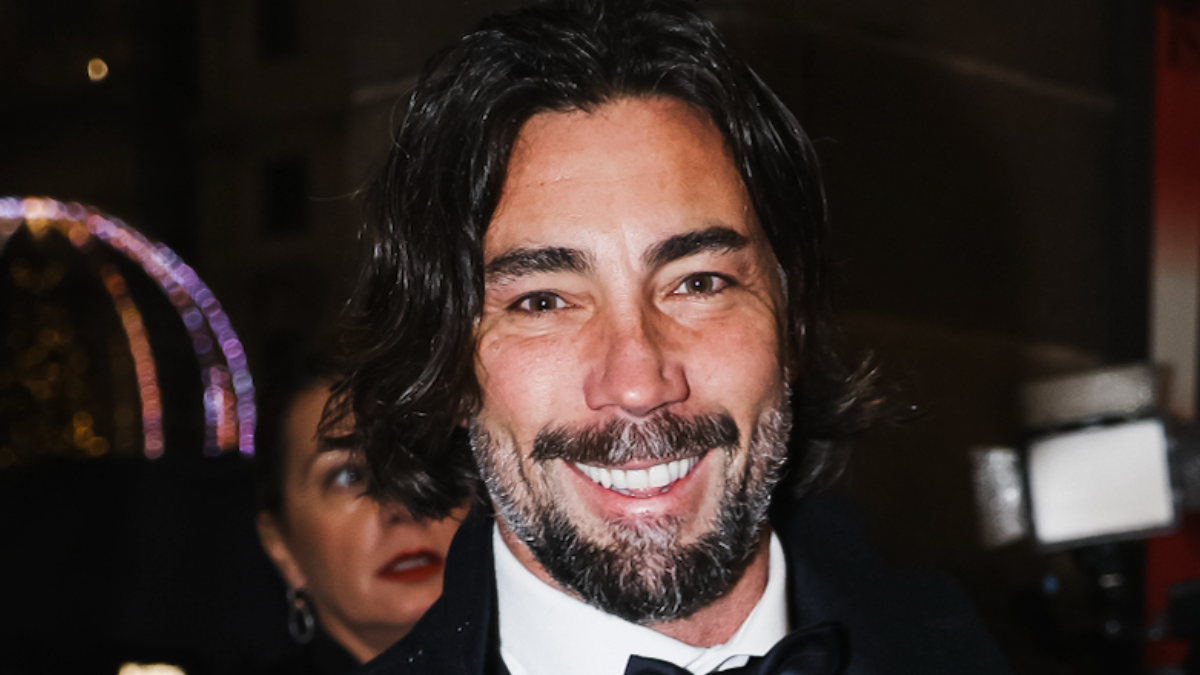

































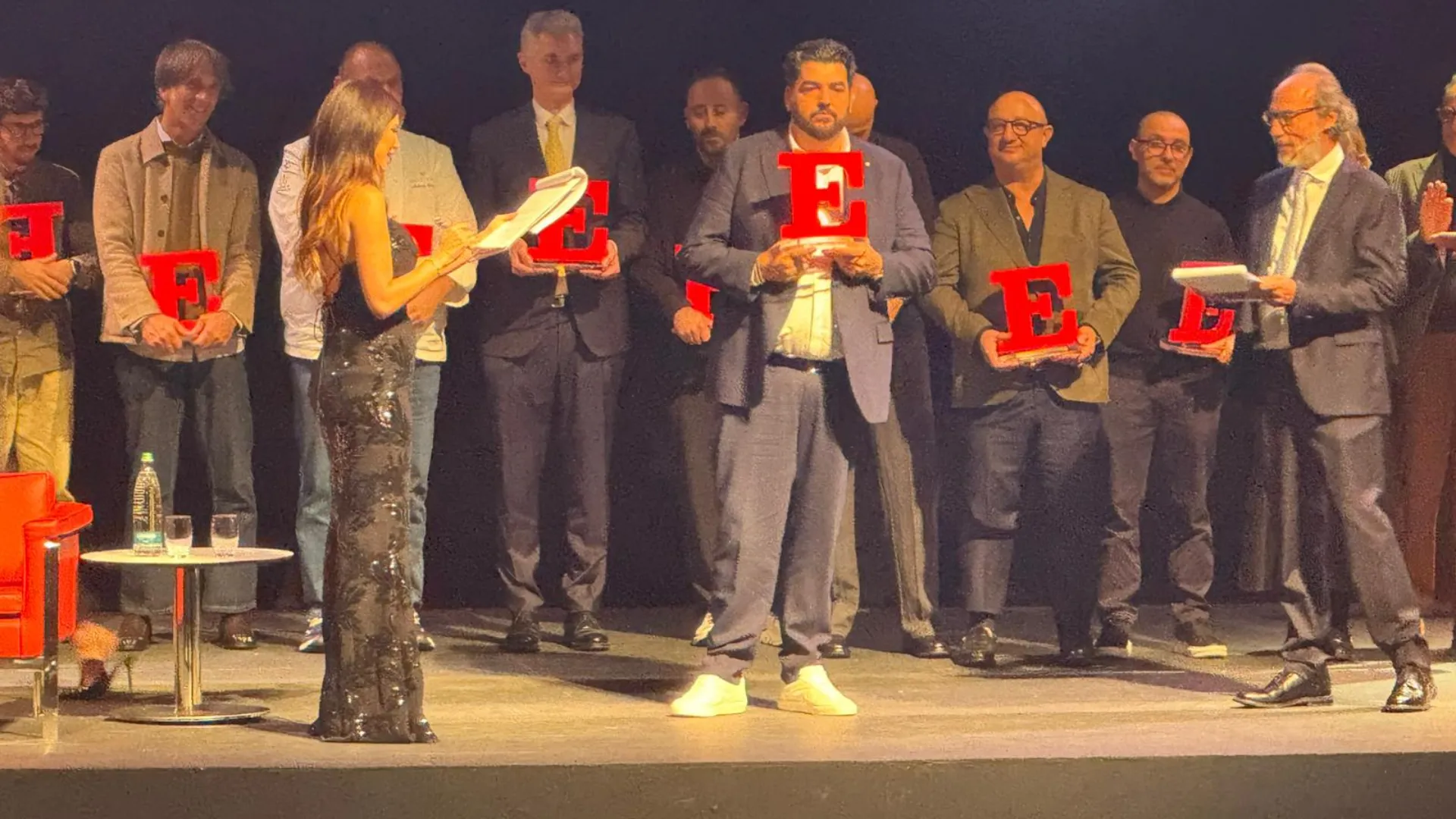
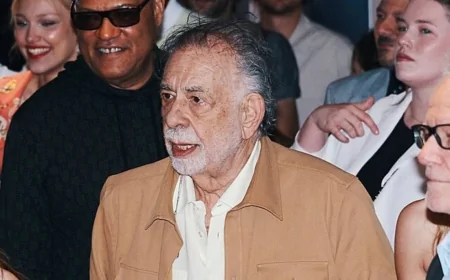





















-1761333925581.jpg--moncalieri__a_100_anni_torna_a_camminare_dopo_la_frattura_del_femore___ringrazio_di_cuore_i_medici_che_mi_hanno_aiutata_.jpg?1761333926178#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)