Dall’AI “empatica” alla sicurezza Quantum: i trend tecnologici che definiranno il 2026 (e oltre)
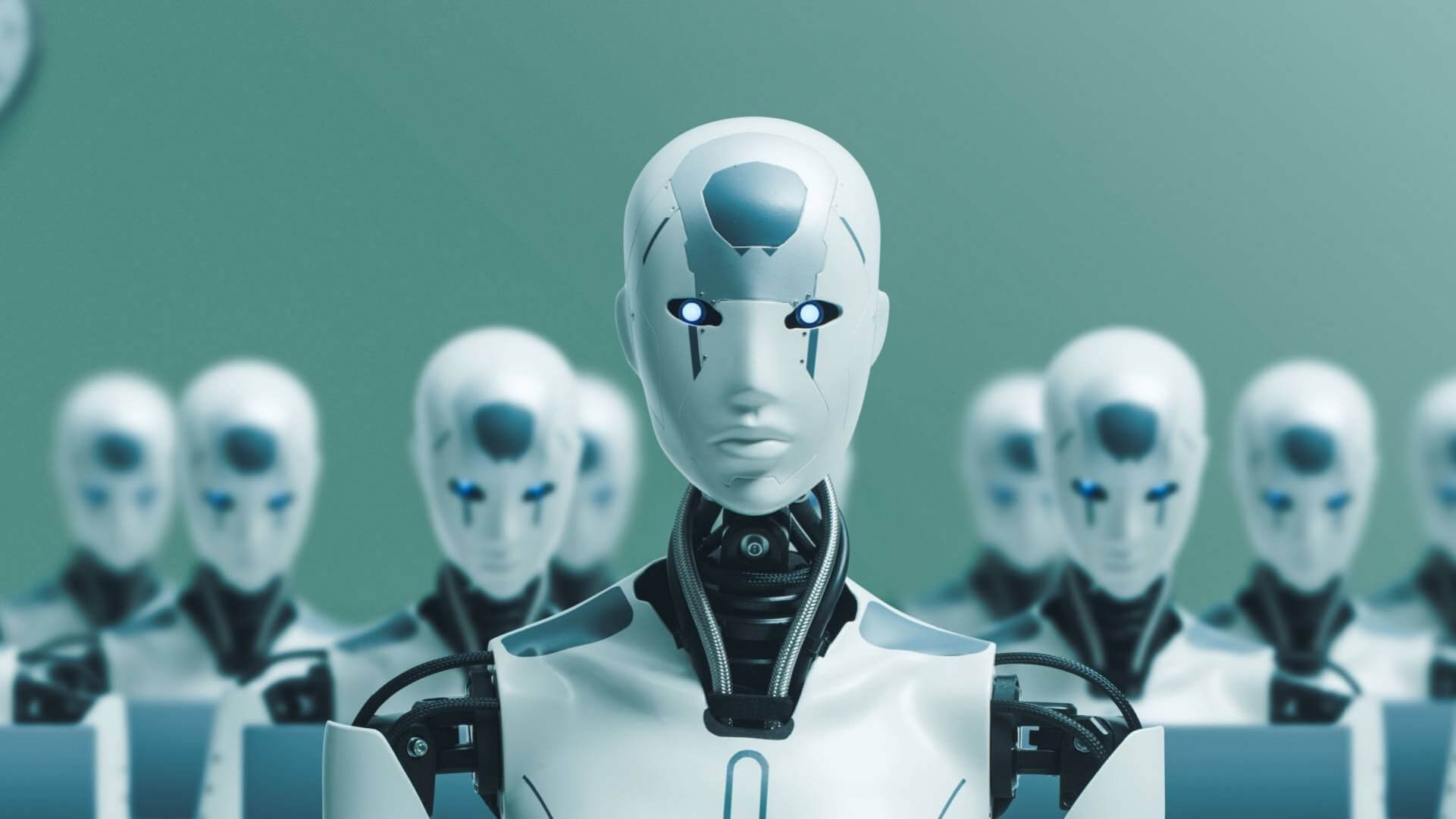
l’analisi del cto di amazon
Dall’AI “empatica” alla sicurezza Quantum: i trend tecnologici che definiranno il 2026 (e oltre)
Werner Vogels (CTO Amazon) delinea le previsioni per i prossimi anni: l’AI entra nel ciclo umano per risolvere sfide globali. Dall’uso dell’AI contro la solitudine alla nascita del developer rinascimentale fino all’accelerazione del trasferimento tecnologico dalla difesa ai servizi civili: ecco che cosa dice.
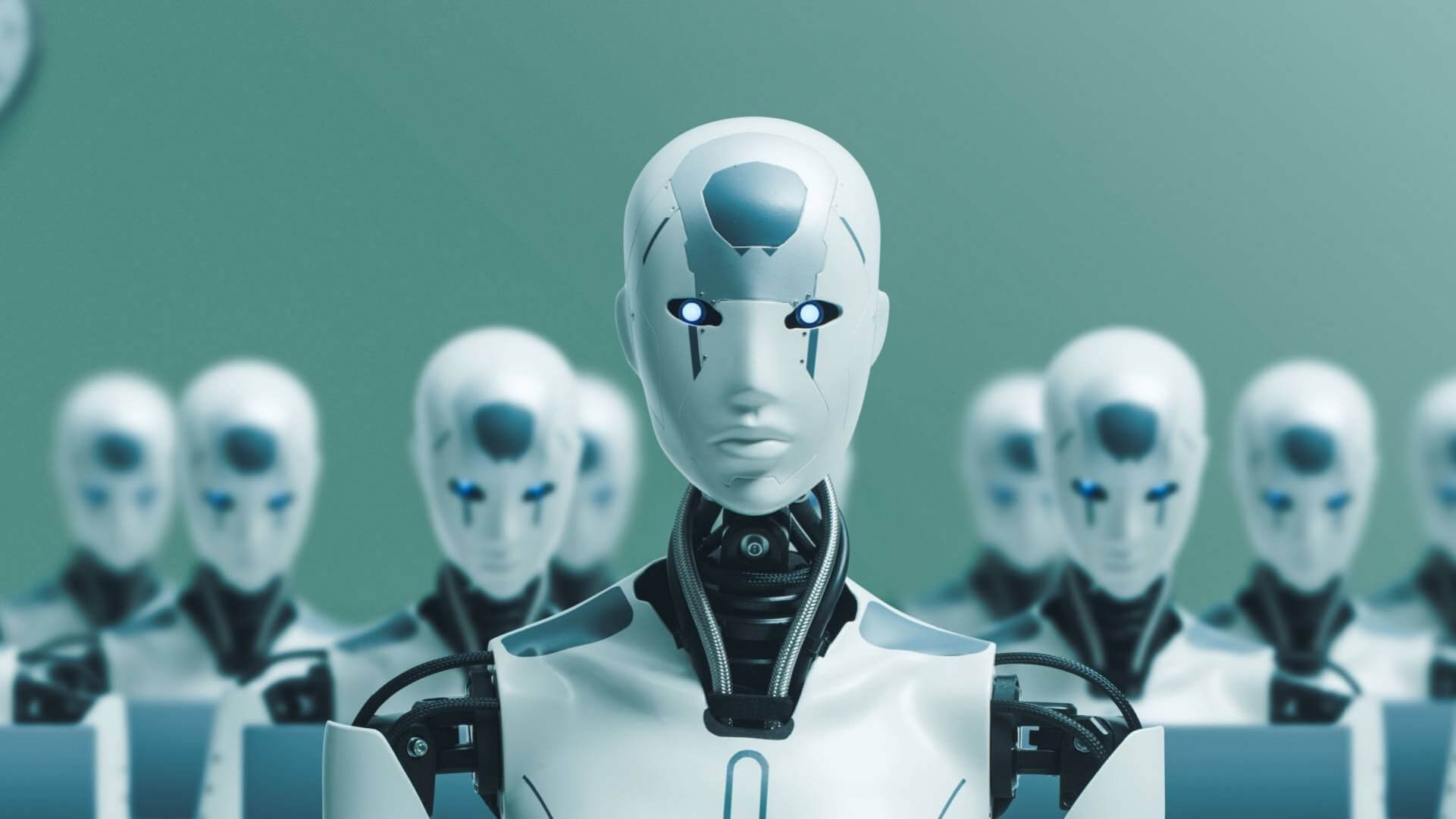
Un futuro di profonda interazione tra esseri umani e AI, destinata a inserirsi nei cicli della vita quotidiana per affrontare sfide sistemiche: è questa la visione che delinea Werner Vogels, Chief Technology Officer di Amazon, sulle traiettorie tecnologiche che plasmeranno il 2026 e gli anni successivi.
Le sue proiezioni indicano una transizione verso una nuova era in cui la tecnologia mira a valorizzare l’autonomia e l’esperienza individuale.
Vogels identifica quattro macro-aree di trasformazione imminente per l’industria e la società:
- la ridefinizione della compagnia in risposta alla “crisi di solitudine”
- l’evoluzione della figura professionale dello sviluppatore
- l’urgenza di una migrazione globale verso la sicurezza post-quantistica
- l’accelerazione del trasferimento tecnologico dal settore della difesa a quello civile.
“Siamo sull’orlo di qualcosa di fondamentalmente diverso. Abbiamo intravisto un futuro che valorizza l’autonomia, l’empatia e le competenze individuali. Dove la cooperazione interdisciplinare influenza la scoperta e la creazione a un ritmo inarrestabile”, scrive.
“Nel prossimo anno inizieremo la transizione verso una nuova era dell’IA nel ciclo umano, e non viceversa. Questo ciclo creerà enormi opportunità per risolvere problemi che contano davvero. E inizierà affrontando una delle conseguenze indesiderate del nostro mondo iperconnesso, la solitudine e la mancanza di compagnia, trasformando proprio la forza che ha creato il problema nella soluzione”, aggiunge.
L’AI come risposta all’epidemia di solitudine
Il futuro delineato da Vogels vede quindi la tecnologia, e in particolare l’AI, a servizio di alcune grandi sfide sociali, a cominciare dall’isolamento sociale.
Un fenomeno che ha raggiunto proporzioni epidemiche a livello globale, tanto da essere stata classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una crisi di salute pubblica.
L’isolamento sociale, che colpisce una persona su sei a livello mondiale, aumenta il rischio di mortalità del 32%. La solitudine è associata anche a un aumento del 31% del rischio di demenza e del 30% di ictus.
Di fronte all’invecchiamento demografico e alla pressione sui sistemi di assistenza, la convergenza tra la AI avanzata e le esigenze sociali ha creato le condizioni ideali per un cambiamento profondo.
L’obiettivo è passare da interazioni meramente transazionali con i dispositivi a relazioni basate sulla compagnia, in cui l’AI fisica dimostra un’intelligenza emotiva sempre più sfumata e un comportamento reattivo.
Studi clinici condotti, per esempio, in Canada, hanno dimostrato l’efficacia di robot come Paro nell’assistere la salute mentale in strutture di assistenza a lungo termine. In un’analisi specifica su pazienti con demenza, il 95% delle interazioni con questi compagni robotici è risultato benefico, portando a riduzioni misurabili nell’agitazione, nella depressione e nello stato di solitudine.
Vogels spiega che questa efficacia affonda le radici nella nostra stessa biologia: siamo programmati per proiettare intenzionalità e forma di vita su qualsiasi movimento autonomo percepito nel nostro spazio fisico, trattando i robot più come esseri viventi o animali che come semplici strumenti.
L’osservazione del team Amazon Astro ha evidenziato come le capacità di mobilità, l’interfaccia espressiva e le funzioni proattive del robot creino attaccamenti genuini, trasformando il robot da dispositivo di assistenza in un membro della famiglia percepito.
Lungi dal sostituire gli assistenti umani, questa AI mira a costruire un modello collaborativo in cui la tecnologia offre una presenza emotiva costante e un monitoraggio di routine, consentendo agli esseri umani di dedicarsi alle decisioni complesse e al nutrimento di relazioni più profonde.
L’alba del developer rinascimentale
Vogels precisa che la narrativa che paventa l’obsolescenza degli sviluppatori a causa dell’AI generativa è smentita dalla storia dell’innovazione nel software.
Ogni semplificazione degli strumenti ha prodotto un innalzamento del livello di astrazione: l’introduzione dei compilatori, anziché rendere superflui i programmatori assembly, ha aperto lo sviluppo a un pubblico più vasto, e l’automazione del cloud computing ha generato un’esplosione di nuovi ruoli ingegneristici.
Vogels ritiene che l’AI non eliminerà l’esigenza di competenza, ma la amplificherà, contribuendo all’emergere di una nuova figura professionale: il “developer rinascimentale“.
“Come i grandi del Rinascimento che combinavano arte, scienza e ingegneria, gli sviluppatori che prosperano in questo mondo potenziato dall’intelligenza artificiale devono diventare dei moderni poliedrici: sviluppatori rinascimentali”, scrive.
I developer di questa nuova era, spiega Vogels, “comprendono che i sistemi sono ambienti viventi e dinamici in cui i cambiamenti si propagano attraverso servizi, API, database, infrastrutture e persone. Comunicano con chiarezza, in modo che sia gli esseri umani che le macchine possano trarne vantaggio. Sono responsabili della qualità, della sicurezza e dell’intento di ciò che creano, soprattutto ora che l’ AI è sempre più sicura dei propri errori. Apportano conoscenze di settore che l’AI non è in grado di replicare, come la comprensione del business, dei clienti e dei vincoli del mondo reale che contano. Non smettono mai di imparare”.
La sicurezza quantum diventerà l’unica sicurezza
Le previsioni sulle tempistiche di sviluppo dei computer quantistici stanno subendo una drastica compressione. I recenti progressi nell’architettura hardware e nell’efficienza della correzione degli errori – come dimostrato da progetti quali il chip Ocelot di AWS o i progressi di IBM verso il fault-tolerant quantum computing entro il 2029 -, hanno reso l’arrivo della potenza quantistica una questione di pochi anni, non decenni.
Diventa quindi necessario, sottolinea Vogels, agire immediatamente per garantire la sicurezza dei dati. Il rischio più significativo risiede nel fatto che attori malevoli stanno già raccogliendo dati crittografati oggi, in attesa di disporre della potenza di calcolo necessaria per decifrarli.
La maggior parte della sicurezza digitale attuale si basa su algoritmi a chiave pubblica come RSA e la crittografia a curve ellittiche (ECC), che risulteranno banali per i computer quantistici che eseguiranno algoritmi come quello di Shor.
Una recente ricerca ha mostrato che interi RSA a 2048 bit potrebbero essere fattorizzati con meno di un milione di qubit rumorosi, una riduzione del 95% rispetto alle stime precedenti. Questo rende plausibile che, nel giro di circa cinque anni, la crittografia che protegge transazioni finanziarie e dati sensibili possa essere compromessa.
La preparazione, pertanto, non può essere posticipata e deve procedere su tre fronti interconnessi: l’implementazione della crittografia post-quantistica (PQC) dove possibile, la pianificazione per la sostituzione delle infrastrutture fisiche non aggiornabili, e lo sviluppo di talenti specializzati.
Soluzioni PQC basate su standard NIST, come ML-KEM, sono già disponibili e in fase di implementazione da parte delle principali aziende tecnologiche a livello di OS, browser e cloud.
Tuttavia, la sfida più complessa risiede nel mondo fisico: milioni di dispositivi embedded, dai contatori intelligenti ai sistemi di controllo delle reti idriche ed elettriche, si affidano alla crittografia attuale ma mancano della potenza di calcolo per eseguire gli algoritmi PQC.
“Questo vincolo costringerà le aziende a dare sfogo alla loro creatività. Ci si possono aspettare approcci ibridi che sovrappongono gateway quantistici sicuri ai dispositivi legacy e nuovi modelli di implementazione che sequenziano gli aggiornamenti hardware senza interrompere i servizi critici. Non si tratta più di un progetto di sicurezza IT, ma di una trasformazione inter funzionale che coinvolge ingegneria, logistica, produzione e operazioni”, precisa.
L’accelerazione del trasferimento tecnologico dalla difesa
Storicamente, il trasferimento di innovazioni nate in ambito militare verso l’utilizzo civile è stato un processo lungo, con cicli di adattamento che duravano dai dieci ai vent’anni, necessari per ottimizzazioni di costo e validazione commerciale.
Tecnologie essenziali per la vita civile come l’internet, il GPS o il radar ne sono un esempio. Werner Vogels osserva che questo modello di progressione è giunto a una fine. La differenza attuale non risiede soltanto nell’entità degli investimenti nel settore della difesa, ma nel cambio di approccio all’innovazione.
Vogels evidenzia come aziende emergenti operino ormai con l’obiettivo del duplice uso (militare e civile) fin dalla fase di ideazione del prodotto. Una strategia che elimina la tradizionale fase di adattamento che storicamente allungava il processo di trasferimento.
Il risultato è un’accelerazione critica: i sistemi autonomi e gli algoritmi di AI vengono affinati sotto estrema pressione in scenari operativi, con cicli di feedback e aggiornamenti misurati in giorni, non più in decenni.
Le implicazioni di questa velocità sono immediate per il settore civile. Ad esempio:
- Le capacità affinate per l’uso tattico si riversano rapidamente in applicazioni umanitarie e infrastrutturali
- l’Edge computing, perfezionato per ambienti disconnessi, trova oggi applicazione in cliniche sanitarie remote
- i sistemi autonomi sviluppati per la logistica militare vengono riadattati per l’agricoltura o la sicurezza di porti e centrali elettriche
Data tale accelerazione, settori civili come l’assistenza sanitaria e la gestione delle infrastrutture devono prepararsi a integrare queste capacità nel giro dei prossimi due anni e non tra due decenni.
“Le organizzazioni che riconoscono che non si tratta di evoluzione, ma di rivoluzione, saranno quelle che risolveranno i problemi che riguardano miliardi di persone”, aggiunge.
L’apprendimento personalizzato incontra la curiosità infinita
Il sesto punto affrontato da Vogels riguarda la trasformazione dell’istruzione: l’accesso a un tutoraggio personalizzato, un tempo limitato ai ceti abbienti, diventerà universale grazie alla AI.
Vogels riflette sul fatto che i sistemi educativi storici sono stati concepiti per l’efficienza e la conformità, spesso a scapito della curiosità e della diversità degli studenti. L’AI ha il potere di adattarsi al metodo di apprendimento, al ritmo e alle esigenze di ogni singolo studente, rispondendo a innumerevoli domande e creando ambienti sicuri dove l’errore è un punto di partenza e non un fallimento.
Questo cambiamento è già in atto su vasta scala. Vogels cita la rapida diffusione di piattaforme come Khanmigo o l’integrazione di strumenti AI nelle scuole in India, Brasile e Africa.
Per la Generazione Alpha, l’AI non è un semplice strumento, ma un’estensione del pensiero. Le statistiche supportano questa tesi: gli studenti dimostrano un aumento del 65% nella volontà di affrontare compiti impegnativi quando utilizzano strumenti AI.
La tesi centrale di Vogels è che l’AI non sostituirà gli insegnanti, ma ne ridefinirà il ruolo. Gli educatori potranno liberarsi da compiti ripetitivi e che richiedono tempo (risparmiando in media 5,9 ore alla settimana), per dedicarsi all’interazione creativa, al tutoraggio individualizzato e a stimolare la naturale passione per l’apprendimento.
L’obiettivo, conclude Vogels, è ricreare nell’istruzione le condizioni in cui gli individui prosperano, trasformando l’ambiente da un luogo di conformità a uno di fioritura della diversità.
L'articolo Dall’AI “empatica” alla sicurezza Quantum: i trend tecnologici che definiranno il 2026 (e oltre) proviene da Innovation Post.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































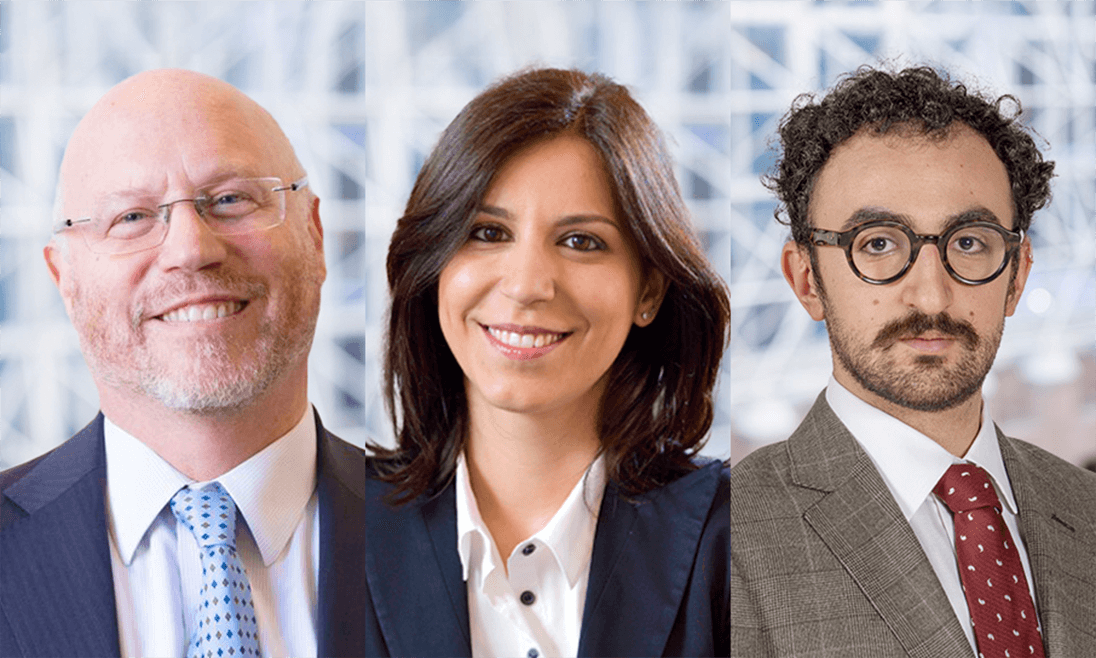


















































































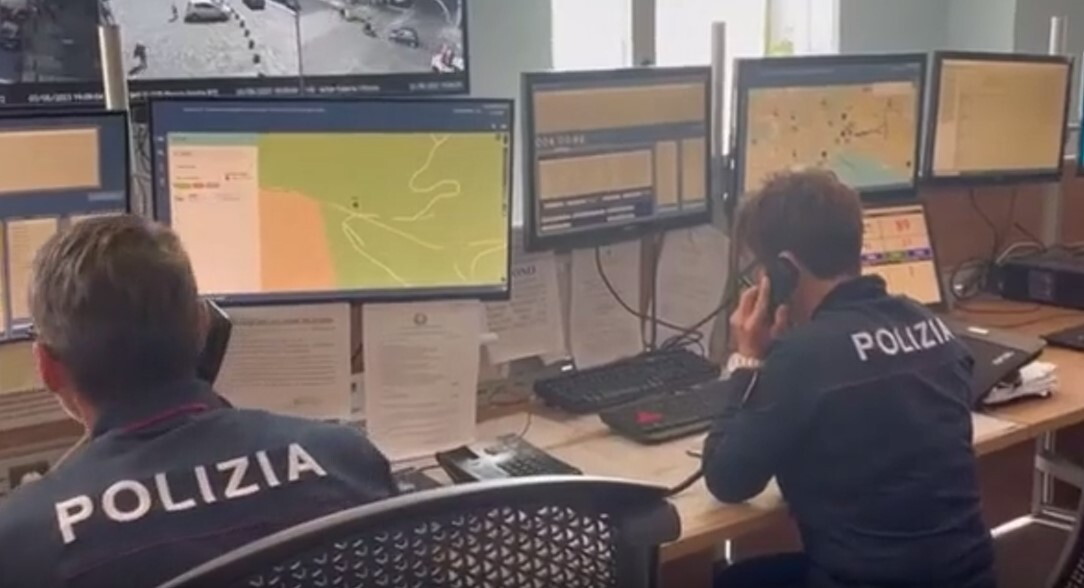
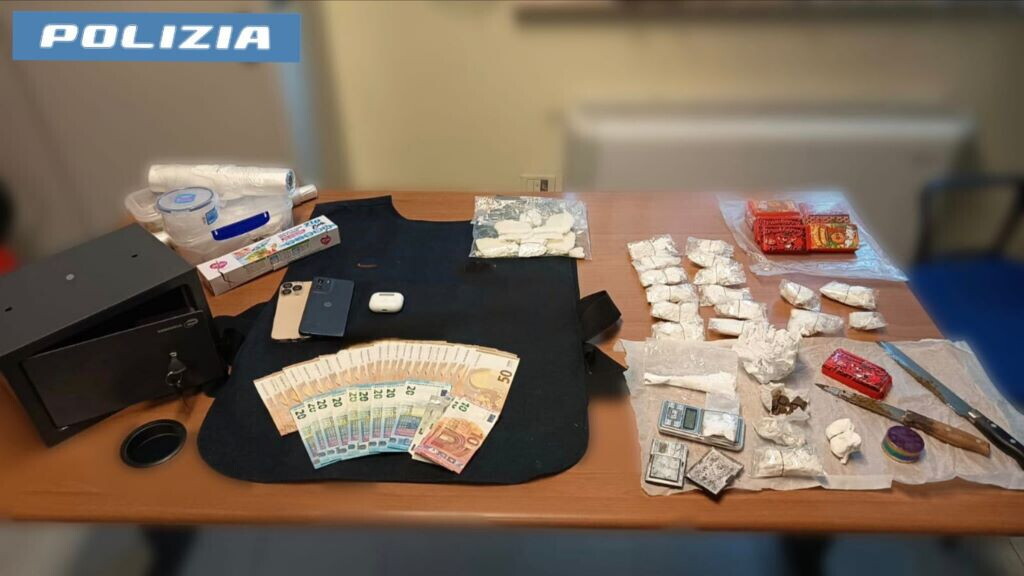
































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































