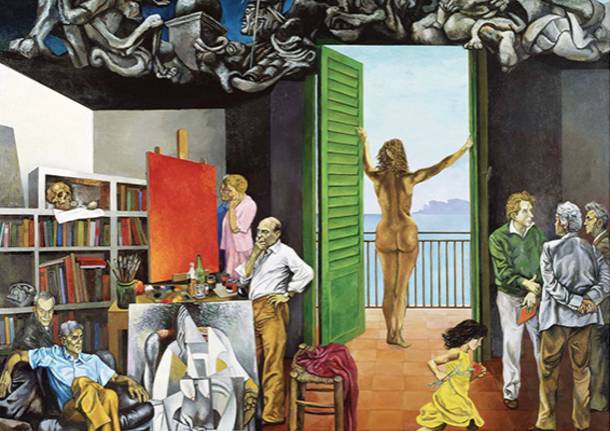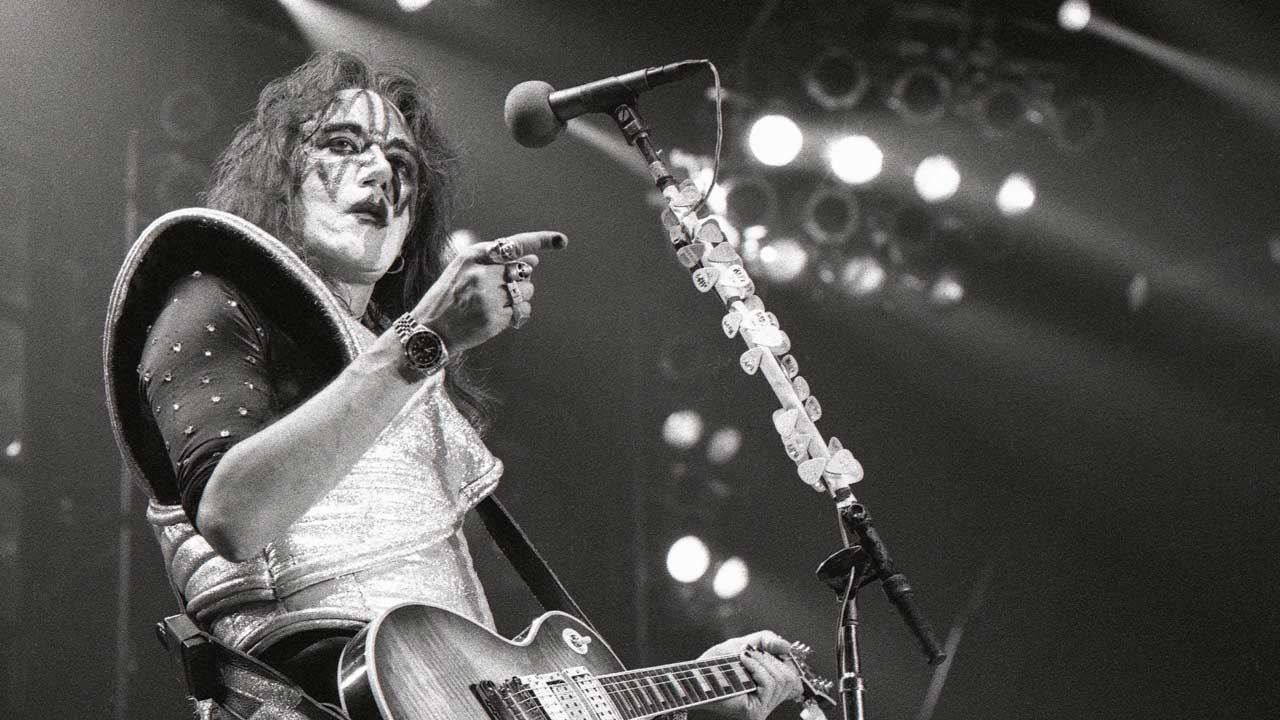E tu, lasci la mancia?


La mancia non è solo un piccolo gesto, ma una leva di politica del lavoro e di fiscalità, uno specchio delle disuguaglianze sociali e un simbolo culturale. Cambiarne il regime significa incidere sull’equilibrio tra Stato, lavoratori e consumatori, e ridefinire il valore sociale di un settore chiave come quello dell’ospitalità.
Se paghi il ristorante con la carta di credito, e succede sempre più spesso, lasciare la mancia può essere un problema. A seconda del Paese in cui ti trovi, parte di quella mancia sarà assorbita dalle tasse, e non andrà direttamente nelle tasche dei lavoratori. La mancia, inoltre, in alcuni mercati è parte integrante fondamentale dello stipendio, rendendola di fatto obbligatoria per permettere ai lavoratori di guadagnare a sufficienza. Tutti i cambi e le modifiche dei sistemi fanno discutere e cercano di legalizzare una pratica fino a pochi anni fa lasciata molto al singolo.
In Francia le mance (pourboires) sono attualmente esenti da imposte e contributi sociali. L’esenzione, introdotta nel 2022 per sostenere il settore della ristorazione e dell’ospitalità, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 e riguarda i dipendenti con retribuzione non superiore a 1,6 volte lo Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Dal 2026, salvo ulteriori proroghe, le mance torneranno a essere tassate come reddito ordinario. Le associazioni di categoria come l’Umih hanno espresso forte contrarietà, segnalando il rischio di un calo delle mance e di una perdita di attrattività per i lavoratori, che già sono pochi e sempre meno motivati. Così reagisce Thierry Marx, presidente della Confederazione: «Le mance non sono un privilegio, ma piuttosto un riconoscimento del servizio offerto al cliente. Tassarle e addebitare contributi previdenziali su queste mance equivarrebbe a una “tassa del sorriso”. Questa misura indebolirebbe ulteriormente il nostro settore, che fatica a reclutare e trattenere il personale, e avrebbe un impatto diretto sul potere d’acquisto dei nostri team e comprometterebbe la stabilità economica di molte aziende».
In Italia dal 2023 le mance percepite dai dipendenti di strutture ricettive e pubblici esercizi possono essere tassate con un’imposta sostitutiva del 5 per cento. La legge di bilancio 2025 ha ampliato i limiti: il regime si applica fino a un reddito complessivo da lavoro dipendente di 75.000 euro (prima 50.000) e per un importo di mance non superiore al 30 per cento del reddito annuo (prima 25 per cento), anche se il lavoratore può optare per la tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme devono essere indicate nella Certificazione Unica e nel modello 730. Le mance possono essere pagate con il Poi, quindi anche da chi non ha con sé contante, come sottolinea Fipe, anche se ancora in pochi si sono allineati a questa possibilità: «Grazie alla nuova normativa il numero di clienti che lascia le mance in modalità digitale è cresciuto sensibilmente, ma molto resta da fare e, per questo, la Federazione ha sollecitato il sistema bancario affinché i sistemi Pos prevedano questa funzionalità. Allo stesso tempo la Federazione sostiene l’importanza di informare i clienti dell’esistenza di questa opportunità».
Negli Stati Uniti le mance fanno parte integrante del reddito dei lavoratori e sono normalmente soggette a tassazione federale e contributi previdenziali (Social Security e Medicare). Nel luglio 2025 è stato approvato il No Tax on Tips Act, che introduce un’esenzione parziale: fino a 25.000 dollari annui di mance qualificate non saranno tassati a livello federale, misura valida dal 2025 al 2028. Restano in vigore gli obblighi di reporting al datore di lavoro per mance superiori a 20 dollari al mese per dipendente. Le modalità di applicazione e la definizione dei settori eleggibili sono demandate a regolamenti del Tesoro e dell’Irs (Internal Revenue Service).
Nel Regno Unito le mance sono considerate reddito imponibile e soggette a Income Tax. Se gestite tramite un tronc (sistema collettivo amministrato da un troncmaster), non sono soggette a contributi National Insurance; in caso contrario, sono assoggettate sia a imposta sia a contributi. Dal 1° ottobre 2024 è in vigore il Tipping Act, che obbliga i datori di lavoro a trasferire integralmente le mance ai dipendenti e a dotarsi di politiche scritte e registri di trasparenza. Il Department for Business and Trade ha pubblicato linee guida operative per l’applicazione della normativa.
Il confronto mette in luce quattro modelli: la proroga temporanea francese, la flat tax agevolata italiana, l’esenzione parziale e sperimentale statunitense e la tassazione ordinaria con regole di trasparenza britanniche. Quattro approcci diversi a una stessa pratica, che in ogni Paese è regolata in modo da bilanciare esigenze fiscali, tutela dei lavoratori e consuetudini culturali.
In qualunque Stato, la mancia va vissuta come un fenomeno che tocca tre dimensioni cruciali: economia, società e politica. Sul piano economico, la mancia è un flusso di reddito parallelo al salario. In alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, rappresenta una parte essenziale del guadagno dei lavoratori e solleva il tema delle distorsioni salariali: se la paga base resta bassa perché si presume un’integrazione da parte del cliente, il costo del lavoro viene di fatto scaricato sulla clientela. Allo stesso tempo, la fiscalità sulle mance diventa un laboratorio di politiche pubbliche.
La dimensione sociale è altrettanto rilevante. La mancia modifica il rapporto tra cliente e lavoratore, trasformando il riconoscimento in dipendenza: premia il sorriso o l’attenzione, ma rischia di accentuare dinamiche servili. Inoltre crea disuguaglianze interne: chi lavora in sala beneficia di un contatto diretto, chi resta in cucina o dietro le quinte riceve meno o nulla, con inevitabili tensioni. Infine, è un marcatore culturale: in Italia resta facoltativa, in Francia simbolica, negli Stati Uniti quasi obbligatoria.
Non mancano le implicazioni politiche. Sostenere fiscalmente le mance significa inviare un segnale a un comparto in crisi di personale, e diventa uno strumento di consenso. Ma è anche una questione di giustizia sociale: c’è chi vede la mancia come premio meritocratico e chi la considera un alibi per non alzare i salari. Ogni scelta normativa, dunque, è anche una presa di posizione sul valore del lavoro e sul ruolo dello Stato nel garantirlo.
La mancia, in apparenza un gesto minimo, è in realtà uno specchio fedele delle fragilità e delle aspirazioni del lavoro contemporaneo.
L'articolo E tu, lasci la mancia? proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































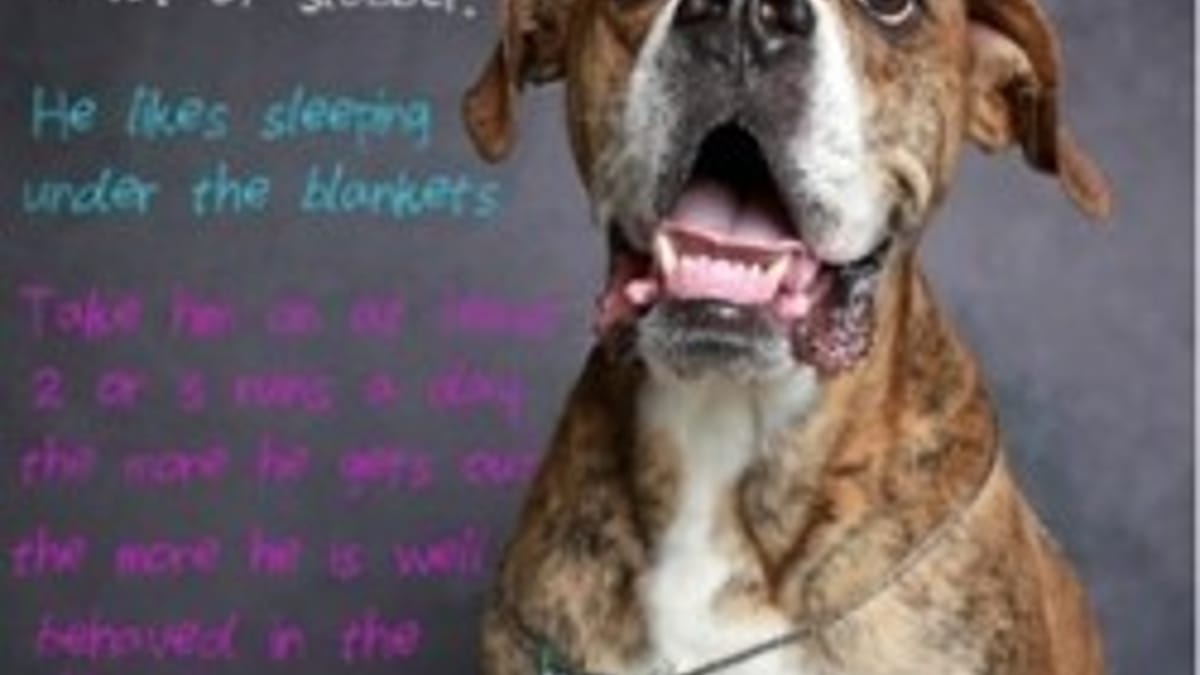













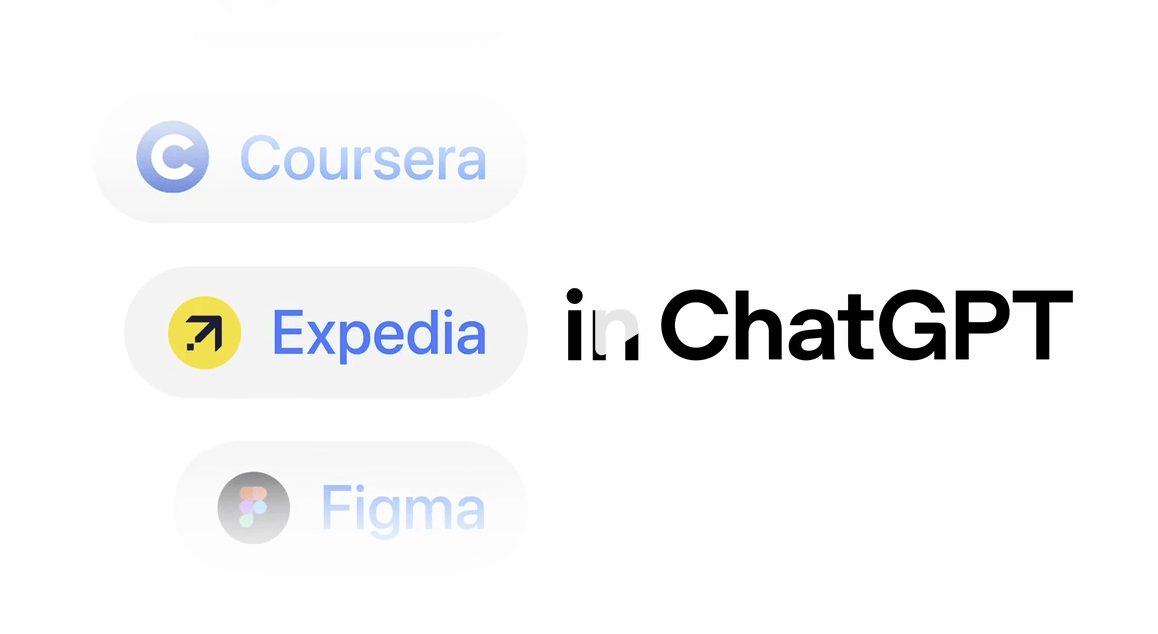














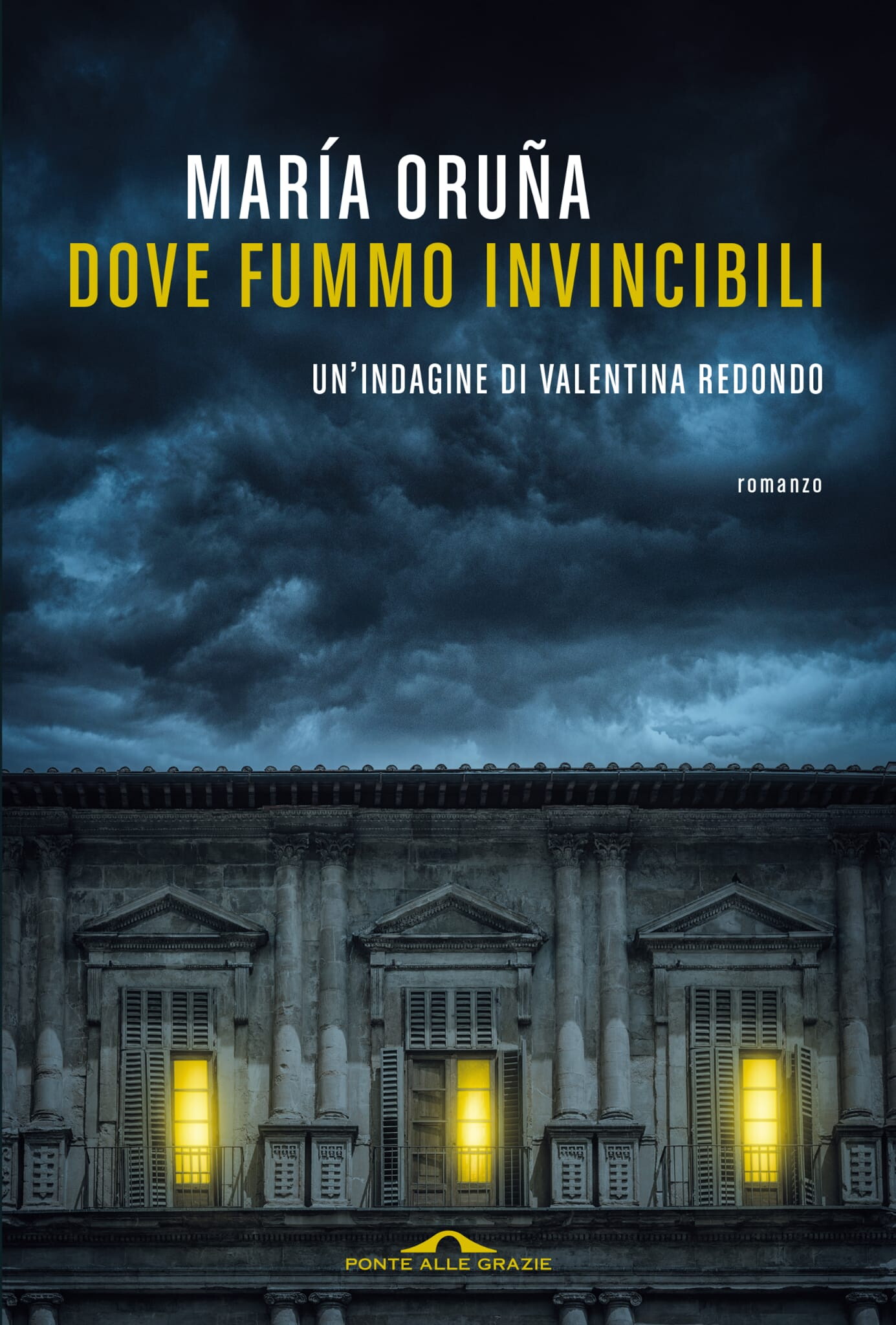
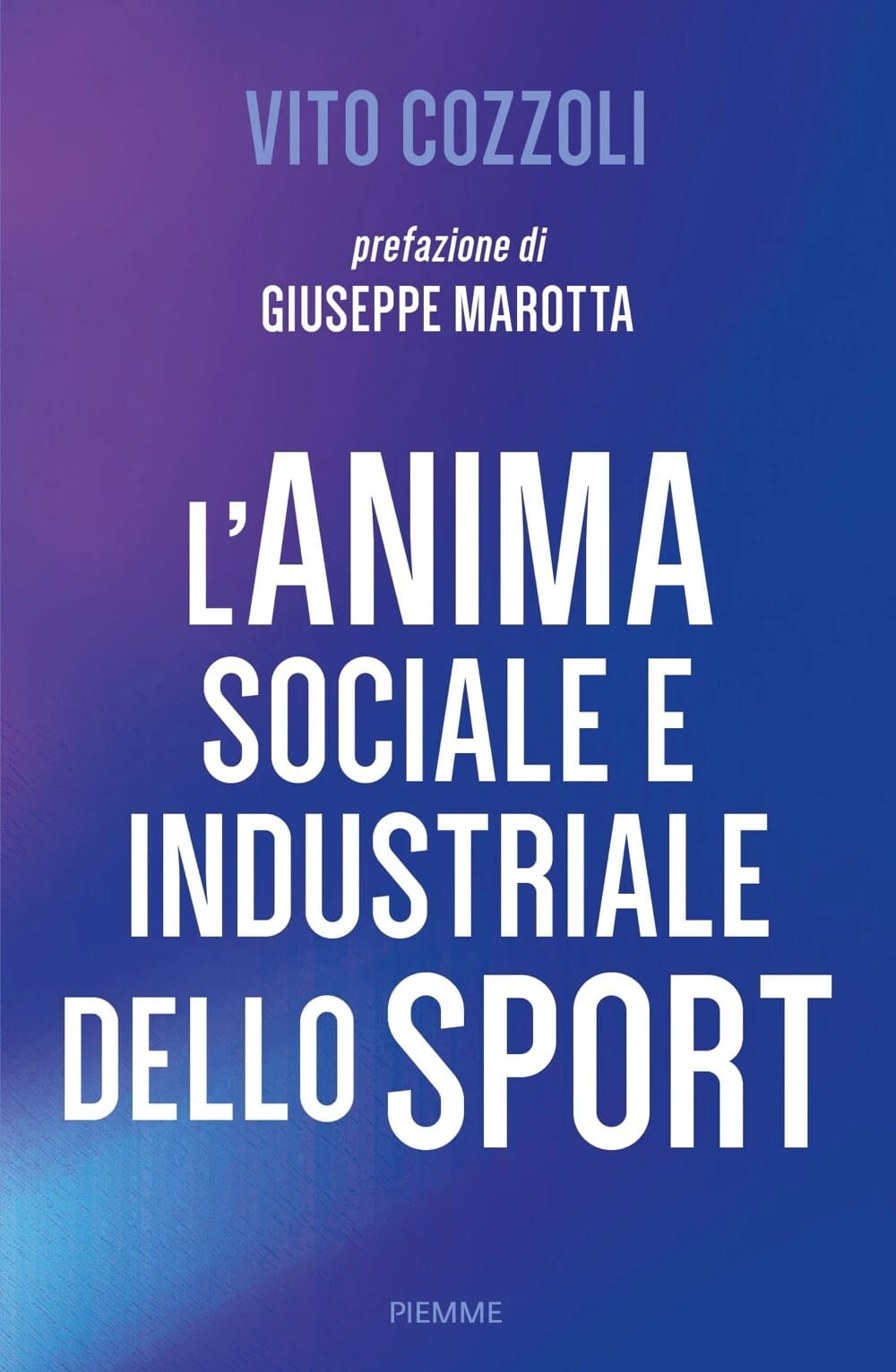
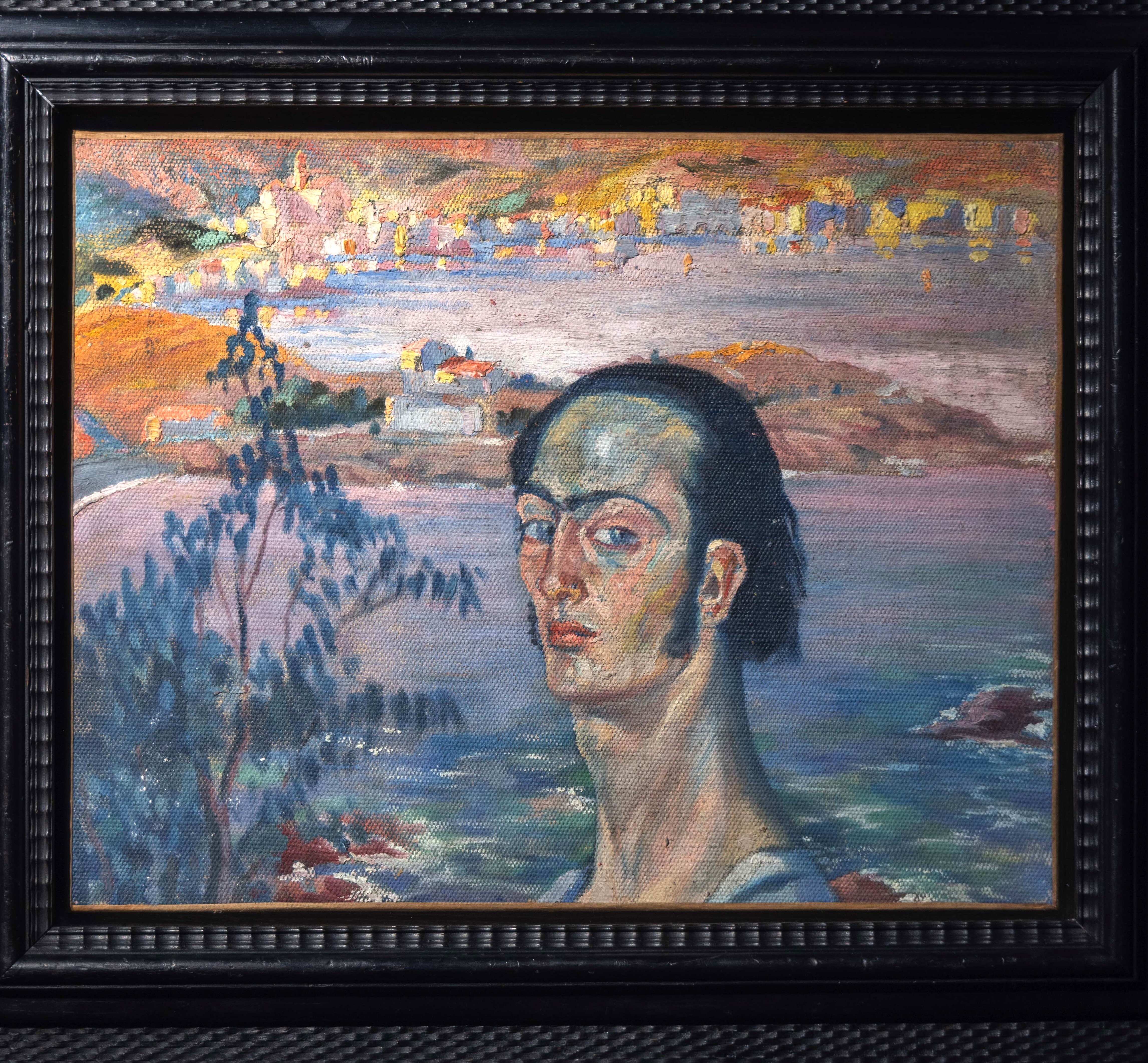







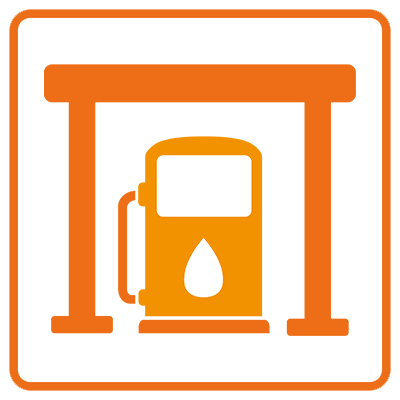





































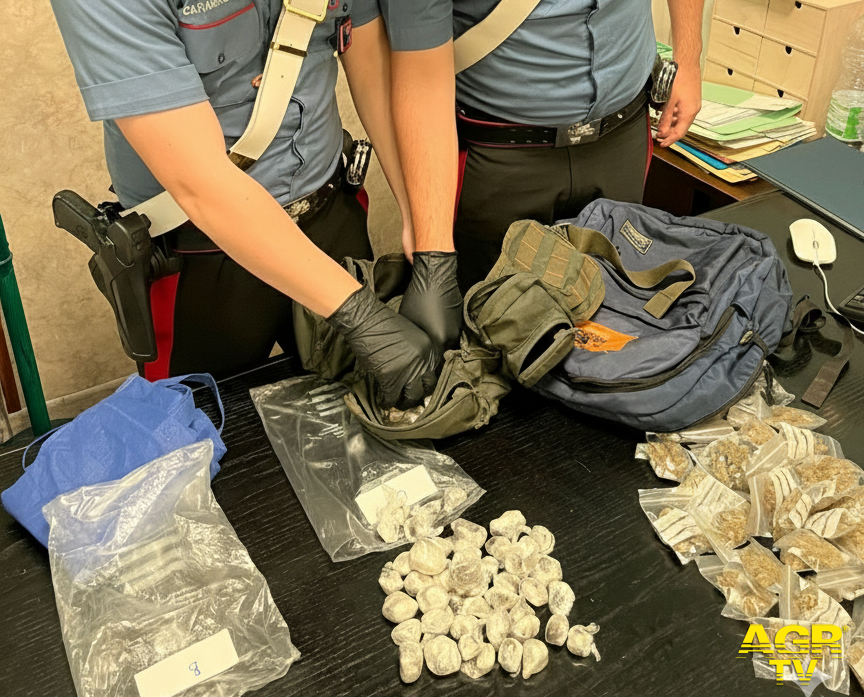

















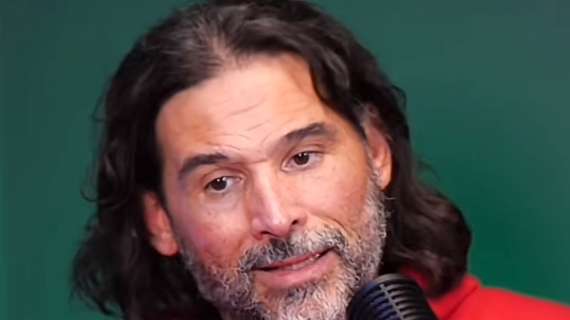

















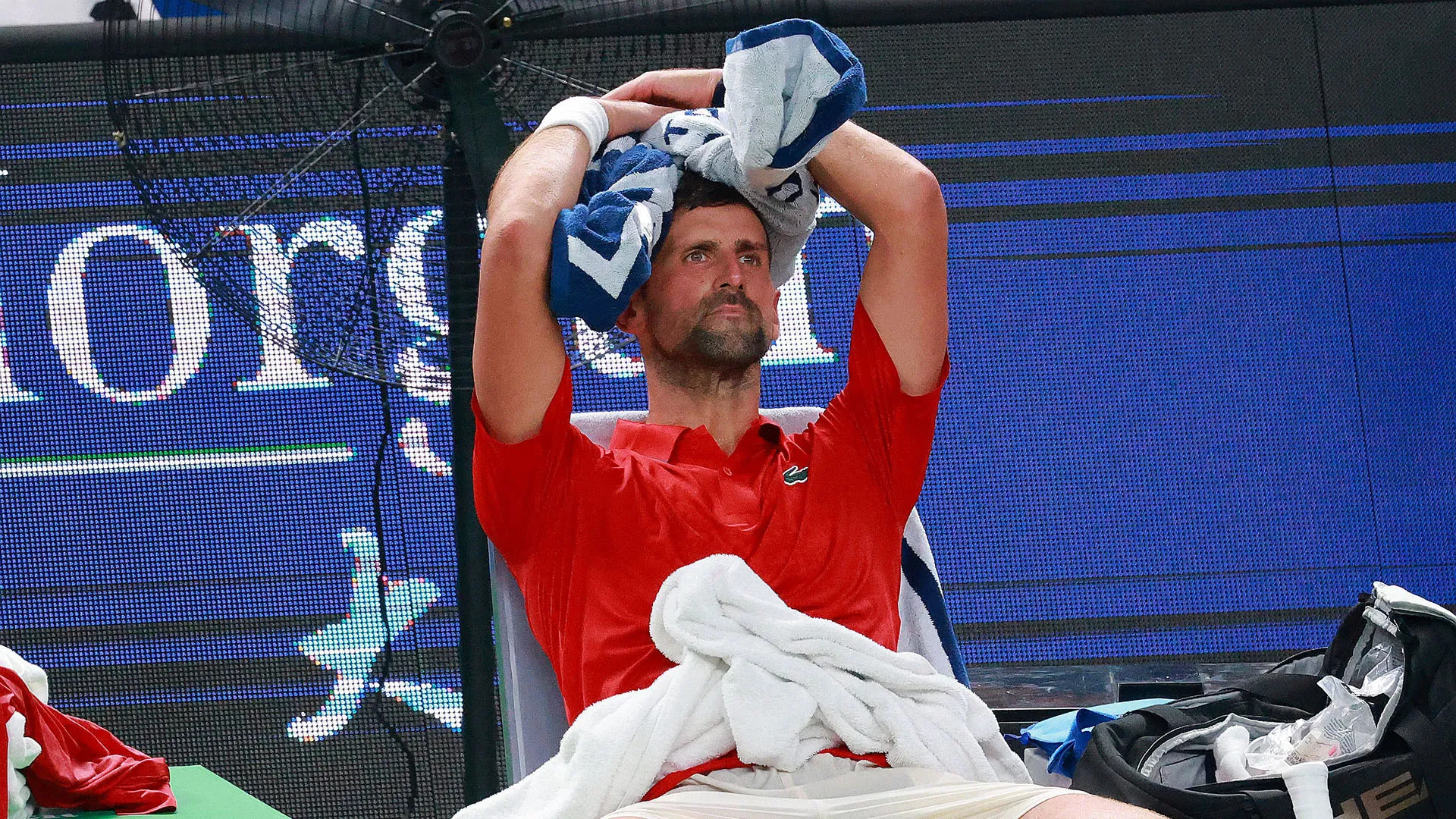















.png)










-1760794656640.jpeg--torino_intitola_tre_nuove_vie_rendendo_omaggio_a_tre_donne_di_eccezionale_valore.jpeg?1760794656733#)




-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)