I legami della globalizzazione contemporanea amplificano la portata delle crisi


La pandemia ha rappresentato uno degli shock sistemici più radicali a danno delle supply chain, inedito per portata ed estensione. In un panorama globale dove le catene del valore passano per decine e decine di paesi e giurisdizioni, centinaia o migliaia di imprese, fornitori e subfornitori, l’asimmetria delle politiche di lockdown, nonché dei tempi in cui si sono sviluppati i picchi nelle diverse aree geografiche, ha fatto saltare tutti gli schemi degli scambi commerciali.
O, meglio, ha costretto gli operatori a muoversi in una realtà frammentata e a tratti imprevedibile: ritardi corposi, rinegoziazioni dei contratti, sospensione di alcune forniture, contenziosi, modifiche nelle rotte commerciali, normative che hanno bloccato l’export per favorire il mercato domestico e via dicendo. Non serve pensare alle catene emblematiche, come quella dei semiconduttori o della produzione degli smartphone Apple: l’apparentemente più semplice vaccino Pfizer ha richiesto, in termini di indotto totale, 280 componenti da 86 fornitori in 19 paesi .
La pandemia e le relative implicazioni sulla fornitura di beni determinate dai rigidi lockdown iniziali hanno mostrato la fragilità di catene del valore troppo estese: per esempio, la difficoltà nel rifornimento di dispositivi sanitari, come le mascherine, ha evidenziato certe dipendenze da assemblaggi in paesi lontani ritenute pericolose in tempi di crisi sanitaria.
Ancora, la carenza dei già citati semiconduttori ha avuto un peso notevole nella crisi della produzione automobilistica, oltre che nell’ambito dell’elettronica, dagli smartphone alla Playstation 5, la cui uscita in quel periodo è risultata piuttosto in salita. Dopodiché, a essere colpito è stato soprattutto il motore dell’ingranaggio degli scambi globali, ossia il trasporto marittimo di merci, alla base della sincronizzazione domanda-offerta.
Se inizialmente, a causa delle rigorose chiusure in tutto il mondo, vi è stato un drastico calo dei trasporti, poi una (sorprendente) ripresa della domanda ha cambiato le carte in tavola. Gli stimoli monetari e fiscali attuati dai diversi paesi, in primis dagli Stati Uniti, hanno infatti guidato la ripresa della domanda mondiale di merci prima del previsto. A ciò va aggiunto il boom dell’e-commerce di prodotti elettronici, dettato dai lockdown, dallo smart working e dalla didattica a distanza.
Infine, diverse agevolazioni hanno alimentato alcune bolle nel settore edilizio, appesantendo la domanda di materie prime (legname, alluminio, acciaio, rame ecc.). Di fronte a questi – perlopiù inaspettati – fenomeni, il lato dell’offerta non era adeguatamente preparato: la scarsità di chip e semiconduttori non permetteva di soddisfare l’intera domanda degli operatori digitali e delle case automobilistiche; lo stop ad alcune produzioni durante i primi mesi di lockdown (pensiamo ai forni per l’acciaio) ha reso poco reattivi diversi produttori di fronte al repentino rialzo della domanda, con la conseguenza che la riattivazione dei processi industriali non è stata immediata; le tensioni geopolitiche aggravavano il tutto. […]
La pandemia ha illuminato l’articolato diramarsi delle catene del valore. Ricordandoci un aspetto tanto banale quanto spesso dimenticato: la globalizzazione va intesa soprattutto nella sua dimensione concreta, distante dalle narrazioni che l’hanno accompagnata, da sempre focalizzate sulla finanza, il digitale, le multinazionali dalla pretesa a-territorialità. La vera globalizzazione non è quella finanziaria o della libera circolazione dei capitali, bensì quella delle catene del valore delle merci che passano per decine e decine di paesi e del mezzo di trasporto che più le informa: il trasporto marittimo, senz’altro poco ecologico, ma il più conveniente per lo scambio di beni. […]
Merci, materie prime e risorse energetiche – la cui catena produttiva coinvolge più paesi secondo una logica ricardiana di abbattimento dei costi (ogni paese si occupa del segmento in cui è più utile) – giungono dunque nei mercati di sbocco finale dopo essere state caricate in navi portacontainer, cargo, bulk carrier, petroliere ecc.
Il trasporto aereo, invece, movimenta perlopiù merci ad alto valore aggiunto o a rapida deperibilità, mentre il trasporto ferroviario e quello su gomma operano nelle brevi tratte, spesso a seguito di trasbordo dai porti in un’ottica multimodale. Un mondo materiale, enfatizzato da eventi simbolici e non solo come l’incaglio della nave Evergiven nel canale di Suez nel marzo 2021. Ci siamo ricordati della centralità delle attività portuali in Cina al fine di ricevere i beni sotto la porta di casa quando si sono registrati i primi ritardi dovuti alle congestioni degli scali.
Ancora, abbiamo avuto modo di cogliere i rischi insiti nella scarsità delle scorte di magazzino in occasione di alcuni shock sistemici: è il caso dei componenti medici nella prima fase della pandemia o di alcuni connettori wire per la produzione di jets Boeing, ritardata tra il 2021 e 2022. In questi frangenti abbiamo sperimentato come l’intero apparato della globalizzazione dipenda dalla capacità di organizzare i singoli segmenti, coordinare tempi, spazi e persone. In altre parole, le crisi degli ultimi anni hanno intaccato e allo stesso tempo valorizzato la componente essenziale della globalizzazione contemporanea, ossia appunto la logistica.

Tratto da “Linee invisibili. Geografie del potere tra confini e mercati”, di Luca Picotti, Egea, pp. 14-17,16,06 €
L'articolo I legami della globalizzazione contemporanea amplificano la portata delle crisi proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































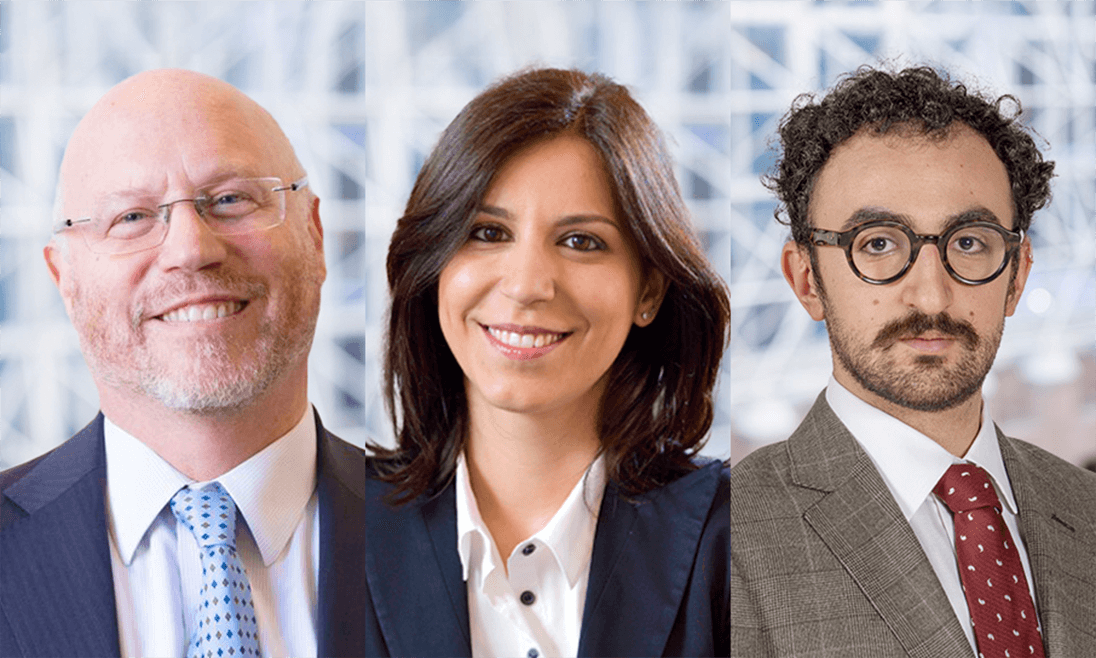


















































































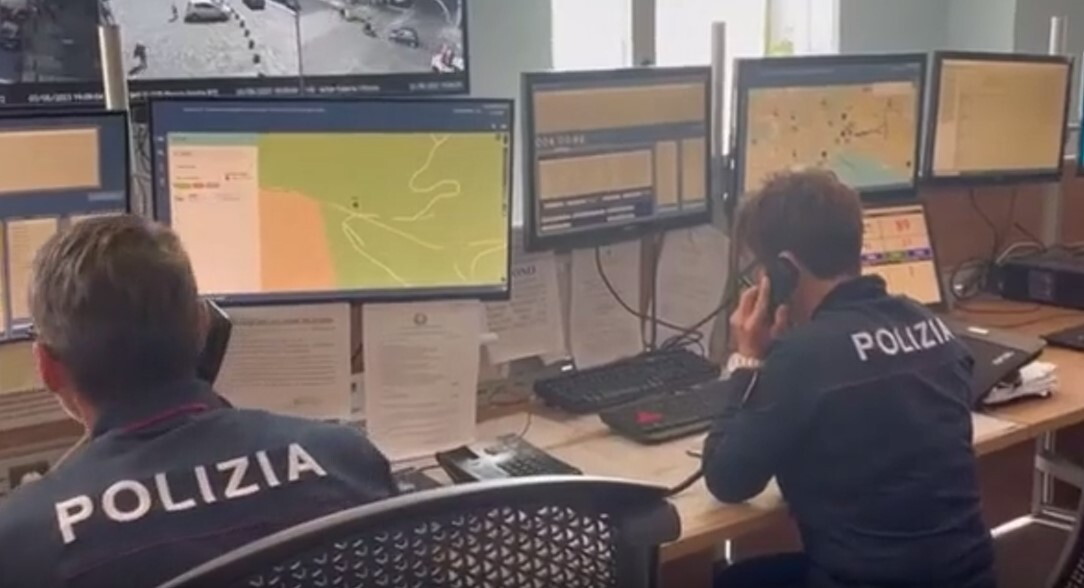
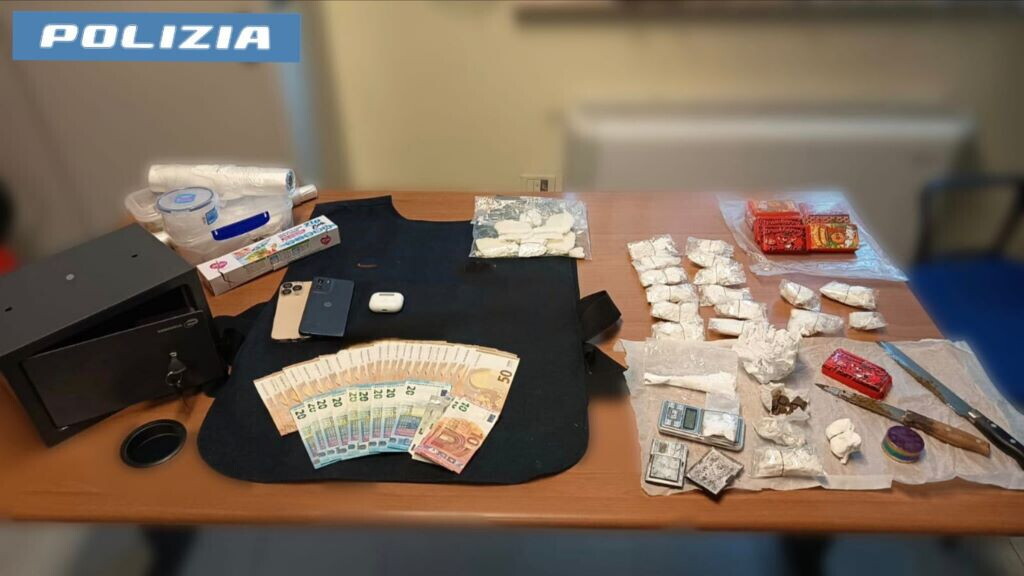
































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































