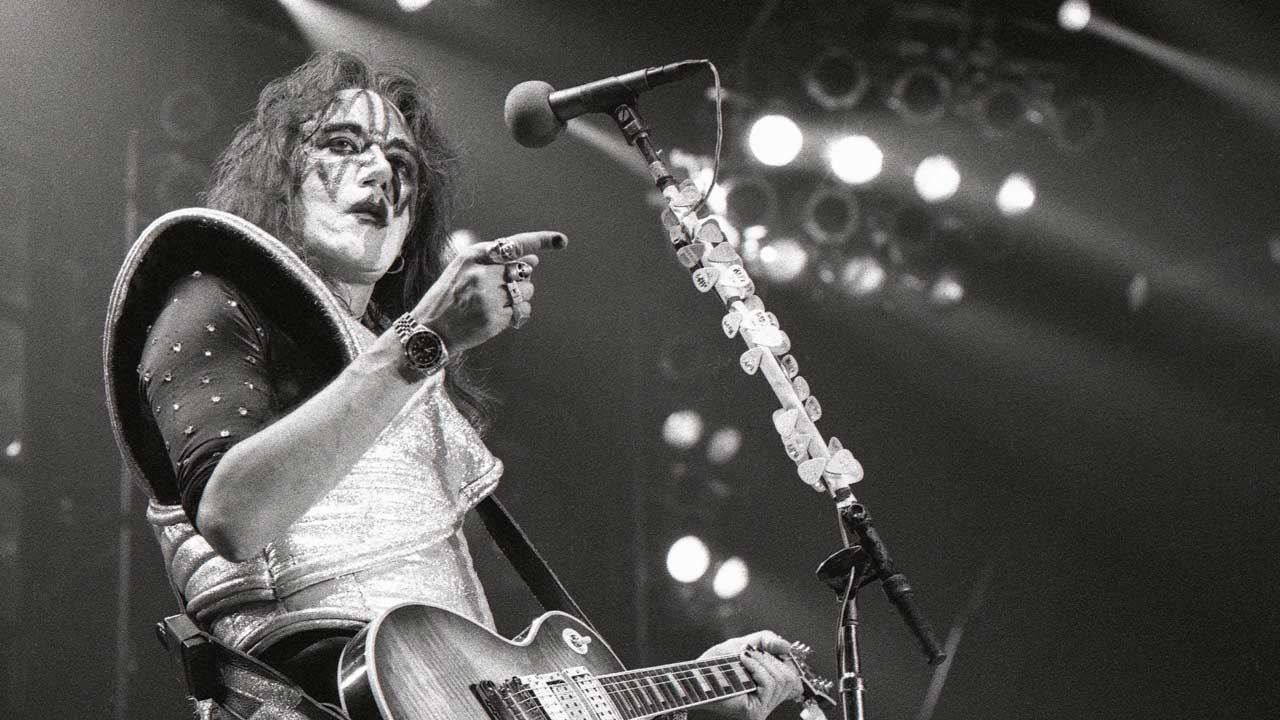Abusi, le parole della prevenzione: vulneranza


Nelle vicende di abuso di coscienza, spirituale e sessuale accertate in campo ecclesiale si sono verificate delle costanti oggettive di funzionamento e di mentalità che hanno influito in modo decisivo: la sacralizzazione del leader, l’accentramento autoreferenziale del potere, la mancanza della cultura dell’errore, la prevalenza della cultura dell’omertà. Oltre a chi abusa e alla vittima che subisce, perché si realizzi un abuso è necessario che ci sia un terzo attore: gli oggettivi elementi contradditori del contesto ecclesiale.
Significato
L’abuso non si può adeguatamente comprendere pensando che si realizzi esclusivamente tra due persone, ma occorre riconoscere l’influenza determinante del contesto comunitario, istituzionale e sociale. Il termine vulneranza esprime gli elementi oggettivi di un contesto, di una istituzione, di una prassi educativa e pastorale che, come possono essere un pericolo rispetto alla vulnerabilità delle persone, sono come un piano inclinato che induce più facilmente tutto il sistema a favorire dinamiche abusanti.
La vulneranza quindi riconosce come importante un terzo attore, oltre a chi abusa e a chi subisce: il “contesto sistemico” degli abusi. Il concetto di “sistema”, inteso in senso ecclesiale, comprende la missione, le norme e le strutture necessarie per realizzare il mandato originario della Chiesa e per garantire la sua continuità. Tutti gli elementi del sistema possono, se utilizzati in maniera distorta, influire direttamente o indirettamente nel permettere, favorire e coprire abusi al loro interno, nonostante ciò che viene dichiarato nel messaggio cristiano.
Per favorire un’opera di vera prevenzione e predisporre ambienti sicuri, si dovrebbe sviluppare un’analisi precisa del funzionamento delle istituzioni, delle concezioni teologiche e dei simboli. In questa scheda essenziale ci limitiamo a indicare alcuni funzionamenti e i relativi linguaggi oggettivamente pericolosi.
La sacralizzazione di una persona. All’interno di sistemi gerarchici, nei quali la concentrazione del potere si focalizza su una sola persona, gli abusatori agiscono in modo arbitrario. In alcune realtà si arriva alla sacralizzazione di una persona che riveste il ruolo di leader, come un sacerdote o il capo carismatico di un movimento, attraverso alcune concezioni teologiche errate o incomplete per giustificare prassi autoritarie e arbitrarie.
L’accentramento del potere. I consigli e gli organismi di controllo non ci sono e, se ci sono, sono succubi al carisma del leader. Il leader è autoreferenziale, non ci sono veri interlocutori, ma solo sostenitori che difendono l’operato del capo. Non si realizza nessun confronto e nessuna verifica con persone esterne alla comunità, al movimento, alla ristretta comunità ecclesiale di appartenenza. Sistemi chiusi che si reggono sull’accentramento dei poteri sono ad alto rischio di abuso.
La mancanza di una cultura dell’errore. Un altro elemento di vulneranza di un sistema è la presenza di una sottocultura teologica, spirituale e pastorale ambivalente, che da una parte proclama alti valori ideali e dall’altra tende a sminuire e normalizzare ogni scandalo. Manca l’applicazione di una cultura dell’errore, che porta a confrontarsi con gli sbagli affrontandoli in modo adeguato non solo a livello personale, ma anche istituzionale.
Gli spettatori e la cultura dell’omertà. Infine, è importante considerare un ulteriore elemento di vulneranza: la mancanza di reale corresponsabilità e di processi di sinodalità effettiva. Tale modalità assolutizzante riduce le persone della comunità o del gruppo a spettatori passivi più che a corresponsabili protagonisti. In questo modo nel sistema si crea una cultura del silenzio e della negazione collettiva che riduce la possibilità di reagire agli abusi in modo responsabile e coraggioso, sia in senso evangelico sia civile.
Domande
1) In riferimento al nostro contesto ecclesiale, quali aspetti (funzionamenti, automatismi, concezioni, linguaggi, simboli…) riteniamo distruttivi, rigidi, confusivi e ambigui rispetto a un cammino di comunione e corresponsabilità?
2) Quali organi di consiglio e di decisione mancano o potrebbero procedere con un dialogo più aperto, trasparente e competente secondo il magistero attuale della Chiesa?
3) Quanto sarebbe non solo importante per la prevenzione di eventuali abusi, ma anche generativo per il cammino della comunità aprirsi a un ascolto e a una supervisione esterna dei processi educativi, formativi e decisionali della nostra comunità? Possiamo pensare di proporre questi passi nella nostra comunità?
Strumenti
DEODATO A. – FUCKS K., Vulnerabilità: aspetti personali e sistemici, “Tredimensioni”, 21 (2024), (Aspetti sistemici), pp.260-269.
EUGENIO L., Dalla vulnerabilità alla vulneranza. I contesti e le dinamiche istituzionali dell’abuso, “Tredimensioni”, 1/2023, pp. 54-64.
FUMAGALLI A., Lo scandalo dei piccoli. Approcci teologico-morali agli abusi nella Chiesa, in “Abusi nella Chiesa. Un approccio interdisciplinare” (Ancora, Milano 2025), a cura di Corbella C. e Ceragioli F. (Fattori sistemici), pp 136-145
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


































































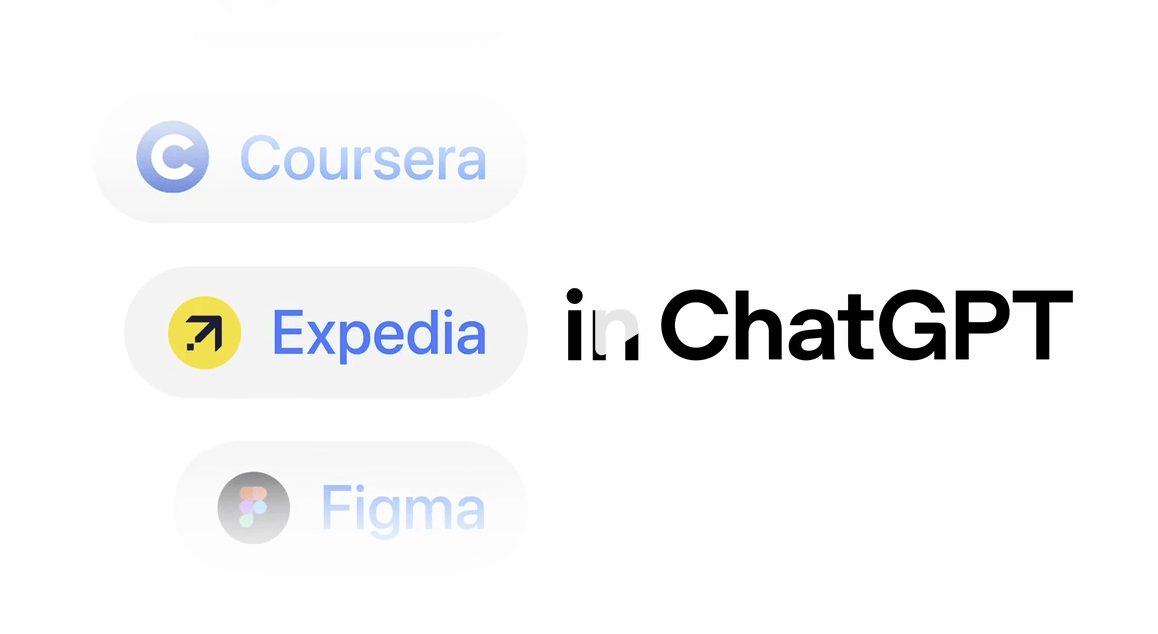


















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184280.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184278.jpg)




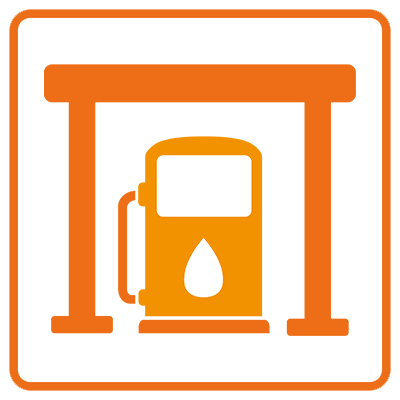












































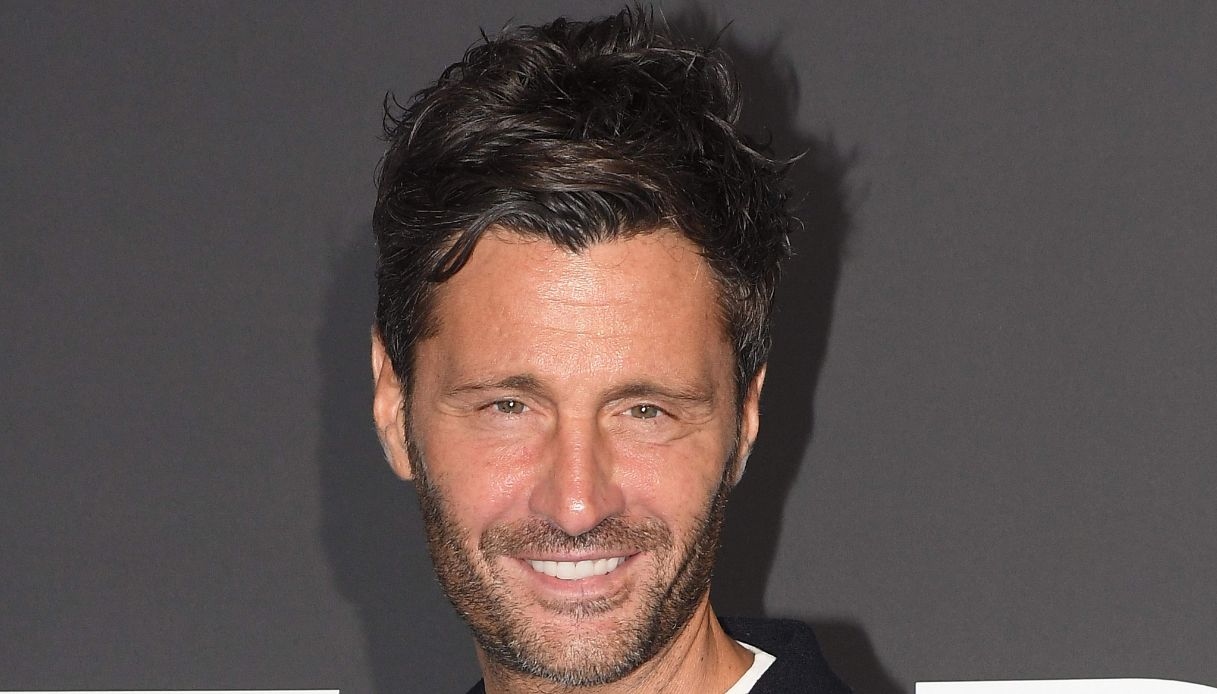





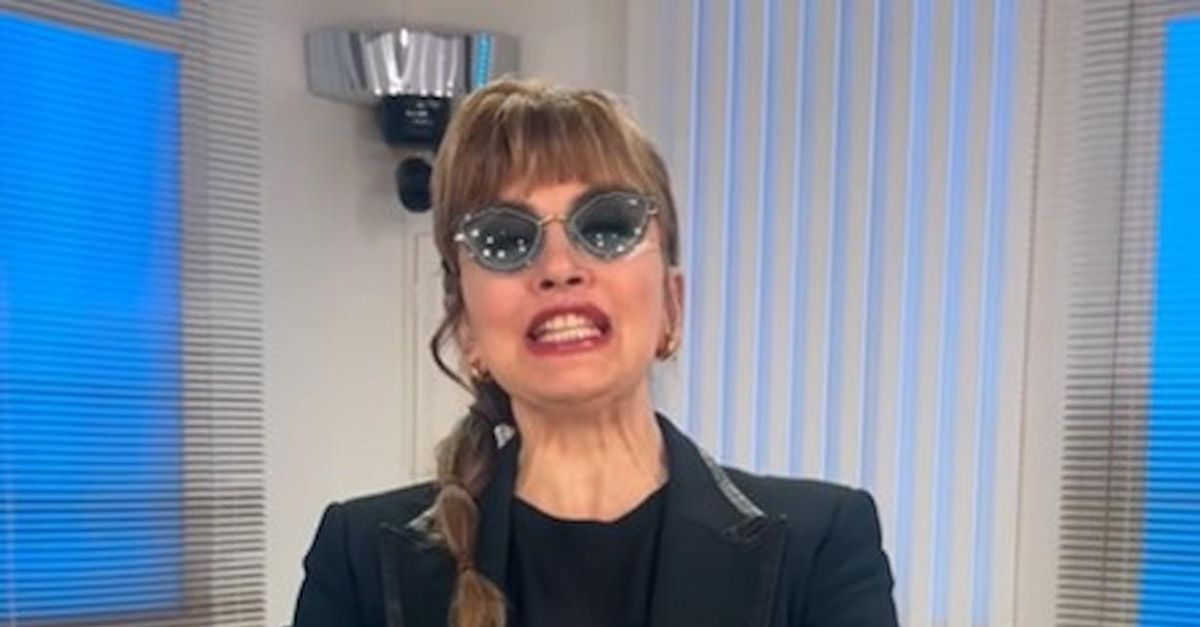


























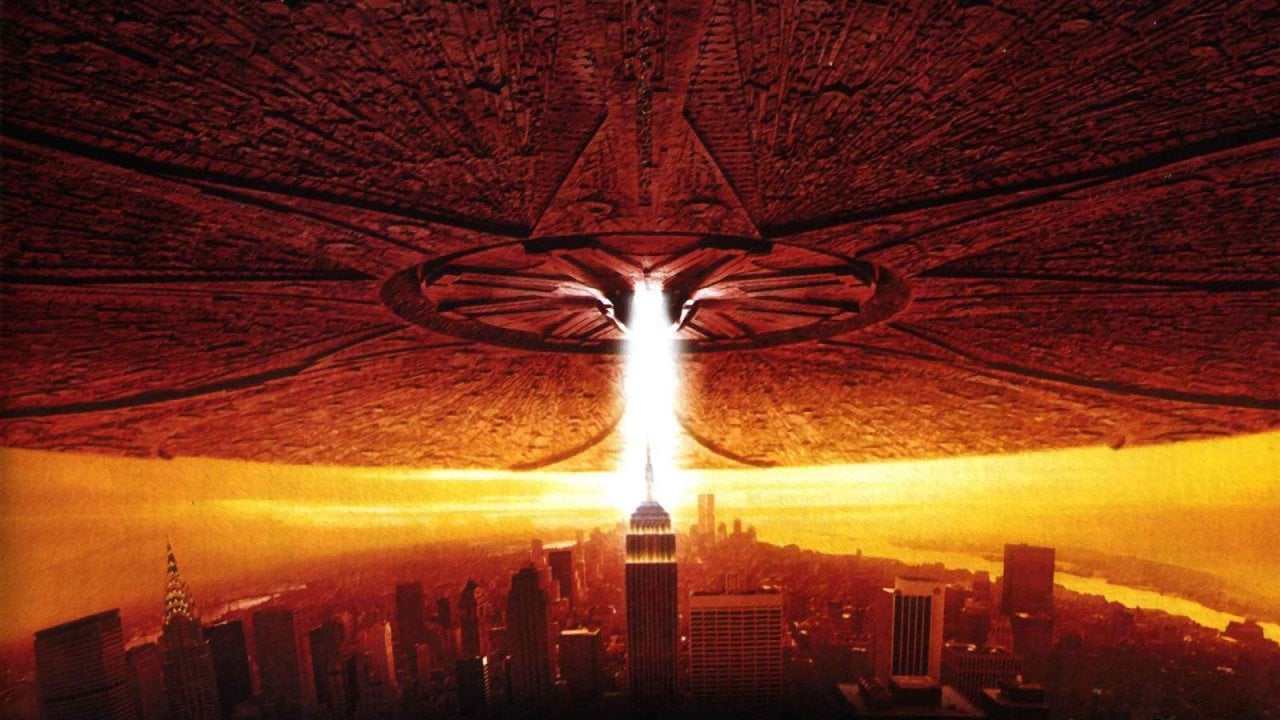
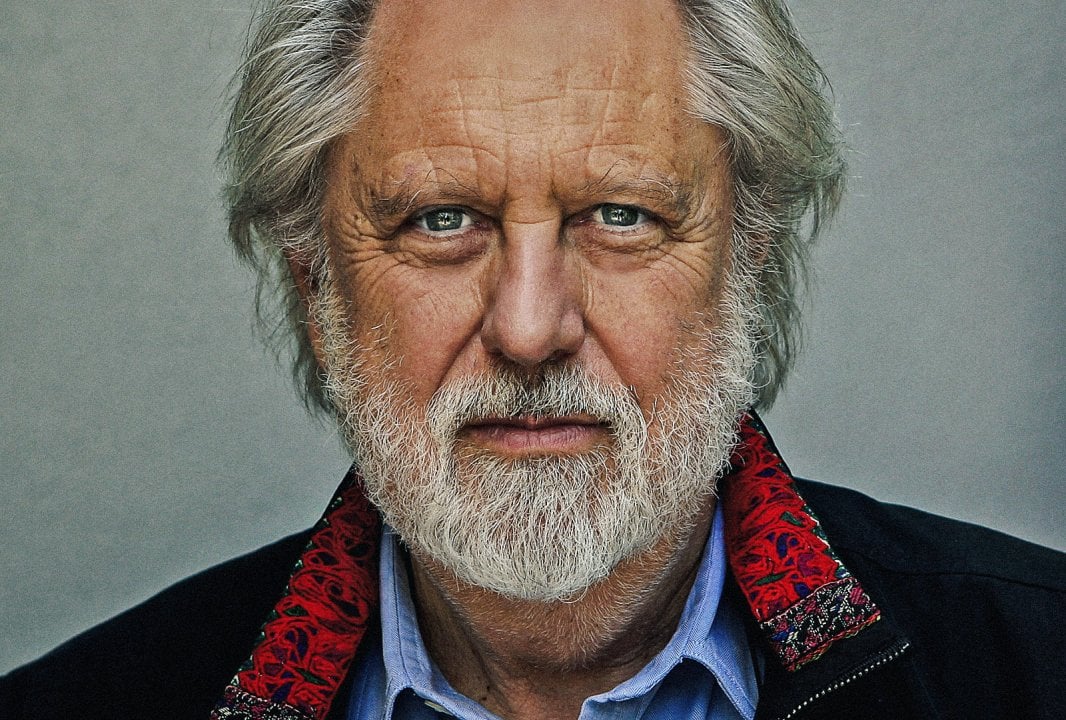





.png)




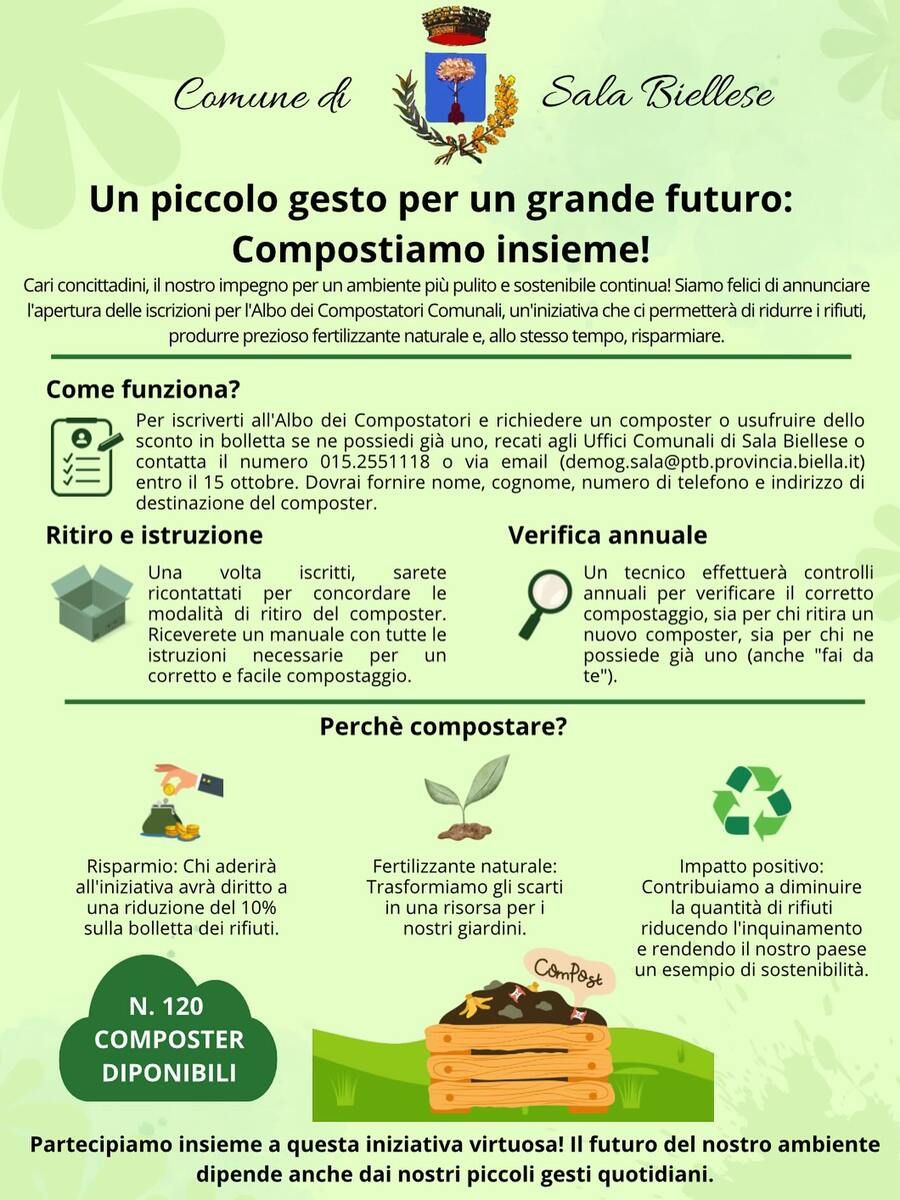





-1760794656640.jpeg--torino_intitola_tre_nuove_vie_rendendo_omaggio_a_tre_donne_di_eccezionale_valore.jpeg?1760794656733#)




-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)