Bellegra, la città dei panorami, una terrazza a 360 gradi sul Lazio

Adagiato in cima al Monte Celeste nell’entroterra laziale, Bellegra è un punto d’incontro tra cielo e terra, un borgo dove lo sguardo si perde tra le vallate e ogni dettaglio invita a rallentare, a respirare l’aria pulita che profuma di bosco e di pietra antica.
La posizione è spettacolare: da un lato si apre la Val d’Aniene, dall’altro si allunga la Valle del Sacco, e intorno una corona di rilievi (gli Ernici, i Lepini, il Monte Scalambra) a delimitare l’orizzonte con i colori che cambiano a ogni ora del giorno: all’alba, la nebbia risale lenta dai fondovalle, al tramonto, invece, le sfumature violacee e dorate disegnano un paesaggio che ricorda una pittura rinascimentale.
Bellegra è il rifugio perfetto per chi ama camminare nei boschi, pedalare tra sentieri poco battuti o ascoltare il silenzio tra un ruscello e una radura. Una terrazza naturale da cui godere a 360 gradi dell’anima più autentica del Lazio.
Radici antiche e sapori di festa: la storia viva di Bellegra
Le origini di Bellegra affondano nella storia più remota del Lazio. Già nel VI secolo a.C., la cima del Monte Celeste ospitava gli insediamenti degli Equi, poi passati agli Ernici e infine inglobati nella potenza romana: è a loro che si devono le mura poligonali che ancora oggi affiorano tra le case del centro storico.
Nel periodo romano, il borgo era conosciuto come Vitellia, e proprio a questa antica identità si ispira oggi il corteo storico della Gens Vitellia, che si svolge in autunno accompagnando la Sagra delle Tacchie. Durante la festa, le strade si riempiono di profumi che arrivano dai funghi porcini dei boschi e dalla pasta fatta a mano secondo la tradizione.
Ma non è l’unico momento in cui Bellegra si accende. A luglio, la Sagra del Fallacciano celebra i fichi locali, dolcissimi e carnosi, con eventi che uniscono folklore, musica e sapori di un tempo.
Panorami sacri, misteri sotterranei e testimonianze di fede
Bellegra è un piccolo scrigno di meraviglie, da esplorare con occhi curiosi e spirito lento. Il centro storico conserva testimonianze evidenti del passato romano: tra tutte, i resti del tempio della dea Bona e le mura ciclopiche che costeggiano il borgo, imponenti nella loro solidità millenaria. Costruite secondo l’Opus Cementicius, tecnica tipica dei Romani, illustrano una storia di difesa, ingegno e permanenza.
Fino al XIX secolo Bellegra era chiamata semplicemente “Cittadella”, un nome che ancora oggi risuona nel carattere raccolto e fiero del paese.
A circa due chilometri dal centro abitato, nascosto tra faggi e castagni a 815 metri d’altitudine, si apre un luogo di pace e spiritualità: il Sacro Ritiro di San Francesco, la cui origine è legata al passaggio del Santo d’Assisi nel 1223, in viaggio verso il Sacro Speco di Subiaco: si racconta che qui, colpito dalla bellezza del luogo, decise di fermarsi con i suoi compagni.
Quel piccolo rifugio iniziale, semplice e povero, si trasformò nei secoli in un complesso armonioso grazie anche all’opera di Tommaso da Cori, che nel Seicento ne fece un punto di riferimento per la comunità francescana.
Oggi, oltre alla chiesa e agli spazi del convento, si può visitare un piccolo Museo Francescano dove sono conservati oggetti, documenti e testimonianze di vita monastica di valore inestimabile.
Tra gli edifici religiosi del centro spicca poi la Chiesa di San Nicola, impreziosita da stucchi barocchi risalenti al periodo precedente il 1671. Al suo interno è inglobata una struttura ancora più antica, l’oratorio duecentesco dedicato a Santa Lucia, custode di fede e devozione popolare.
Ma le meraviglie di Bellegra non si fermano in superficie. A circa quattro chilometri a est del paese, si apre un mondo sotterraneo affascinante: le Grotte dell’Arco. Questa cavità carsica, lunga quasi un chilometro e alta fino a trenta metri, è un viaggio nel cuore della terra. Stalattiti e stalagmiti disegnano geometrie naturali, mentre gli inghiottitoi e le cavità celano tracce di epoche lontanissime: resti di fauna del Paleolitico, testimonianze dell’industria litica del Mesolitico e affreschi primitivi dalle forme antropomorfe e zoomorfe.
Le grotte prendono il nome da un suggestivo arco naturale in pietra, visibile più a valle rispetto all’ingresso, che segna un punto d’incontro tra natura e leggenda, tra geologia e immaginazione.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































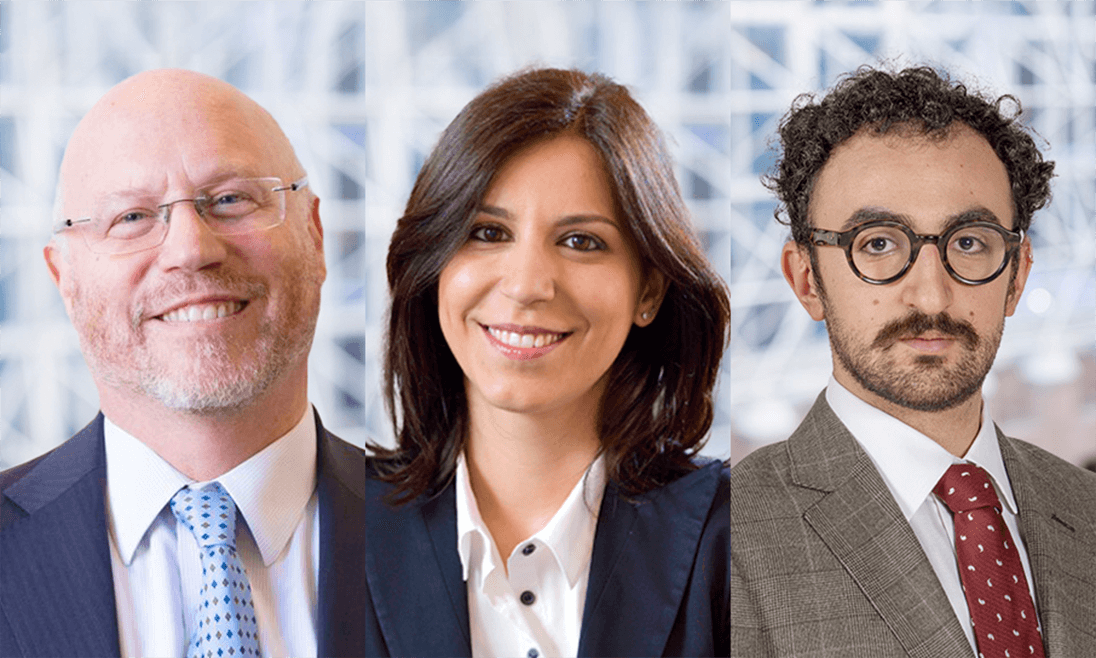




















































































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































