Castagne: la coltivazione italiana langue


Grande fonte alimentare per secoli, il castagno è sempre stato anche custode dell’agro biodiversità forestale. Ma anche in questo caso la crisi climatica incombe
La storia del castagno in Italia è la storia dell’albero del pane delle nostre aree montane e collinari ed è stato fondamentale nelle regioni dove la coltivazione di cereali era difficile.
Per secoli, le castagne sono state la fonte primaria di alimento, hanno avuto un ruolo fondamentale nel sostentamento dei poveri e delle comunità alpine e delle aree interne.
La crisi della castanicoltura, avviata negli anni ’50, è strutturale dal momento che la produzione nazionale non soddisfa la domanda. L’Italia è costretta a importare circa 20mila tonnellate annue di castagne, secondo il rapporto Ismea La castagna, superando il volume prodotto internamente e coprendo meno del 50% del fabbisogno nazionale.
La vera partita si gioca sulla distinzione netta tra la qualità del Marrone – frutto pregiato con polpa dolce e pellicola interna non aderente – e la castagna generica, destinata al volume e all’industria.
Coltivazione della castagna, ma cosa è successo?
Il declino della castanicoltura è innescato da avversità come il parassita Cinipide Galligeno e amplificato dal cambiamento climatico, che destabilizza la fioritura e minaccia la vitale produzione di miele.
Nonostante tutto, l’asse produttivo è fortemente polarizzato: l’87% delle superfici specializzate, sempre secondo Ismea, si concentra in sole sei regioni, con la Campania in testa (45%). La superficie dedicata a castagneti specializzati in Italia risulta, sempre dai dati Ismea, pari a 36mila ettari.
Il settore castanicolo non è un blocco unico, ma è attraversato da una profonda frattura economica a due velocità. Da un lato, e qui individuiamo la prima velocità, i produttori aderenti ai Consorzi Dop/Igp riescono a generare un reddito sufficiente a coprire i costi di gestione, grazie al posizionamento sul Marrone e all’accesso ai mercati premium.
Dall’altro lato (la seconda velocità), le piccole proprietà e le vaste aree isolate sono schiacciate dalla concorrenza sui volumi della castagna generica e lavorano con margini minimi o in perdita. Questo porta all’inevitabile abbandono della coltivazione.
L’abbandono ha un costo ambientale enorme: i castagneti smettono di essere custodi dell’agro-biodiversità forestale. Questa ricchezza consiste nelle varietà locali e antiche (la biodiversità genetica) selezionate in secoli di storia contadina.
La perdita di gestione di questi boschi aumenta il rischio di dissesto idrogeologico e impoverisce il nostro patrimonio genetico.
La risposta al Cinipide è arrivata dalla scelta della lotta biologica, attraverso l’introduzione del parassitoide Torymus sinensis. Questa strategia ha stabilizzato la salute dei boschi e aperto la strada alla certificazione biologica (Bio).
Oggi, il futuro del castagno poggia sulla combinazione di Dop/Igp + Bio. Questo modello garantisce l’eccellenza e offre la speranza di un futuro in cui il valore del frutto sia sufficiente a remunerare le comunità che fungono da custodi attivi e permanenti di questo inestimabile territorio montano.
articolo redatto da Gianmario Folini
Crediti immagine: Depositphotos
L'articolo Castagne: la coltivazione italiana langue è stato pubblicato su GreenPlanner Magazine.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















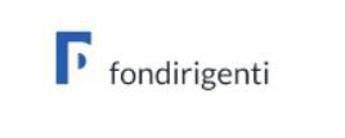




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































