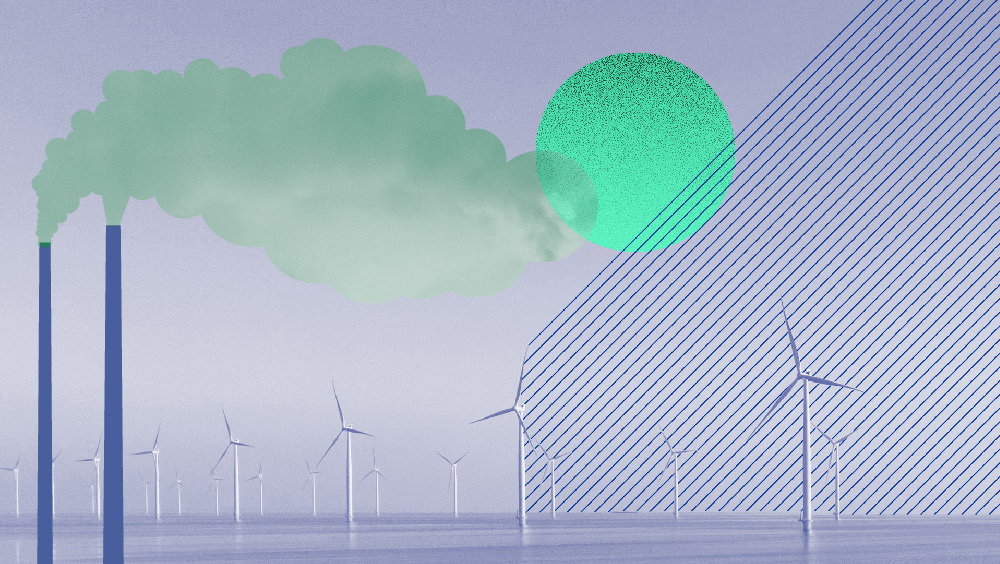Giustizia climatica in tribunale: la sfida dei cittadini contro l’inerzia dello stato


La possibilità per associazioni e cittadini di rivolgersi al giudice per la tutela di interessi collettivi o diffusi, soprattutto in ambito climatico, è legata strettamente alla loro legittimazione ad agire: vediamo cosa significa…
Negli ultimi anni è sempre più frequente il ricorso al contenzioso climatico, ovvero la proposizione di azioni giudiziarie da parte di cittadini, associazioni e Ong per contestare la grave insufficienza delle risposte politiche e amministrative alla crisi climatica e per ottenere una tutela effettiva dei diritti fondamentali minacciati dai cambiamenti climatici, come il diritto alla vita, alla salute e a un ambiente salubre.
Il fenomeno, nato in ambito anglosassone, si è progressivamente diffuso anche in Europa e in Italia. A livello europeo, il contenzioso più celebre è il caso Urgenda nei Paesi Bassi, in cui la Corte Suprema olandese, a fronte di una causa promossa da una fondazione, ha condannato lo Stato a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 25% rispetto ai livelli del 1990.
Questo precedente ha ispirato numerose altre azioni in Europa. In Italia, il caso più noto è quello denominato Giudizio Universale, promosso da un ampio fronte di associazioni e cittadini contro lo Stato italiano, accusato di non aver adottato misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico e di aver violato obblighi costituzionali e internazionali.
Le questioni processuali: legittimazione, giurisdizione e tipicità dell’azione
Uno dei nodi centrali del contenzioso climatico riguarda la legittimazione ad agire, cioè la possibilità per associazioni e cittadini di rivolgersi al giudice per la tutela di interessi collettivi o diffusi.
In Italia, la giurisprudenza è tradizionalmente restrittiva su questo punto, richiedendo la titolarità di una posizione giuridica soggettiva e un interesse concreto e attuale. Un problema speculare è quello relativo all’azione specifica da promuovere.
Infatti, non esistendo un’azione tipizzata per questo tipo di contenziosi, come strumento di tutela finora è stato invocato il rimedio della responsabilità civile. Tuttavia, i tribunali chiamati a pronunciarsi sul punto hanno stabilito che il diritto a vivere in un ambiente salubre non può essere protetto con il rimedio della responsabilità civile, che invece presuppone una tutela di tipo individuale, distinta da quella della collettività.
Nel caso Giudizio Universale, il Tribunale di Roma ha dunque dichiarato inammissibile la domanda proposta, ritenendo che la questione climatica rientri nella sfera delle scelte politiche e che non sia configurabile un diritto soggettivo alla tutela del clima azionabile in sede civile.
Il giudice ha inoltre sottolineato che eventuali carenze dell’azione amministrativa (vale a dire la mancata adozione di misure volte a ridurre le emissioni derivanti da fonti precise ed individuale) possono essere censurate solo davanti al giudice amministrativo e non invece davanti a quello civile.
La recente apertura della Corte di Cassazione
Una parziale risposta a queste criticità è arrivata dalla Corte di Cassazione. Nel 2023 alcuni cittadini e associazioni ambientaliste hanno avviato una causa davanti al Tribunale di Roma per l’accertamento di dell’inottemperanza all’obbligo di riduzione delle emissioni e la condanna dell’ente intimato all’adozione di misure correttive.
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale che negava la possibilità al giudice italiano di pronunciarsi su casi in materia di cambiamento climatico, il Tribunale di Roma ha rimesso la questione di giurisdizione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La Corte si è pronunciata nel mese di luglio 2025, riconoscendo la possibilità del giudice italiano di statuire su questioni di “responsabilità da cambiamento climatico“.
Infatti, secondo la Corte, la normativa nazionale e comunitaria fornirebbe al giudice italiano la base giuridica per potersi validamente pronunciare su questioni climatiche ed eventualmente condannare lo Stato o altro ente responsabile di emissioni non conformi agli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale.
Non solo: quando gli effetti del cambiamento climatico si verificano in Italia e le decisioni che hanno contribuito al cambiamento climatico sono state prese in Italia da enti o istituzioni italiane, il giudice italiano sarebbe sempre dotato di giurisdizione.
La Corte ha dunque rimesso la causa al Tribunale di Roma che ora potrà pronunciarsi nel merito della vicenda e dovrà valutare se e come accogliere la domanda delle associazioni ambientaliste e dei cittadini.
Sotto questo profilo, il Tribunale potrà fare affidamento su un importante precedente: nel 2024, nelle more del giudizio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la legittimità della pretesa di un’associazione di diritto svizzero e alcuni cittadini volta a far valere omissioni delle autorità statali nel settore dei cambiamenti climatici, riconoscendo la complementarità dell’intervento giudiziario rispetto al potere legislativo ed esecutivo nella tutela dei diritti fondamentali (per esempio,la tutela della salute e a vivere in un ambiente salubre).
Conclusioni
Il contenzioso climatico rappresenta oggi una delle frontiere più avanzate della tutela dei diritti fondamentali e della democrazia partecipativa.
Se da un lato i giudici sono chiamati a colmare i vuoti lasciati dalla politica, dall’altro la recente apertura della Corte di Cassazione segna un cambio di passo importante: la giurisdizione italiana può e deve essere protagonista nella difesa del clima e della salute collettiva.
» Leggi tutti gli articoli di Codice verde (norme&sostenibilità)
 Stefania Casini: avvocato specializzato in diritto ambientale, energia e infrastrutture. Appassionata a temi legati alla sostenibilità e all'economia circolare. Spera un giorno di poter viaggiare con una macchina del tempo, alimentata da fonti rinnovabili | Linkedin
Stefania Casini: avvocato specializzato in diritto ambientale, energia e infrastrutture. Appassionata a temi legati alla sostenibilità e all'economia circolare. Spera un giorno di poter viaggiare con una macchina del tempo, alimentata da fonti rinnovabili | LinkedinL'articolo Giustizia climatica in tribunale: la sfida dei cittadini contro l’inerzia dello stato è stato pubblicato su GreenPlanner Magazine.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0



















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/paypal-promuove-pagamenti-stablecoin.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/07/hype-logo-1.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/approfitta-2-percento-interesse-trade-republic-nessun-vincolo-solo-vantaggi.jpg)
























































































.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)