Il dibattito pubblico è morto, cancellato da intellettuali influencer in cerca di cuoricini


Cito a memoria e non ricordo la fonte, ma l’ho letto pochi giorni fa e continuo a pensarci: epoche serie richiedono gente seria. Cui aggiungerei: e noi non ne abbiamo di disponibile. Poi certo, ci si può chiedere se siano i tempi che fanno le persone o le persone che fanno i tempi, ma resta la domanda: come usciamo da questo casino? Non importa neanche sappiate quale dei molti casini correnti ho in mente: qualunque sia quello che vi affligge, non mi pare si vedano vie d’uscita.
Una delle due conversazioni più interessanti che ho ascoltato in questi giorni è quella tra Ta-Nehisi Coates – probabilmente più importante intellettuale nero americano di questo secolo, in Italia lo pubblica Einaudi – e Ezra Klein, che in questo momento è il più famoso giornalista del New York Times giacché i lettori non vogliono leggere e lui fa un comodo podcast.
Li ho ascoltati perché ho visto molti commenti di americani di sinistra indignati che Coates – che incarna l’ortodossia di sinistra di questo momento storico – si fosse prestato a parlare con Klein, che fa (come Coates) quel che dovrebbe fare un intellettuale, cioè sforzarsi di pensare invece di accomodarsi sui trending topic, ed è perciò considerato una strega da bruciare (a proposito di streghe e di caccia, l’altra conversazione interessante del momento è quella tra Woody Allen e Bari Weiss nel podcast di lei, “Honestly”).
Come spesso accade, i due parlavano proprio di quel tic che il commentatore di sinistra dimostra commentandoli, non riconoscendosi nella descrizione e dicendo che è uno scandalo che quei due si parlino, che Coates legittimi un interlocutore cui non va data corda, cui non va data visibilità (giorni fa ho visto un tizio della provincia italiana che spiegava che lui non avrebbe dato visibilità alla vedova di Charlie Kirk, cioè al video che decine di milioni di persone in tutto il mondo stavano guardando: a parole hanno tutti la sindrome dell’impostore, ma nei fatti si comportano come fossero davvero convinti d’influire sui destini del mondo).
Tutti, da sinistra e da destra, dicono che con quegli altri non si parla, dice Klein. Tutti pensano d’essere in una cold civil war, cioè dentro a una guerra civile che sia anche una guerra fredda, in una Berlino divisa a metà, in un paese in cui il tuo concittadino è tuo nemico ma la guerra non è dichiarata. E tutti pensano che i cattivi siano gli altri.
Se noi siamo i buoni, chiede in sostanza Klein, perché perdiamo? Evoca la domanda che faceva Will McAvoy, il protagonista repubblicano di “Newsroom” (era tredici anni fa: sembrano trecento): «Se i liberal sono questi cazzo di geni, come diavolo è che perdono sempre?». Anche su questo Coates e Klein avrebbero un’osservazione, ed è quella sul fatto che tendiamo a pensare che ogni rivolgimento sia significativo e definitivo, che chi perde o vince in quel momento perda o vinca «sempre».
Nella loro conversazione citano gli editoriali sulla vittoria di Barack Obama e la definitiva conclusione del suprematismo bianco da cui non si sarebbe mai più tornati indietro, e quelli uguali e contrari del 2005, dopo la seconda vittoria di George W. Bush, secondo i quali i democratici avevano perso il polso del paese e non avrebbero vinto mai più.
Per me ci sono degli assoluti da cui non si può prescindere, delle indicibilità inaccettabili, degli interlocutori che non possono essere tali, dice Coates. E Klein dice benissimo, ma il confine che mettiamo, rispetto a cosa è accettabile e cosa no, a che serve, se metà del paese lo supera? Che senso ha?
È ovviamente una domanda senza risposta, perché l’unica risposta è quella che dà Sean Penn, sempre sul New York Times ma non ho visto altrettanta agitazione social, non perché sia un attore e quindi il suo parere conti meno ma perché è in forma scritta e bisognava prendersi l’incomodo di leggere l’intervista. È la risposta a due domande su Charlie Kirk.
«Questo caso di violenza mi sembra diverso. Diverso dagli attentati ai politici. Diverso dall’uccisione del dirigente assicurativo. Diverso anche dall’attentato al presidente. Charlie Kirk, mi sembra, anche se non lo seguivo molto ed è di certo una di quelle persone con cui sono in disaccordo su praticamente tutto, credeva davvero in tutto ciò su cui non eravamo d’accordo. Non mi sembrava che fosse un piazzista. Credo che ci serva quel genere di persona, che ci serva quel dibattito. Che dobbiamo scazzarci e trovare un compromesso. […] Sto dicendo che se qualcuno crede che la vita inizi al concepimento, e tu non riesci a capacitartene, sei stupido. Se non sei in grado di tollerare che in quel concetto qualcuno creda profondamente quanto io posso credere che sia diritto della donna decidere. Sono tutte opinioni valide. […] L’assassino che ha sparato all’assicuratore? Non sono un fan delle assicurazioni sanitarie, ma, santiddio, la tua dialettica è ridotta così?».
C’è un punto in comune tra le due risposte di Penn e la conversazione di Klein e Coates, e sono proprio Klein e Coates a esplicitarlo: gli intellettuali e i politici fanno due lavori diversi, e hanno responsabilità diverse in tutto, anche nell’uso del linguaggio. Quando Klein gli fa vedere il discorso in cui Hillary Clinton definì una parte degli elettori di Donald Trump «bunch of deplorables», Coates dice che anche lui li giudica così, ma che lei non avrebbe dovuto dirlo.
Coates, il cui più famoso articolo (del 2014) è un saggio breve che s’intitola “The case for reparations” e argomenta che i neri americani abbiano diritto a essere risarciti per la riduzione in schiavitù dei loro avi, dice che non sarebbe stato politicamente furbo, per Barack Obama, chiedere risarcimenti per la popolazione nera. C’è una qualità, in questa conversazione, che non si trova spesso nei dibattiti di questo tempo sbandato: a parlare sono due adulti. Per forza il commentatore social non li capisce: quelli parlano di storia e di politica, e lui capisce solo la tifoseria, piccino.
Ta-Nehisi Coates compie cinquant’anni oggi, ma mica bastano i compleanni: Stefano Massini li ha compiuti una settimana fa, e qualche giorno prima ha fatto uno dei monologhi più imbarazzanti che abbia sentito nella mia vita di spettatrice televisiva, e includo quelli di certi comici romani e persino le tiktoker che accendono il telefono prima di mettersi a piangere. Ha elencato un po’ di cose dette da Charlie Kirk, ma dette nella fantasia di Massini: pensa lo spettatore televisivo che Kirk non l’ha mai visto né sentito, che non ha idea dei codici lessicali americani, di cosa sia plausibile e di cosa no, e se lo sente riassumere da Massini come uno che diceva di Michelle Obama «quella negra».
Certo, la gente vota la destra perché spera che le levi di mezzo un po’ d’immigrazione molesta o almeno le faccia portare il cane in aereo, però anche il fatto che la sinistra abbia intellettuali il cui orecchio per il dialogo si avvicina più ai Broncoviz che al realismo, ecco, diciamo che non aiuta.
Possiamo parlare con qualcuno che non la pensa come noi per uno scopo diverso dal mettere la clip su internet con la didascalia «Lo asfalta»?, si chiedono Klein e Coates che non hanno mai visto un talk show italiano ma tutto il mondo è evidentemente «un bell’applauso». Io li guardo e mi chiedo se davvero a nessuno che non siano due americani teoricamente lontanissimi da noi venga in mente che non è sensato definirsi tramite ciò che non siamo e coloro con cui non parliamo. E che gli intellettuali e i politici hanno ruoli diversi, sì, ma se i secondi pensano che il loro ruolo sia se sono di sinistra andare al gay pride e se sono di destra andare a Casa Pound, ecco, allora forse i politici hanno limiti persino più grossi di quelli degli intellettuali. Dipenderà dal fatto che sono in cerca degli stessi cuoricini?
L'articolo Il dibattito pubblico è morto, cancellato da intellettuali influencer in cerca di cuoricini proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















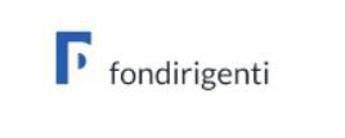




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































