Il nuovo reato di violenza sessuale è un monumento mostruoso al populismo penale


L’unanime e contagioso entusiasmo con cui il Parlamento italiano sta rapidamente edificando un diritto penale speciale per i reati di genere ha in Italia svariati precedenti nelle legislazioni d’emergenza, a partire da quelle antiterrorismo e antimafia. Il principio è sostanzialmente il medesimo: di fronte a reati particolarmente odiosi e riprovevoli, la manomissione dei principi di civiltà giuridica, in particolare sul diritto di difesa e sulla formazione della prova, è considerata un sacrificio accettabile e, tutto sommato, imposta da un interesse morale superiore a quello della garanzia processuale di un accusato di crimini nefandi.
Alcuni mesi fa il Senato ha approvato all’unanimità una legge per autonomizzare il reato di femminicidio – nuovo articolo 577-bis del codice penale – per farne esemplarmente l’unico omicidio volontario punito con la pena dell’ergastolo, a prescindere dalla sussistenza di circostanze aggravanti.
Per farne un reato autonomo, il legislatore non è stato solo obbligato a superare la neutralità sessuale delle fattispecie incriminatrici, ma ha anche dovuto paradossalmente isolare il femminicidio dal novero dei crimini d’odio per motivi fondati sull’identità sessuale o di genere della vittima, col risultato che oggi per il codice penale italiano l’omicidio d’impeto «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione» di una donna è considerato più grave di quello di una persona trans o di un uomo.
Se di questa cervellotica e demagogica innovazione, che sarà certo confermata dalla Camera – ci si può aspettare che non faccia troppi danni – (nei femminicidi si arrivava normalmente all’ergastolo anche prima, attraverso l’aggravante dei motivi futili e abietti o delle sevizie e della crudeltà), ci si devono attendere invece conseguenze rovinose dalla riqualificazione del reato di violenza sessuale, approvata il diciannove novembre all’unanimità dalla Camera dei deputati e attesa a breve al vaglio del Senato, dove sarà certamente confermata con una votazione altrettanto plebiscitaria.
Il nuovo art. 609-bis del codice penale stabilisce che «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
È ovviamente pacifico che qualunque atto sessuale subito e non voluto sia un atto di violenza e che non si possa dedurre dall’assenza di reazione della vittima – che può essere dettata dall’imbarazzo, dalla vergogna, dalla paura… – l’esistenza di un consenso implicito, anche se non dichiarato. In questa direzione si era già tempo incamminata la giurisprudenza di merito e di legittimità. Non è invece né ovvio né pacifico confezionare una norma ambigua e indeterminata e trascinarne un’interpretazione letteralmente eversiva, in cui alla presunzione di verità dell’accusa corrisponde la presunzione di colpevolezza dell’accusato.
Di quali atti sessuali si sta parlando? Da baci e abbracci di un imbarazzante approccio sgradito allo stupro violento? Tutti compresi in un’unica categoria, tutti valutati di uguale offensività, tutti inquadrati nella medesima cornice edittale di pena (minimo sei anni)? E se non si può desumere l’assenza di coercizione solo dalla mancata reazione della vittima, a dimostrare la coercizione, cioè l’assenza di consenso in un atto sessuale imposto o estorto con la violenza e la minaccia, è sufficiente la testimonianza della vittima?
La consigliera di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini ha spiegato così quella che ha definito «una svolta storica» e «il cuore di una legge che da oggi apre una strada nuova nei processi per stupro». Non è la vittima a dover testimoniare la propria resistenza all’aggressore, per dimostrare di essere stata violentata, ma è l’imputato a dover dare la prova di avere avuto il consenso della vittima. È un cambiamento culturale e giuridico a trecentosessanta gradi… Con la nuova legge, ecco il cambiamento, sarà chiaro che saranno i denunciati a dover dare prova, come si dice volgarmente, che «lei ci stava».
L’unanime consenso del Parlamento alla svolta storica nei processi per violenza sessuale segna il ritorno in grande stile della giustizia inquisitoriale: limitazione del diritto di difesa, assenza del contraddittorio, inversione dell’onere della prova, cristallizzata nell’atto di accusa.
I reati di violenza sessuale, quando non ne emergano con evidenza tracce dal corpo della vittima, sono sempre molto difficili da dimostrare, perché l’accertamento del fatto, per le stesse circostanze in cui si verifica, esclude molto spesso la reperibilità di elementi e testimonianze diverse da quelle fornite dalle parti processuali.
Nondimeno, i processi che si concludono con una condanna – sono significativamente superiori a quelli per altri delitti e questo lascia già oggi supporre una tendenza a considerare la testimonianza della vittima una prova più che sufficiente, a meno che altri elementi non ne compromettano l’intrinseca credibilità.
Adesso si arriva a stabilire per legge che il reato di violenza sessuale è di per sé provato dalla denuncia e che tutto quello che il processo consente all’accusato è la probatio diabolica della propria innocenza. Secoli di civiltà giuridica sacrificati all’idolo mostruoso del populismo penale, per cui solo la condanna soddisfa e l’assoluzione invece oltraggia il desiderio di giustizia.
L'articolo Il nuovo reato di violenza sessuale è un monumento mostruoso al populismo penale proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0









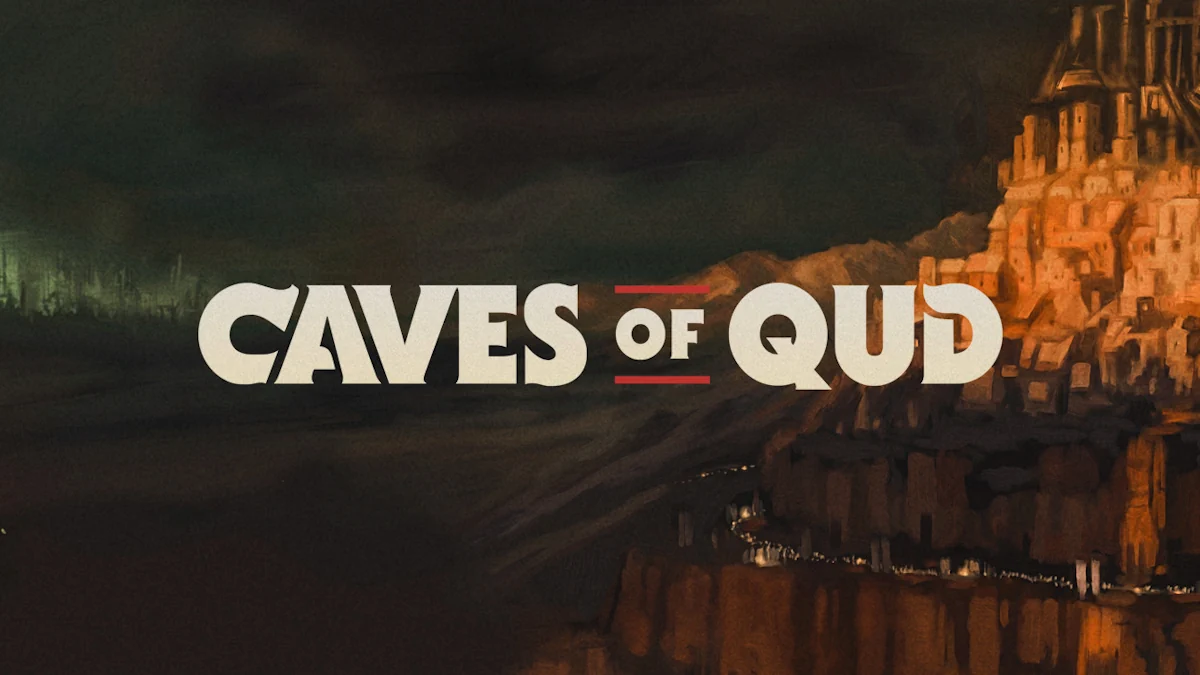































%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)























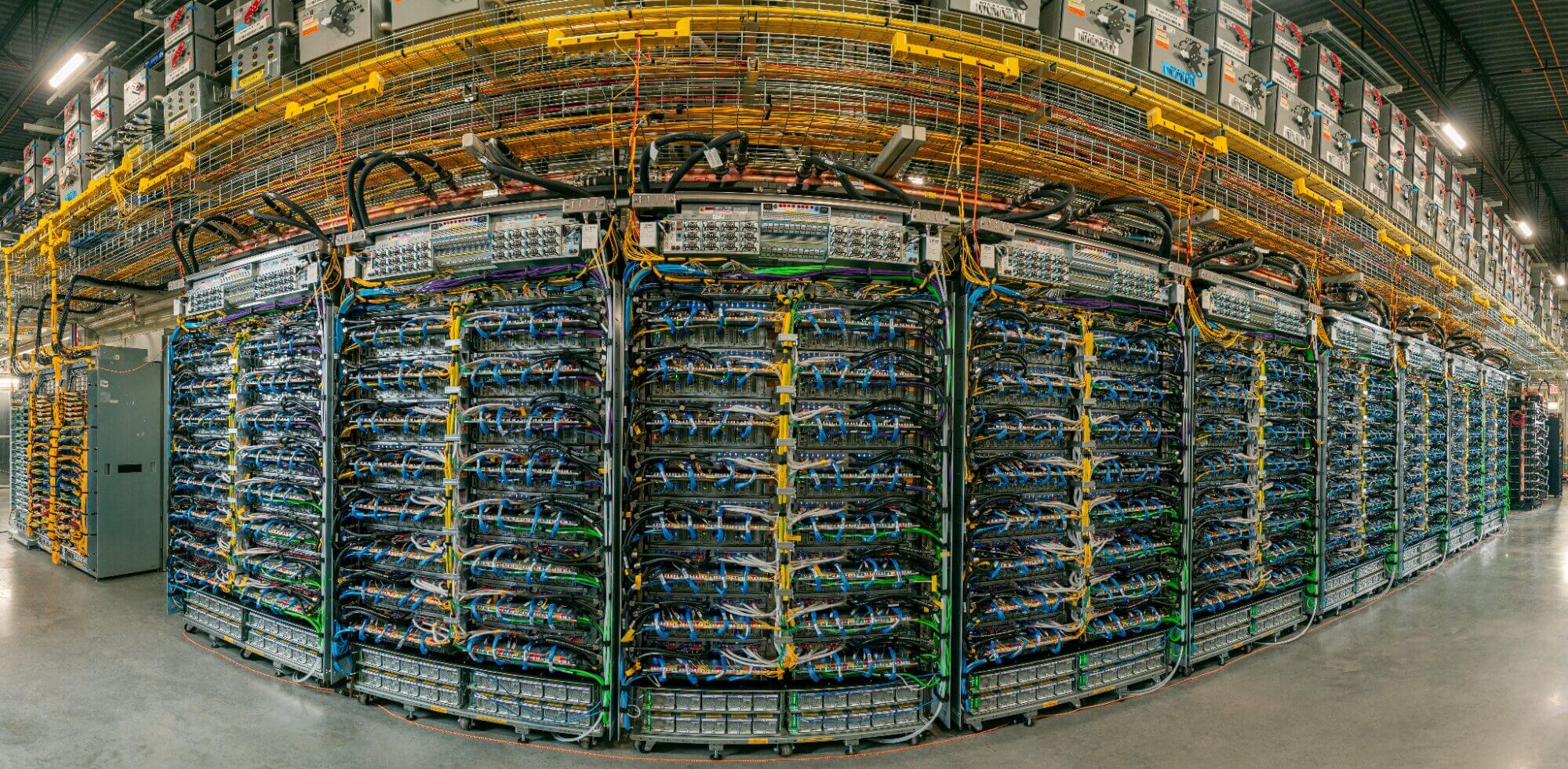


















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/persone-guardano-titolo-indici.jpg)



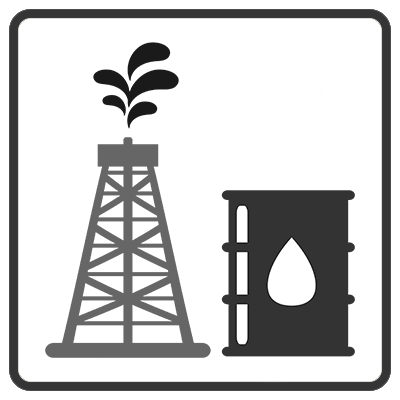

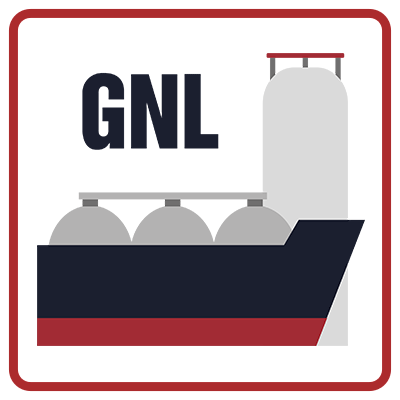



































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































