La scrittura è disciplina, ma anche un immenso spazio di libertà


Parigi. Dicembre 2018
La prima regola cui attenersi, se si vuole scrivere un romanzo, è saper dire di no. No, non vengo a bere qualcosa. No, non posso badare al nipotino che sta male. No, non sono disponibile per una colazione, un’intervista, una passeggiata o un cinema.
Bisogna dire di no tante di quelle volte che le proposte si fanno sempre più rare, il telefono non squilla più e, con gran disappunto, si finisce per ricevere mail di sola pubblicità. Bisogna saper dire di no, passando così per misantropi, arroganti e malati di solitudine. Erigere intorno a sé un muro di dinieghi contro cui andranno a infrangersi le tante sollecitazioni. Questo mi aveva detto l’editore quando ho cominciato a scrivere romanzi. Questo continuavo a leggere in tutti i saggi sulla letteratura, da Roth a Stevenson, passando per Hemingway che riassumeva la cosa in maniera molto semplice e banale: “I peggiori nemici di uno scrittore sono il telefono e la gente che lo va a trovare.” E aggiungeva che, una volta acquisita la disciplina, una volta che la letteratura è diventata il centro, il cuore e l’unico orizzonte della vita, la solitudine viene da sé. “Gli amici muoiono o svaniscono, stanchi forse, dei nostri tanti dinieghi.”
Da qualche mese, mi sono imposta di farlo anche io. Creare le condizioni indispensabili al mio isolamento. La mattina, dopo aver accompagnato i figli a scuola, salgo nel mio studio e ne esco solo la sera. Stacco il telefono, mi siedo davanti al tavolo di lavoro o mi sdraio sul divano. Alla fine ho sempre freddo e col passare delle ore, m’infilo prima un maglione, poi un altro, e finisco per avvolgermi in una coperta. Il mio studio misura tre metri per quattro. Sul muro di destra, una finestra si affaccia su un cortiletto da cui risalgono gli odori di un ristorante. Odori di detersivo e di lenticchie al lardo. Di fronte a me, una lunga asse di legno funge da tavolo da lavoro. Gli scaffali sono ingombri di libri di storia e ritagli di giornale. Sul muro di sinistra, ho attaccato dei post-it di vari colori. Ogni colore corrisponde a un anno preciso. Rosa per il 1953, giallo per il 1954, verde per il 1955. Su quei pezzetti di carta ho annotato il nome di un personaggio, un’idea scenica. Mathilde al cinema. Aisha nel campo di cotogni. Un giorno che ero particolarmente ispirata, ho buttato giù la cronologia del romanzo a cui sto lavorando e che non ha ancora trovato un titolo. Racconta la storia di una famiglia nella cittadina di Meknès, tra il 1945 l’indipendenza del regno. Sul pavimento è sciorinata una carta della città, risalente al 1952. Vi si vedono con chiarezza le frontiere tra la città araba, il mellah ebraico e il centro città europeo.
Oggi non è una giornata positiva. Son seduta su questa sedia da ore e i miei personaggi non mi parlano. Non viene fuori niente. Non una parola o un’immagine, o l’attacco di una musica che mi spinga a mettere in fila le frasi sulla pagina. Da stamattina, ho fumato troppo, ho perso tempo navigando per siti Internet, ho fatto una siesta ma non ne è venuto fuori niente. Ho scritto un capitolo che ho poi cancellato. Ripenso alla storia che mi ha raccontato un amico. Non so se è vera, ma a me è piaciuta molto. Pare che durante la stesura di Anna Karenina, Lev Tolstoj abbia attraversato una profonda crisi creativa. Per settimane, non aveva scritto una sola riga. L’editore, che gli aveva anticipato una somma notevole per l’epoca, preoccupato del ritardo nella consegna del manoscritto e spinto a reagire dal silenzio del maestro che non rispondeva alle sue lettere, decise di prendere il treno e chiedere lumi di persona. Al suo arrivo a Jasnaja Poljana, il romanziere lo ricevette e quando l’editore gli chiese a che punto fosse con il lavoro, Tolstoj rispose: “Anna Karenina se n’è andata. Aspetto che torni.”
Lungi da me l’idea di paragonare la mia persona al genio russo o uno dei miei romanzi ai suoi capolavori. Ma sono ossessionata da questa frase: “Anna Karenina se n’è andata.” A volte ho anch’io l’impressione che i miei personaggi fuggano via da me, che siano andati a vivere un’altra vita e che decideranno di tornare solo quando parrà a loro. Sono assolutamente indifferenti alla mia angoscia, alle mie preghiere, indifferenti persino all’amore che gli porto. Se ne sono andati e devo aspettare che tornino. Quando invece sono lì con me, i giorni passano senza che io me ne accorga. Mormoro, scrivo il più rapidamente possibile, tanta è la paura che le mani siano meno rapide del filo dei pensieri. A quel punto, come un funambolo che commette l’errore di guardare in basso, sono terrorizzata all’idea che qualcosa finisca per interrompere la mia concentrazione. Quando i personaggi sono lì con me, tutta la mia vita gira intorno a cui mi muovo, come un’esaltata, alla fine di una lunga e serena giornata di lavoro. Vivo in uno spazio a parte. La reclusione mi sembra la condizione necessaria perché la Vita possa accadere. Come se, allontanandomi dal frastuono del mondo, proteggendomi, potesse finalmente emergerne un altro, di mondo: “C’era una volta”. In quello spazio chiuso evado, fuggo la commedia umana, mi immergo nella densa schiuma delle cose. Non mi chiudo al mondo, anzi, lo percepisco in maniera più intensa che mai.
La scrittura è disciplina. È rinuncia alla felicità e alle gioie di tutti i giorni. È uno stato da cui è inutile tentare di guarire o cercare di trovar consolazione. Al contrario, bisogna coltivare i propri dolori come i tecnici di laboratorio coltivano batteri nei contenitori di vetro. Bisogna riaprire cicatrici, rimestare ricordi, ravvivare umiliazioni e lacrime del passato. Per scrivere bisogna negarsi agli altri, negare la propria presenza, la propria tenerezza, deludere amici e figli. In tale disciplina trovo insieme un motivo di soddisfazione, addirittura di felicità, e la causa della mia malinconia. L’intera mia vita è sottoposta a una serie di “devo”. Devo stare in silenzio. Devo concentrarmi. Devo rimanere seduta.
Devo resistere ai desideri. Scrivere significa porsi degli ostacoli, ma è proprio da lì che può nascere una sconfinata, vertiginosa libertà. Ricordo il momento in cui me ne sono resa conto per la prima volta. Era il dicembre del 2013, stavo scrivendo il mio primo romanzo, Nel giardino dell’orco. All’epoca vivevo a Parigi, in Boulevard Rochechouart. Avevo un bambino piccolo e per scrivere dovevo approfittare dei momenti in cui era all’asilo. Ero seduta al tavolo da pranzo, di fronte al computer, e ho pensato: “Adesso puoi dire davvero tutto ciò che vuoi. Proprio tu, la brava bambina che ha imparato a comportarsi bene, a trattenersi, puoi dire la tua verità. Non sei obbligata a compiacere nessuno. Non aver timore di ferire gli altri. Scrivi tutto ciò che vuoi.” In questo immenso spazio di libertà, cade la maschera sociale. Si può essere un altro, non si è più definiti da un genere, da una classe sociale, da una religione o da una nazionalità. Scrivere significa scoprire la libertà di inventare se stessi e il mondo.
Certo, le giornate penose come quella di oggi sono tante, e a volte si susseguono generando un profondo senso di sconforto. Ma uno scrittore si comporta un po’ come un oppiomane e come qualunque vittima di dipendenza: dimentica gli effetti collaterali, la nausea, le crisi d’astinenza, la solitudine, e ricorda soltanto i momenti di esaltazione. È pronto a tutto pur di rivivere quell’attimo culminante, il sublime istante in cui i personaggi cominciano a parlare attraverso di lui, in cui la vita prende a pulsare. Sono le cinque del pomeriggio ed è già buio. Non ho acceso la lampada da tavolo e il mio studio è immerso nell’oscurità.
Comincio a credere che in quelle tenebre possa accadere qualcosa, un guizzo d’entusiasmo all’ultimo momento, un’ispirazione folgorante. Succede, a volte, che nel buio le allucinazioni e i sogni si dipanino come liane. Apro il computer, rileggo una scena scritta il giorno prima. Parla di un pomeriggio che il mio personaggio trascorre al cinema. Chissà cosa davano al Cinema Empire di Meknès nel 1953? Mi immergo nelle ricerche. Su Internet trovo delle immagini d’archivio commoventi che mando subito a mia madre. Comincio a scrivere. Mi torna in mente quel che raccontava mia nonna della maschera marocchina, alta e brusca, che strappava le sigarette di bocca agli spettatori. Sto per attaccare un nuovo capitolo quando la sveglia del telefonino si mette a squillare. Ho un appuntamento di lì a mezz’ora. Un appuntamento cui non ho saputo dire di no. Alina, l’editrice che devo incontrare, è una persona molto convincente. È una donna entusiasta che vuole propormi qualcosa. Comincio a pensare di mandarle un messaggio falso e bugiardo. Potrei usare i miei figli come scusa, dire che sono malata, che ho perso un treno, che mia madre ha bisogno di me. Invece infilo il cappotto, faccio scivolare il computer nella borsa ed esco dalla mia tana.

L'articolo La scrittura è disciplina, ma anche un immenso spazio di libertà proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































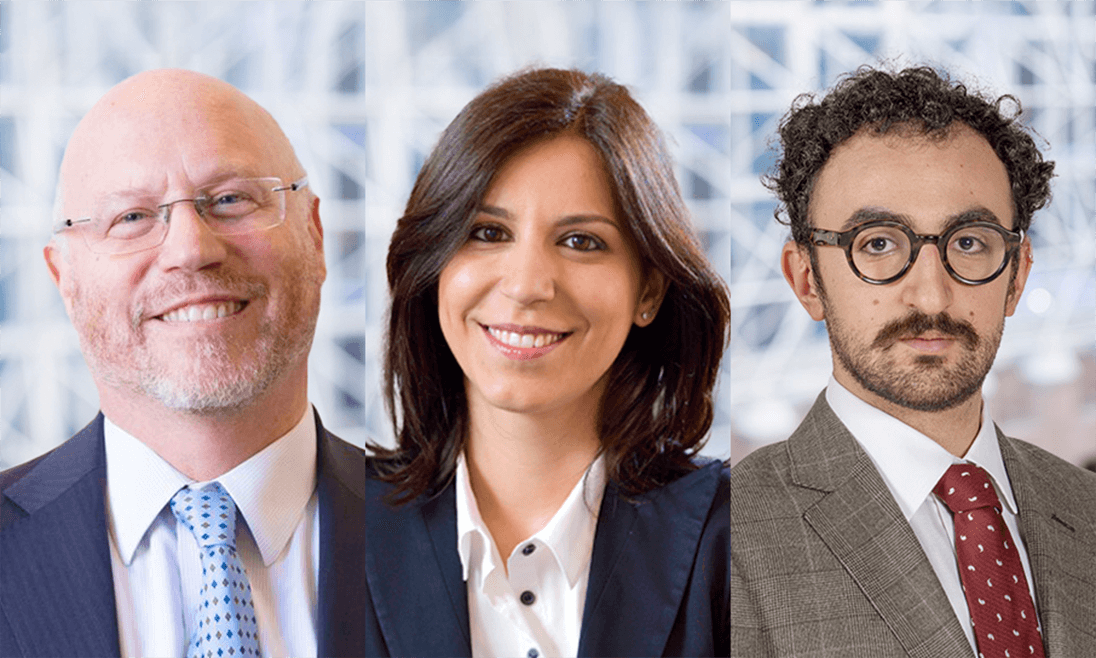


















































































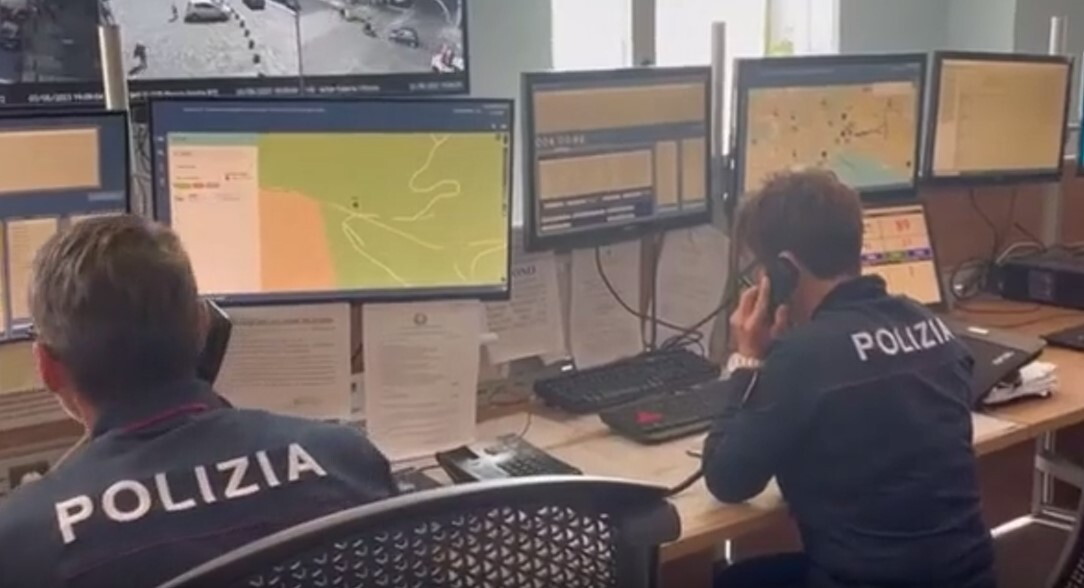
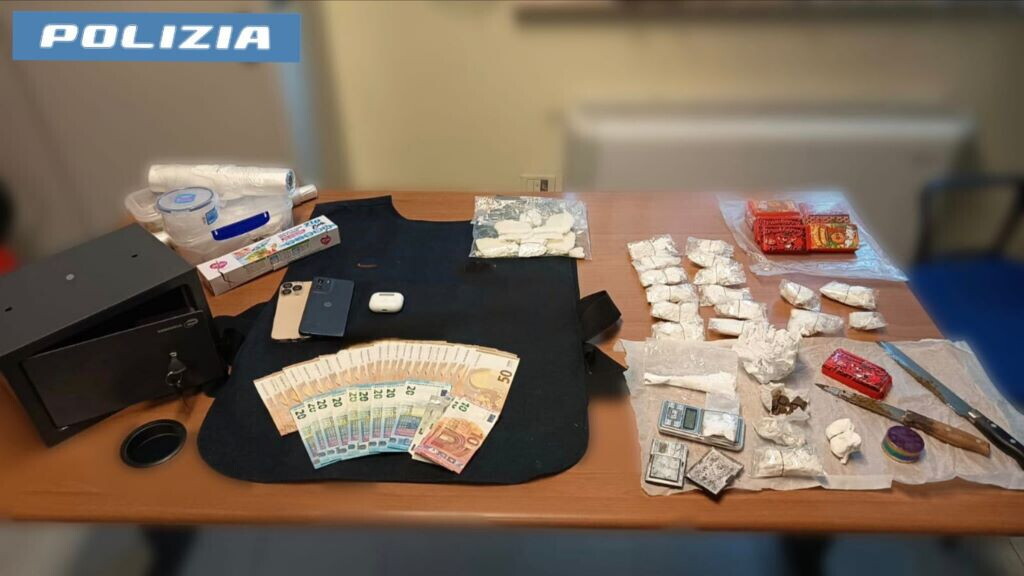
































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































