L’Europa finalmente spende miliardi per la difesa, ma deve imparare a usarli bene


Per la prima volta in decenni l’Europa non discute più se spendere per la difesa, ma come. Ed è già qualcosa. Il 2024 è stato l’anno di una svolta storica: trecentoquarantatré miliardi di euro investiti nel settore, un record assoluto per l’Unione, pari all’1,9 per cento del Pil complessivo. Nel 2025 la cifra salirà a trecentottantuno miliardi. Sono numeri che collocano l’Europa al secondo posto nel mondo per spesa militare, dietro soltanto agli Stati Uniti, e che superano di una volta e mezzo i bilanci della Cina e di tre volte quelli della Russia. Ma la vera sfida non è la quantità, bensì l’efficacia: trasformare la ricchezza del continente in capacità militare reale.
Come spiega un interessante approfondimento di Foreign Affairs, non è sufficiente aumentare i bilanci. Washington ha spinto gli alleati Nato a puntare a una soglia del cinque per cento del Pil, di cui il 3,5 per cento da destinare a hardware e sistemi essenziali; ma la motivazione più forte deve venire dall’interno: l’Europa deve rafforzarsi per se stessa, non solo per rispondere alle pressioni americane. E soprattutto deve farlo costruendo un’autonomia industriale e tecnologica, senza affidarsi a fornitori esterni che impongono tempi di consegna fino a sette anni, come accade per i sistemi Patriot.
Il punto debole sottolinea Foreign Affairs, è la frammentazione. L’Europa dispone di sei volte i sistemi d’arma principali degli Stati Uniti, ma li produce in modo dispersivo, con aziende nazionali che raramente collaborano oltre confine. Così anche i grandi gruppi come Thales, Leonardo o Rheinmetall appaiono modesti rispetto ai colossi americani e cinesi. Spendere di più senza coordinarsi significherebbe ripetere gli errori del passato.
L’Europa è la più grande riserva di risparmio al mondo, con trentanove trilioni di dollari in attivi privati, più del triplo degli Stati Uniti, ma queste risorse restano ferme in depositi e conti bancari, frenate da un mercato dei capitali frammentato. Negli Stati Uniti il settantacinque per cento dei finanziamenti alle imprese passa dai mercati e solo il venticinque per cento dai prestiti bancari; in Europa il rapporto è invertito, penalizzando le aziende e soprattutto le startup della difesa.
Il settore del venture capital europeo, sei volte più piccolo di quello americano, rende difficile lo sviluppo di imprese innovative che pure sarebbero decisive, come dimostrato dal ruolo dei droni nella guerra in Ucraina. In parallelo pesa un ostacolo culturale: nel 2021 il quattordici per cento degli asset gestiti professionalmente in Europa era soggetto a restrizioni sugli investimenti in armamenti, contro meno dell’uno per cento negli Stati Uniti. La Banca europea per gli investimenti, con un bilancio da seicentoquaranta miliardi di dollari, ha escluso per due decenni i progetti militari e solo di recente ha aperto a programmi dual use, continuando però a vietare il finanziamento diretto ad armi e munizioni.
Sempre secondo Foreign Affairs, per invertire la rotta servono due mosse. La prima è la creazione di un’Unione del risparmio e degli investimenti, proposta già nel 2015 e rilanciata dai rapporti Draghi e Letta: un mercato unico dei capitali che elimini barriere e consenta al risparmio europeo di fluire verso progetti strategici. La seconda è l’emissione di un grande bond europeo per la difesa, sul modello dei fondi salva-euro del 2012 e del Recovery Fund post-pandemico. Mario Draghi ha stimato in ottocento miliardi di euro (novecentocinquanta miliardi di dollari) la cifra necessaria: uno strumento del genere permetterebbe di raccogliere rapidamente capitali, con garanzie di credito altissime e tassi di interesse sostenibili.
La fotografia più aggiornata arriva dal rapporto dell’Agenzia europea per la difesa, che documenta la portata della svolta. Nel 2024 la spesa per investimenti – cioè equipaggiamenti e ricerca e sviluppo – ha toccato i centosei miliardi di euro, pari al trentuno per cento del totale. Di questi, tredici miliardi sono stati destinati a ricerca e sviluppo, con un aumento del venti per cento sull’anno precedente. Gli acquisti di nuovi sistemi sono cresciuti del trentanove per cento.
Quasi tutti i Paesi hanno contribuito: venticinque su ventisette hanno aumentato i propri bilanci militari e sedici hanno registrato incrementi superiori al dieci per cento rispetto al 2023. Germania, Polonia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi sono stati tra i più dinamici. In prima linea la Polonia, con una spesa vicina al quattro per cento del Pil, seguita da Estonia, Lettonia e Lituania che hanno superato il tre per cento. Solo Portogallo e Irlanda hanno ridotto i bilanci.
«L’Europa sta spendendo cifre record per la difesa per tenere al sicuro i nostri cittadini, e non ci fermeremo qui», ha dichiarato l’alto rappresentante Kaja Kallas. «La difesa oggi non è un lusso, ma un elemento fondamentale per la protezione dei nostri cittadini. Questa deve essere l’era della difesa europea».
La spesa da sola non basta. L’Europa ha più carri armati e veicoli da combattimento degli Stati Uniti, ma meno caccia e soprattutto minor capacità tecnologica dei suoi alleati e avversari. Senza consolidare industrie, mercati e regole comuni, i miliardi rischiano di restare numeri su un bilancio. La sfida vera è trasformarli in potenza reale.
L'articolo L’Europa finalmente spende miliardi per la difesa, ma deve imparare a usarli bene proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















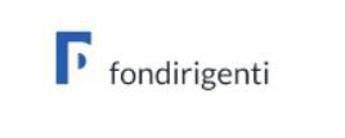




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































