Lo sciopero generale per la Flottilla e il rischio del corteo politico permanente


È molto probabile che, alla fine di questo articolo, le due tifoserie rimarranno ciascuna sulle proprie posizioni. Da un lato chi considera lo sciopero generale il minimo indispensabile per fermare l’occupazione israeliana a Gaza e pensa che ogni mezzo sia necessario in una guerra fatta di immagini e di retorica, oltre che di armi. Dall’altro chi lo liquida come una messa in scena: nessun ostaggio tornerà libero per effetto di un corteo a Milano e Netanyahu non ritirerà i carri armati perché a Roma si fermano autobus e metro.
Ma lo sciopero generale ha ancora senso quando viene proclamato per grandi cause politiche e non per questioni contrattuali? È il caso dell’astensione dal lavoro indetta dalla Cgil con Usb, Cub e Cobas a sostegno della Sumud Flotilla, la missione internazionale che ha tentato senza successo di forzare il blocco navale di Israele su Gaza.
Maurizio Landini ha scelto di rompere con la vecchia logica della “triplice” (la storica unità tra Cgil, Cisl e Uil) e di spostare la Cgil su un terreno più politico, alleandosi con i sindacati di base: realtà più piccole e radicali, nate in contrapposizione ai confederali, che fanno del conflitto permanente la loro cifra e considerano lo sciopero una pratica ordinaria.
Cisl e Uil, invece, non hanno aderito. Non per disinteresse verso Gaza, ma perché hanno imboccato una strada diversa: puntare sulla trattativa, sui rinnovi contrattuali e sulle misure negoziabili con governo e imprese. Per loro lo sciopero generale su temi internazionali rischia di essere un gesto simbolico che non porta risultati ai lavoratori. La loro linea è quella della contrattazione: meno piazze ideologiche, più tavoli per aumenti in busta paga o fondi per la sanità.
«Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme», ha commentato ironicamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una battuta che intercetta il senso comune della maggioranza silenziosa e riassume il problema: lo sciopero non ha più una controparte definita. Funzionava quando fermava la fabbrica e costringeva il padrone a trattare. Oggi la fabbrica è delocalizzata, il padrone un fondo anonimo, e la protesta parla al governo o all’opinione pubblica. Non è più conflitto economico, ma manifestazione politica.
Negli anni Settanta le lotte contro la guerra in Vietnam camminavano a fianco delle battaglie per i contratti e per lo Statuto dei lavoratori. Oggi la frattura è netta. Gaza riempie le piazze, mentre i rinnovi contrattuali dei metalmeccanici o i salari fermi nella scuola e nella sanità non muovono la stessa mobilitazione. La saldatura fra cause internazionali e diritti sociali si è spezzata e il sindacato rischia di trasformarsi in movimento politico permanente.
C’è chi parla di inflazione dello sciopero: a furia di proclamarlo perde di valore anche come minaccia. Non a caso i nuovi alleati di Landini hanno rilanciato lo slogan «blocchiamo tutto», che prescinde dai luoghi di lavoro e si affida alla forza dei cortei. Ma i lavoratori avrebbero bisogno proprio del contrario: rinnovi contrattuali, aumenti salariali, più sicurezza, risposte alle crisi industriali come l’ex Ilva o i grandi poli produttivi venduti senza piani industriali.
Lo sciopero per Gaza arriva anche a ridosso del piano in venti punti annunciato da Donald Trump: restituzione degli ostaggi, smilitarizzazione e ricostruzione sotto un Consiglio di pace internazionale. Netanyahu lo ha accolto con cautela. In questo quadro l’astensione dal lavoro manda un segnale confuso: si protesta contro Israele, contro il piano stesso, o per accelerarne l’attuazione? L’ambiguità rischia di annacquare la forza della mobilitazione.
E pesa pure il tempismo. Lo sciopero è stato proclamato subito dopo il fermo delle imbarcazioni della Flotilla e l’arresto di cittadini occidentali. È stato quel gesto a far scendere subito i giovani nelle piazze, più velocemente delle notizie quotidiane dei massacri a Gaza. A volte la mobilitazione scatta più facilmente quando la vittima ci somiglia.
Lo sciopero resta un diritto costituzionale e un simbolo di libertà, ma da solo non basta più. In un mercato del lavoro frammentato, fatto di precari, partite Iva e freelance senza contratto né luogo da bloccare, servono altri strumenti. Uno studio del 2019 pubblicato su Kaleidoscope Journal spiega come lo sciopero tradizionale perda forza in società del lavoro frammentate come quella italiana e propone di affiancare all’astensione dal lavoro strumenti diversi: campagne digitali che colpiscano l’immagine pubblica delle aziende o dei governi, pressioni coordinate su consumi e forniture, alleanze territoriali che mettano insieme lavoratori dipendenti, precari, studenti e cittadini. Non più soltanto il blocco della fabbrica, che presuppone un luogo unitario e un padrone identificabile, ma forme di conflitto diffuse e trasversali, capaci di incidere anche laddove non esistono sindacati riconosciuti o catene di montaggio da fermare.
L'articolo Lo sciopero generale per la Flottilla e il rischio del corteo politico permanente proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0










































%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)



















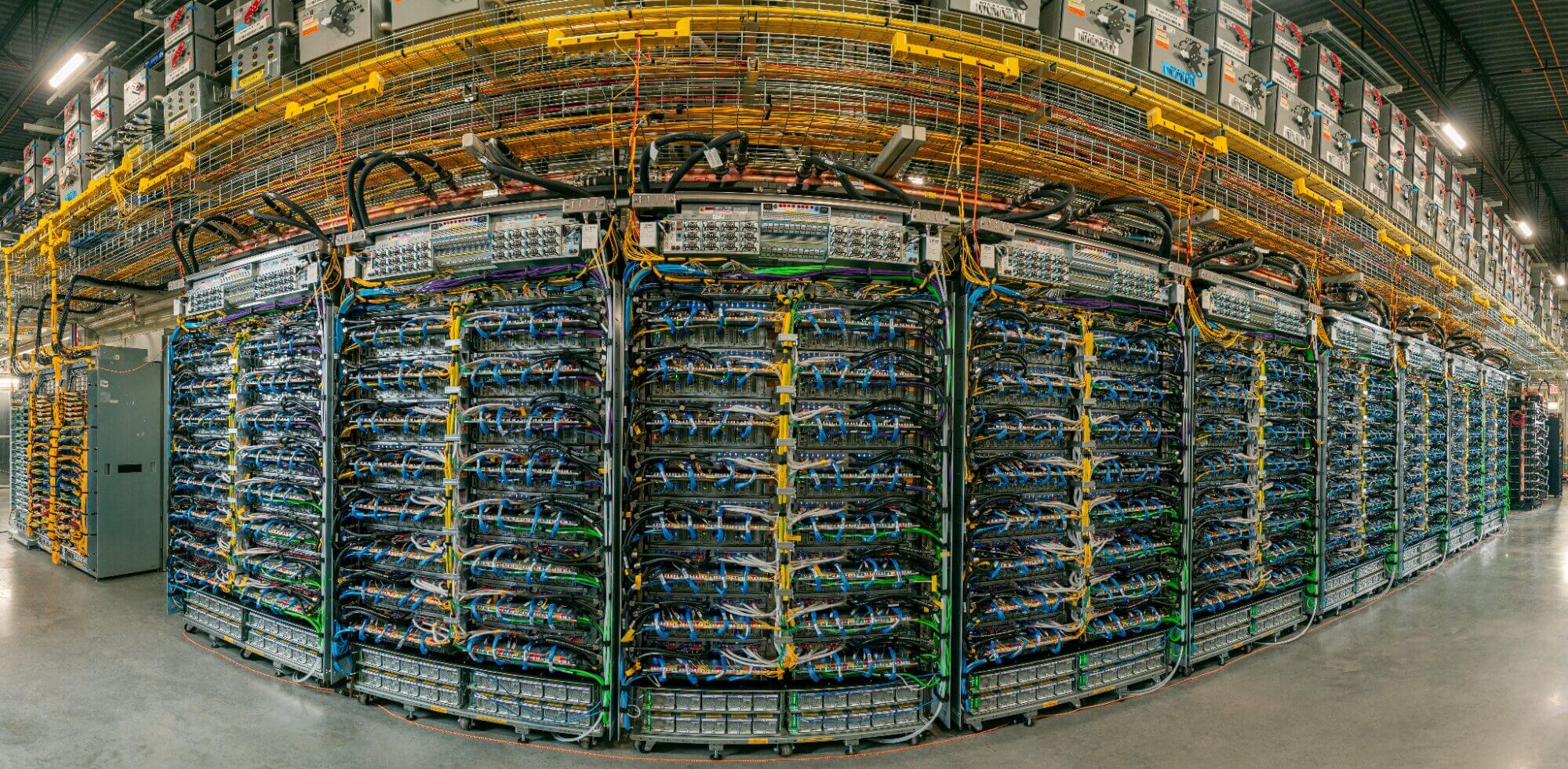






















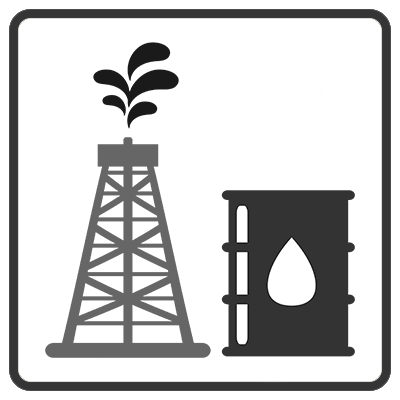

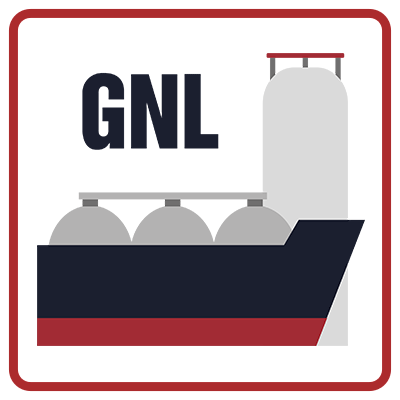



































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































