Open Innovation nell’industria: come Stellantis, Eni e Leonardo collaborano con le startup

OPEN INNOVATION
Open Innovation nell’industria: come Stellantis, Eni e Leonardo collaborano con le startup
Le grandi aziende italiane aprono le porte alle startup per accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie. Con PoC rapidi, fondi dedicati e acceleratori verticali, l’open innovation diventa la via per trasformare idee esterne in soluzioni industriali pronte per il mercato.

Open Innovation nell’Industria significa contaminazione tra mondi che fino a pochi anni fa correvano su binari paralleli: grandi gruppi industriali da un lato e giovani imprese tecnologiche – startup o PMI innovative – dall’altro. Oggi quel confine è più sottile, e per ottime ragioni. Tre esempi su tutti: Stellantis, Eni e Leonardo hanno aperto i propri processi a startup e centri di ricerca, portando innovazioni rapide là dove le strutture interne non riuscirebbero a muoversi con la stessa velocità. È un cambiamento culturale prima ancora che organizzativo, nato dall’urgenza di tenere il passo con mercati in cui la velocità di esecuzione conta quanto la solidità delle infrastrutture industriali.
Questa trasformazione si traduce in strumenti concreti. Stellantis ha creato un fondo corporate da 300 milioni di euro, dedicato a investimenti in tecnologie per batterie di nuova generazione, software-defined vehicle e guida autonoma, e ha già firmato oltre cento contratti di partnership con startup. Leonardo, con la Business Innovation Factory lanciata insieme a LVenture, ha impostato un modello che non si limita alla selezione di idee ma punta a integrare progetti pilota nei processi mission-critical dell’aerospazio e della difesa. Eni, con Joule e il venture builder Eniverse, lavora invece su un doppio binario: accelerare imprese orientate alla transizione energetica e trasformare asset proprietari in nuove aziende capaci di andare sul mercato in tempi rapidi.
Perché le corporate puntano sull’open innovation
L’apertura all’ecosistema startup, per le corporate, non è una moda passeggera. Le grandi imprese hanno capito che affidarsi unicamente alla R&D interna non è più sufficiente. Le transizioni in corso, come la digitalizzazione dei processi, il passaggio verso un utilizzo dell’energia più sostenibile e una maggiore attenzione alla cybersicurezza, richiedono velocità e flessibilità. Le startup sono portatrici di queste caratteristiche: sperimentazione rapida, riduzione del rischio tecnologico, capacità di agire in nicchie dove i colossi industriali non riescono a muoversi da soli…
I dati confermano che l’Open Innovation nell’Industria non è un fenomeno marginale. Nel 2024, secondo il report State of CVC di CB Insights, i finanziamenti globali sostenuti dal corporate venture capital hanno raggiunto 65,9 miliardi di dollari, con un aumento del venti per cento rispetto all’anno precedente. A livello europeo, diversi studi segnalano una crescita della presenza delle corporate nei deal di venture capital, pur in un contesto generale più selettivo: la quota si colloca nell’ordine di alcuni miliardi di dollari e riflette un trend di progressiva maturazione dell’ecosistema.
In Italia l’Osservatorio Open Innovation e CVC 2024 del Politecnico di Milano e Assolombarda rileva che il 33,2% delle startup e PMI innovative è partecipato da soci corporate e che queste imprese generano circa il 47,2% dei ricavi complessivi del comparto. Il fenomeno si riflette anche a livello di mercato: in Italia, il valore dei servizi di open innovation ha sfiorato i 750 milioni di euro nel 2023, con l’intelligenza artificiale come uno dei principali driver di crescita.
L’open innovation diventa quindi uno strumento di competitività, capace di unire la rapidità delle startup alla solidità delle infrastrutture industriali. Stellantis, Eni e Leonardo rappresentano tre declinazioni di questa strategia, che si concretizzano in modelli diversi ma convergono su un punto: trasformare l’innovazione esterna in valore misurabile.
Leonardo: accelerare l’aerospazio e la difesa grazie alle startup
Nel settore della difesa e dell’aerospazio, Leonardo ha strutturato la Business Innovation Factory insieme a LVenture. Nel 2023 la call si è focalizzata sui verticali Simulation & Gamification e Networking & Cybersecurity, con un programma di accelerazione della durata di sei mesi e la possibilità di sviluppare Proof of Concept (PoC) con le business unit del gruppo. La prima edizione ha visto Leonardo investire in capitale in due startup. In questa seconda edizione Leonardo prevede di selezionare fino a dieci imprese, portandole a un Demo Day finale con potenziali investimenti e collaborazioni industriali.
Il modello è chiaro: i progetti pilota sono costruiti insieme alle business unit e rispondono a esigenze operative già identificate. Il ciclo dura alcuni mesi e prevede mentorship interna per ridurre i tempi di adozione. In questo modo si evita che i PoC rimangano confinati a esercizi dimostrativi e si accelera l’ingresso nei processi industriali.
Collaborare per crescere
Le collaborazioni concrete mostrano come l’open innovation di Leonardo non resti sulla carta. Nel 2024 la divisione Leonardo Automation ha avviato una partnership con la bolognese EyeCan, una startup specializzata nello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per object tracking, anomaly detection e classificazione. L’iniziativa, nata dall’esperienza del progetto Fast AI 4 Object Tracking promosso attraverso il programma Open Italy, punta a integrare queste soluzioni nelle linee di movimentazione materiali, con l’obiettivo di migliorare qualità e produttività.
Accanto a casi già formalizzati, l’ecosistema di BIF ha portato all’attenzione anche realtà come Difly, startup emiliana che utilizza droni e sensori avanzati per l’analisi dei dati in scenari complessi. Difly è stata selezionata nelle call di Leonardo e citata in diversi articoli come esempio di applicazioni potenziali in ambiti dual use, dalla mappatura ambientale fino alla rilevazione di ordigni inesplosi. Pur non essendoci ancora comunicazioni ufficiali su progetti congiunti a livello operativo, il suo percorso mostra come la collaborazione tra corporate e startup possa aprire a soluzioni con ricadute industriali e social
Stellantis: il venture fund che guida la mobilità del futuro
Per Stellantis, l’open innovation ha preso forma concreta con la creazione di Stellantis Ventures, un fondo da 300 milioni di euro lanciato nel 2022. L’iniziativa, inserita nel piano Dare Forward 2030, è stata pensata per sostenere startup e PMI innovative che operano in settori chiave per la trasformazione dell’automotive: elettrificazione, software-defined vehicle, connettività e guida autonoma. L’idea non è solo finanziare imprese emergenti, ma legare le innovazioni direttamente alle direttrici industriali del gruppo, con potenziali applicazioni molto interessanti per i modelli di futura applicazione e per le piattaforme globali.
Startup e tecnologie al centro: dalle batterie agli ioni di sodio ai LiDAR
Nei primi dodici mesi di attività, il fondo ha già investito circa un terzo del capitale in dieci startup e in un fondo esterno dedicato alla mobilità. Tra i casi più rappresentativi figura Tiamat, realtà francese che sviluppa batterie agli ioni di sodio, tecnologia considerata un’alternativa al litio per costi più bassi e minori criticità di approvvigionamento. Nel 2024 Stellantis Ventures ha annunciato anche l’ingresso in SteerLight, una startup impegnata nello sviluppo di un LiDAR compatto e a basso costo, destinato a potenziare i sistemi di assistenza avanzata alla guida (ADAS). Questi esempi mostrano come il venture arm del gruppo stia orientando le proprie scelte verso tecnologie in grado di incidere direttamente sulla competitività industriale, riducendo tempi di sviluppo e rischi di filiera.
Eni: accelerazione e venture building per la transizione energetica
Con Joule, la Scuola per l’impresa, Eni ha costruito un programma di accelerazione che sostiene ogni anno decine di startup orientate alla transizione energetica. Nel 2023 il portafoglio contava oltre 130 realtà seguite, con un fatturato cumulato in crescita da 11 milioni di euro nel 2021 a 17 milioni nel 2023 e stime oltre i 20 milioni per il 2024. La particolarità di Joule è l’approccio equity free: le startup non cedono quote di capitale ma ricevono supporto imprenditoriale, tecnico e finanziario.
Centrale, parlando di Open Innovation, è anche la valutazione ESG, sviluppata in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, ELIS e Open Impact, che consente di misurare concretamente sostenibilità e ricadute sociali delle diverse iniziative.
Eniverse, il venture builder interno al 100%
Accanto a Joule Eni ha lanciato Eniverse Ventures, il corporate venture builder controllato al 100% dal gruppo. La sua missione è quella di trasformare asset tecnologici sviluppati internamente in nuove imprese capaci di raggiungere il mercato in meno di tre anni. È il caso di Enivibes, spin-off dedicato al monitoraggio delle pipeline tramite algoritmi acustici, che ha già dimostrato come una tecnologia nata nei laboratori Eni possa diventare una società autonoma con clienti globali. Con Eniverse, Eni sperimenta un modello inside-out che completa l’approccio open-in di Joule, rafforzando il legame tra ricerca interna e nuove imprese.
Open-in e Open-out: due facce dell’open innovation
Quando si parla di open innovation si distinguono due approcci complementari. L’open-in indica l’ingresso di innovazione dall’esterno: la corporate apre i propri processi a startup, università o centri di ricerca, integrando nuove tecnologie attraverso call, programmi di accelerazione o corporate venture capital.
L’open-out, invece, avviene quando è l’impresa stessa a portare sul mercato asset interni, creando spin-off, concedendo licenze o avviando joint venture. Nel caso di Eni, Joule rappresenta l’approccio open-in, con cui l’azienda assorbe innovazione da giovani imprese orientate alla transizione energetica, mentre Eniverse incarna l’open-out, trasformando tecnologie sviluppate nei laboratori interni in nuove società pronte a competere a livello globale.
Open Italy, il ponte con l’ecosistema startup
La strategia di open innovation di Eni si estende anche attraverso programmi esterni come Open Italy di ELIS, che coinvolgono grandi aziende in cicli di innovazione con startup. Le call prevedono una fase di scouting e selezione per progetti sperimentali che vengono realizzati con pochi mesi di prototipazione (12 settimane). Alla fine di questo periodo, è possibile che le aziende adottino le soluzioni testate. Nel 2025, il programma è presentato esplicitamente come un’iniziativa che finanzia PoC in contesti reali con possibilità di scaling.
Si parla di oltre 370 candidature nel 2021, specifiche per Eni: il contesto testimonia un interesse elevato da parte dell’ecosistema startup verso l’Open Italy e il coinvolgimento multi-corporate nelle edizioni recenti.
Quali modelli di open innovation usano le corporate
Le esperienze delle tre aziende, come abbiamo raccontato, mostrano che non esiste un modello unico. La collaborazione senza equity, come nel caso dei PoC retribuiti di Open Italy o delle partnership di Leonardo, consente di testare rapidamente soluzioni con minore complessità. L’ingresso nel capitale, invece, come avviene con Stellantis Ventures, diventa utile quando la corporate intende influenzare la roadmap della startup o garantirsi un accesso preferenziale alla tecnologia.
Gli acceleratori rappresentano un filtro di deal flow e una piattaforma di validazione, mentre i venture arm investono con una logica strategica di medio-lungo periodo. Il successo non si misura solo con il ROI finanziario. Conta la rapidità con cui un proof of concept si traduce in una adozione stabile, la percentuale di progetti che riescono a scalare e l’impatto in termini di risparmi o ricavi aggiuntivi. È altrettanto importante valutare quante delle tecnologie prioritarie siano coperte da partnership o investimenti, e quanto si riduca il time-to-market nelle linee strategiche. Infine, un portafoglio maturo si distingue per la capacità di generare proprietà intellettuale, spin-off e nuovi prodotti: sono questi i veri indicatori di un’innovazione dirompente.
L’Italia si confronta con l’Europa
Il dibattito sui modelli di open innovation non riguarda solo le singole imprese, ma anche le differenze tra i principali ecosistemi europei. In Germania, ad esempio, la tradizione industriale ha favorito l’affermazione di corporate venture capital strutturati: realtà come BMW i Ventures e Bosch Ventures operano con logiche vicine a quelle dei fondi indipendenti, con un forte focus sul ritorno finanziario ma con la capacità di trasferire rapidamente le tecnologie nei processi produttivi.
In Francia, invece, si è affermato un modello più orientato all’accelerazione: programmi come Orange Fab o Airbus BizLab hanno costruito piattaforme che mettono in contatto startup e corporate in cicli rapidi di sperimentazione, spesso con la possibilità di scale-up internazionale. In Spagna, dove l’ecosistema è più giovane, prevale il modello della collaborazione diretta, con PoC retribuiti e partnership commerciali sviluppate caso per caso.
L’Italia si colloca in una posizione intermedia: rispetto ai grandi hub europei è un mercato più recente, ma le corporate hanno adottato modelli ibridi, combinando accelerazione, venture clienting e investimenti diretti. Queste aziende stanno mostrando come sia possibile ridurre il divario “de facto”. Leonardo, Stellantis ed Eni, con approcci diversi ma complementari, rappresentano i casi più evidenti di questa evoluzione, dimostrando che anche nel nostro Paese l’open innovation può assumere forme scalabili e sistemiche. Una mappatura del Politecnico di Milano mostra come in Italia prevalgano approcci ibridi, che combinano percorsi di accelerazione con strumenti di investimento diretto.
Le sfide e le opportunità dell’open innovation industriale
Integrare startup e grandi imprese significa affrontare ostacoli culturali e organizzativi. Le prime si muovono con la logica della sperimentazione rapida, le seconde con quella della compliance e della governance multilivello. Per superare il divario servono contratti standardizzati, clausole chiare sulla proprietà intellettuale e processi di procurement snelli. È un lavoro di traduzione reciproca che richiede team ibridi, capaci di parlare sia il linguaggio dell’agilità sia quello della scalabilità.
La gestione della proprietà intellettuale (IP) e dei dati è un altro nodo delicato. Nei settori regolati occorre definire fin dall’inizio licenze, diritti d’uso e clausole di co-sviluppo, evitando sia la dispersione del know-how sia il rischio di lock-in. Anche la sicurezza informatica è ormai imprescindibile: senza standard robusti non è possibile portare un progetto da prototipo a produzione.
Il passaggio più difficile resta quello dal pilota alla scala globale. Molti PoC si arenano perché mancano budget dedicati o perché non vengono integrati nei sistemi gestionali e produttivi. È qui che programmi come la Business Innovation Factory, i Venture Awards di Stellantis e i PoC time-boxed di Open Italy mostrano la loro utilità: legano i progetti a esigenze operative già individuate e riducono il rischio di dispersione. La vera differenza, però, la fa la sponsorship del management, che deve assumersi la responsabilità di portare le soluzioni in deployment industriale.
Superare la fase pilota
Leonardo, Stellantis ed Eni dimostrano che l’open innovation è ormai un processo strutturato per ridurre tempi di sviluppo e generare valore industriale. Un fenomeno che si inserisce in un mercato nazionale in forte crescita, stimato in circa 750 milioni di euro. Il contesto europeo, pur in un mercato Venture Capital più selettivo, conferma la resilienza degli investimenti corporate, che hanno superato i sette miliardi di dollari nel 2024.
In Italia un terzo delle startup innovative ha già tra i soci una grande azienda e quasi metà dei ricavi complessivi del settore proviene da realtà partecipate da corporate. Sono segnali di un ecosistema che sta crescendo in maturità. La sfida ora è trasformare la fase pilota in deployment globale, con governance più snelle, processi di industrializzazione chiari e metriche condivise. In gioco non c’è solo il ritorno economico immediato, ma la capacità del sistema industriale italiano di restare competitivo di fronte a transizioni epocali come l’elettrificazione della mobilità, la decarbonizzazione dell’energia e la digitalizzazione della difesa.
L'articolo Open Innovation nell’industria: come Stellantis, Eni e Leonardo collaborano con le startup proviene da Innovation Post.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















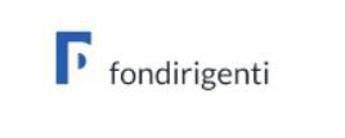




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)







































-U46057518800XMz-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)















